|
LE PRETESE DELLA SCIENZA
Scienza moderna e schiavismo
La scienza moderna, pur essendosi posta, sin dal suo nascere, contro i dormi
della teologia cristiana, specie nella variante cattolico-romana, non sarebbe
potuta nascere che in un luogo geografico caratterizzato da una confessione del
genere.
Molte altre civiltà pre-cristiane hanno svolto profondi studi scientifici, ma
nessuna aveva mai considerato l'uomo così al di sopra della natura. L'universo
veniva sì studiato, ma per essere meglio contemplato, o per decifrarne le leggi
in rapporto ai fenomeni naturali, o in rapporto allo scorrere del tempo, o per
meglio capirne le leggi in funzione di un'attività economica, quella agricola,
strettamente legata ai ritmi della natura.
Con Galilei invece, ma già con Copernico, l'universo viene studiato con
l'intenzione di ricavarne delle leggi da utilizzare per dominare la natura
secondo gli interessi di una classe particolare: la borghesia.
Già l'ebraismo, col Genesi, aveva posto l'uomo al di sopra della natura, in
quanto lo faceva dominatore degli altri animali. E tuttavia l'ebraismo poneva
limiti ben precisi a tale dominio: l'albero della conoscenza del bene e del male
non andava toccato. Cioè l'uomo doveva sì sentirsi padrone della terra, ma non
come un "dio onnipotente". Tant'è che nell'ebraismo il dominio dell'uomo sulla
natura è stato considerato più che altro in maniera metaforica, o comunque come
una possibilità reale unicamente nell'ambito dell'Eden. La perdita volontaria
dell'innocenza aveva tolto all'uomo il diritto di dominare la natura.
L'uomo ha cominciato ad avvertire la natura come un nemico da sconfiggere o
un oggetto da sfruttare a partire dal momento in cui ha abbandonato le leggi del
comunismo primitivo e ha cominciato ad abbracciare quelle della prima civiltà
individualistica: lo schiavismo.
Da allora la distruzione della natura non ha conosciuto soste. Se ci si pensa
bene, lo schiavismo non è che una forma di capitalismo ante litteram.
Capitalizzare schiavi o quattrini non fa molta differenza, in quanto il
disprezzo nei confronti della natura e degli stessi uomini è uguale.
La differenza è piuttosto di tipo quantitativo: non c'è limite all'accumulo
di denaro. Viceversa, il limite all'accumulo di schiavi era determinato
dall'estensione della terra posseduta o dal numero di schiavi che si potevano
acquistare sul mercato (frutto di conquiste belliche). Oggi, i moderni cavalieri
che combattono popolazioni nemiche per renderle schiave, hanno i capitali al
posto degli eserciti, i computer al posto delle armi, anche se non disdegnano di
usare, all'occorrenza, tutta la forza militare possibile.
E' molto probabile che sia stata proprio la consapevolezza dei limiti dello
sfruttamento schiavistico, troppo soggetto alla materialità o fisicità dei
rapporti umani, a indurre gli antichi schiavisti a non perfezionare il livello
tecnologico dei loro mezzi produttivi, e a indurre i moderni schiavisti a fare
esattamente l'opposto.
Gli schiavisti romani o pre-cristiani non conoscevano a fondo il valore della
ricchezza astratta. In fondo non erano molto diversi dagli schiavisti spagnoli e
portoghesi che utilizzavano i negri per ottenere oro, argento, diamanti ecc.
Ma lo schiavismo sotto il capitalismo è tutt'altra cosa, ed esso non poteva
nascere che in un luogo ove dominasse il culto di un dio astratto,
spiritualizzato al massimo.
Le pretese della scienza moderna
La scienza pretende di dimostrare in laboratorio delle verità che in fin dei
conti non sono più "vere" di quelle in cui per consuetudine si era creduto nel
corso di intere generazioni. O comunque la scienza odierna spesso chiede di
credere in verità che all'uomo comune, alla fin fine, poco importano.
Se l'uomo, anche solo per un momento, pensasse a quali disastrose verità la
scienza chiede di credere quasi ciecamente, forse da tempo avrebbe smesso di
tenere nei confronti della scienza un atteggiamento analogo a quello tenuto nei
secoli scorsi nei confronti della religione.
La scienza occidentale non trasmette affatto un sapere "scientifico", cioè
neutrale, oggettivo. Questa scienza è nata in società divise in classi e da
sempre essa si pone al servizio delle classi dominanti.
Paradossalmente proprio questo legame di scienza e capitale ha indotto i
critici del capitalismo a distinguere tra "scienza borghese" e "scienza
proletaria". E' pazzesco pensare a una suddivisione "di classe" della scienza,
che è nata proprio con una pretesa di oggettività non più attribuibile alla
religione. Eppure sono i fatti che lo dimostrano.
La scienza "borghese" ha poco di "scientifico"; spesso la propria
scientificità viene impiegata nei modi peggiori: armamenti sempre più costosi o
sofisticati, manipolazioni genetiche, distruzione dell'ambiente ecc. Ecco perché
è giusto sostenere che può essere definito "scientifico" soltanto ciò che è
conforme alle leggi della natura.
E' dunque difficile valutare se sia più pericolosa l'idolatria verso la
scienza o quella verso l'ideologia politica. Certamente le idee politiche
possono, in determinate condizioni di crisi sociale e istituzionale, muovere
milioni di persone, più di quanto sicuramente non possa fare la scienza.
Però è anche vero che mentre le ideologie politiche mutano di continuo, le
conquiste scientifiche invece permangono nel tempo e i loro effetti si fanno
sentire su molte generazioni.
Le idee politiche riguardano la libertà, che è soggetta alla facoltà
dell'arbitrio, anche se risulta sommamente coinvolgente; le idee scientifiche
riguardano invece la fredda ragione, che si preoccupa di trovare una certa
stabilità, salvo poi sentirsi particolarmente imbarazzata quando un esponente
della stessa scienza sferra delle critiche durissime a quelli che fino a ieri
venivano considerati dei veri e propri dogmi scientifici. Aveva ragione Hegel
quando sosteneva che la scienza si preoccupa della coerenza dell'intelletto, che
è schematica per sua natura, mentre la filosofia si preoccupa della coerenza
della ragione, che è invece flessibile in quanto basata sui principi della
dialettica.
Tuttavia, a volte la scienza produce dei mutamenti così radicali nello stile
di vita che solo con una rivoluzione politica si può pensate di rimuoverli.
Certo è che se uno sviluppo scientifico è strettamente connesso a una
ideologia politica, il superamento radicale di quest'ultima non può non
comportare una revisione, più o meno radicale, anche delle conquiste
tecnico-scientifiche.
Una storia della scienza che non tenesse conto della storia delle idee
politiche finirebbe col dare dei giudizi immotivati sui regressi storici.
Purtroppo è difficile trovare un testo di storia ad uso scolastico che non
consideri il Medioevo un'epoca buia rispetto ai fasti dell'epoca greco-romana.
Pochissimi autori motivano quei "fasti" con lo sfruttamento sistematico degli
schiavi.
Quando c'è ricchezza spropositata, ci sono anche scienza e tecnologia
avanzate (si badi, "avanzate" non vuol dire "diffuse", poiché la scienza e la
tecnologia del mondo romano erano soprattutto patrimonio dei ceti più abbienti,
o comunque venivano utilizzate o a scopo bellico o a scopo propagandistico e
voluttuario).
In virtù di questo spreco di risorse (stiamo parlando della magnificenza dei
templi, dei teatri, delle terme ecc.), gli storici sostengono che il mondo
classico era migliore di quello feudale.
Così facendo, non si guarda la società nel suo complesso, ma solo una parte
di essa, che, come una sorta di "effetto alone", finisce col prevalere su tutto
il resto.
Esattamente come oggi, in cui gli economisti determinano la ricchezza di un
paese, ovvero il suo livello di benessere economico, sulla base degli indici del
Pil e non sulla base dell'effettiva diffusione del benessere vitale, che non è
solo economico ma anche e soprattutto sociale. Nel capitalismo gli indici
economici hanno completamente sostituito quelli sociali.
In realtà la vera ricchezza di una persona sta nei suoi sentimenti, nel modo
come li esprime, sta nelle sue idee di giustizia, di onestà, sta nella sua
capacità di riconoscere la verità delle cose. Questa forma di ricchezza non è
facilmente indicizzabile o rappresentabile in un'opera scientifica, meno che mai
con gli strumenti del capitale: spesso viene considerata dalla politica come un
elemento opzionale e, come tale, di scarsa rilevanza produttiva.
Eppure se c'è una cosa che aliena è proprio questo culto del denaro, poiché
il capitalista pone al di fuori di sé la realizzazione di se stesso, esattamente
come il feudatario di ieri, lo schiavista o il credente. Ognuno guarda al di
fuori di sé per riuscire ad essere se stesso: schiavi, capitali, terre, dio...
Mentre l'unica cosa che davvero conta è già interna a ogni essere umano e si
tratta soltanto di farla sviluppare: la coscienza.
L'evoluzione tecnologica in occidente
Qualunque forma di sviluppo economico in una società capitalistica è
strettamente legato non tanto a un miglioramento dei rapporti sociali, quanto
soprattutto a un'evoluzione della tecnologia.
Questa evoluzione può anche portare a un miglioramento dei rapporti sociali,
ma sotto il capitalismo ciò accade raramente.
Infatti, poiché l'evoluzione tecnologica in occidente è sempre connessa a
motivazioni di tipo economico (la prima delle quali è il profitto), si ha che,
dopo un certo periodo di tempo, un'evoluzione tecnologica troppo spinta porta a
un'ulteriore distruzione dei rapporti sociali. Cioè porta a nuove
contraddizioni, sempre più difficili da risolvere, per le quali, non avendo noi
in mente altri modelli sociali, si è costretti a investire in nuove ricerche di
tipo tecno-scientifico.
L'occidente guadagna enormemente con lo sviluppo tecno-scientifico, sia
perché è partito prima degli altri continenti, sia perché la scienza è parte
integrante del suo modo di rapportarsi alla realtà.
Naturalmente l'occidente ha una propria visione della scienza, che è
strettamente correlata alla tecnologia. E' scientifico solo ciò che è
tecnicamente dimostrabile. Questa visione della scienza oggi è assolutamente
dominante a livello mondiale.
La vera scienza occidentale è lo sperimentalismo da laboratorio.
La più grande applicazione tecnologica alla realtà sociale ed economica ha
appunto prodotto il capitalismo. E siccome il capitalismo domina su ogni altro
sistema sociale, se ne deduce che la scienza occidentale sia l'unica vera
scienza.
Sarebbe in realtà bastato rendersi conto che nessuna macchina è in grado di
eguagliare il lavoro umano. Una produzione in serie è mortificante, è
burocratica, poiché deve per forza supporre una standardizzazione del gusto, è
impersonale e deve sperare che l'interesse ad acquistare una determinata merce
duri il più possibile e aumenti di continuo sul piano quantitativo.
Il macchinismo è riuscito a imporsi grazie all'illusione della comodità:
poter avere delle cose nel più breve tempo possibile, a prezzi contenuti, per
fare cose in maniera più facile, più veloce, più sicura. Si è caduti nella
trappola, poiché i prezzi, da concorrenziali diventano monopolistici, e quando
la domanda è molto alta, salgono sempre più; le merci industriali non sono così
facili da usare: ci vuole esperienza, manutenzione, competenze specialistiche, e
poi non durano molto tempo, altrimenti l'impresa non fa profitti, e ogni merce
che si usa ha ricadute ambientali notevolissime.
Si è cercata la comodità quando proprio questa uccide la creatività, il gusto
della fatica. Abbiamo cercato la velocità di esecuzione quando proprio questa
non permette di assaporare il gusto della vita.
La sicurezza scientifica
La vera sicurezza ci è data dalle cose che si ripetono da millenni,
collaudate dalla natura. Là dove si pretende che la sicurezza dipenda
esclusivamente dalla scienza e dalla tecnica, inevitabilmente si va incontro a
inaspettate catastrofi.
L'uomo non può garantire una maggiore sicurezza di quella che può offrire la
natura, semplicemente perché siamo un prodotto derivato della natura, per quanto
in forma di autoconsapevolezza e non di semplice istinto, come negli
animali.
La pretesa sicurezza che noi ci siamo dati, a partire dalla rivoluzione
tecnico-scientifica, s'è rivelata effimera. Non solo perché di breve durata, ma
anche perché costantemente accompagnata da eventi altamente tragici, sia a
livello sociale (guerre, stermini di massa...), che a livello naturale
(desertificazioni, mutamenti climatici...).
Tutta la nostra avanzata tecnologia non si ha affatto resi più sicuri. Non
solo perché con essa produciamo strumenti di morte e distruzione, ma anche
perché qualunque pretesa di garantire sicurezza contro o a prescindere dalla
natura, si rivela prima o poi illusoria.
Di questi limiti strutturali spesso e volentieri approfitta la religione, che
in luogo di un "ritorno alla natura" preferisce parlare di un "ritorno a
dio".
Scienza e tecnologia
La scienza è una forma di conoscenza. Non è astratta come la filosofia, ma
implica un'applicazione pratica, determinando un collegamento con la
tecnologia.
Un'applicazione della filosofia può essere quella della politica, in maniera
molto naturale e consequenziale. Ma non si può parlare di applicazione naturale
della filosofia alla scienza, a meno che non s'intendano altre scienze astratte,
come p.es. la matematica, la geometria ecc.
Viceversa nell'epoca moderna, quando si parla di scienza astratta, s'intende
sempre qualcosa avente una pratica applicazione (p.es. la matematica applicata
al calcolo automatico o all'informatica).
Per noi occidentali la tecnologia è parte costitutiva della scienza, al punto
che facciamo fatica ad attribuire rilevanza scientifica a quelle forme di
pensiero che non possono avvalersi di dimostrazioni pratiche, concrete,
laboratoriali, e quindi riproducibili.
Il bisogno di darsi delle applicazioni pratiche per dimostrare la validità di
determinate conoscenze astratte (che poi diventano "scientifiche" quando appunto
trovano riscontri concretamente verificabili) è un bisogno primordiale, nato con
la nascita dell'uomo.
Tuttavia solo in epoca moderna la scienza ha avuto un impulso straordinario.
Ora qui dovremmo chiederci se questo nesso strutturale di scienza e tecnologia
poteva svolgersi in maniera diversa, rispetto a quanto è accaduto a partire
dall'epoca borghese, e se sì in che modo.
Noi non possiamo mettere in discussione che la conoscenza sia un diritto
dell'uomo, però non possiamo accettare che questo diritto venga usato contro
l'uomo stesso e l'ambiente in cui vive.
Il diritto alla conoscenza va gestito dal diritto a vivere un'esistenza
umana. E perché sia umana, l'esistenza deve basarsi sulla soddisfazione del
bisogno: bisogni collettivi, decisi dalla collettività.
Se il bisogno non viene gestito democraticamente, neppure lo sviluppo della
conoscenza sarà democratico. E la prima forma di democrazia del bisogno, quella
più elementare, primordiale, è l'esigenza di tutelare l'ambiente in cui si
vive.
Se non c'è rispetto della natura, del suo bisogno di esistere e di
riprodursi, non ci può essere rispetto del bisogno dell'uomo, poiché l'uomo,
senza natura, non esisterebbe neppure, non avrebbe "natura umana".
La natura umana è riproducibile solo naturalmente? Sino alla nascita
dell'ingegneria genetica, sì. Oggi scienza e tecnica sono in grado d'intervenire
anche artificialmente sul momento della riproduzione umana.
Tuttavia noi ancora non possiamo sapere quali conseguenze sul fisico e anche
sulla nostra psiche potranno generare queste riproduzioni artificiali. I
risultati sugli animali non sono stati esaltanti e anche quelli sulle piante
sono forieri di problemi più gravi di quelli per la soluzione dei quali s'era
voluto fare degli esperimenti azzardati.
La natura è maestra di vita, soprattutto in considerazione del fatto che non
è stato l'essere umano ad averla prodotta, ma il contrario. La natura ha
un'esperienza, collaudata nel tempo, infinitamente superiore a quella degli
esseri umani.
Qualunque modificazione che l'uomo compie nei confronti della natura, avrà
necessariamente delle conseguenze su lui stesso. |
Aggiornamento: 01/02/2012 |
Marx e
Kuhn: la struttura delle rivoluzioni scientifiche
Il paradigma dominante è in ogni tempo il paradigma della classe
dominante
1. Introduzione
Ci proponiamo, con questo lavoro, di sostenere che lo sviluppo della scienza
segue le stesse leggi che spiegano l’evoluzione della società e che a questo
assunto dovrebbero rifarsi i filosofi della scienza discutendo di rivoluzioni
scientifiche, paradigmi, scienza normale. Applicando le leggi dell’evoluzione
alla scienza è possibile anche fornire una più precisa e feconda concezione del
concetto di paradigma.
Come noto, lo sviluppo dell’epistemologia ha seguito ben altre vie. Fino a
non molto tempo fa, essa è stata dominata dal neopositivismo. Quando questa
concezione è entrata in crisi, ha lasciato il posto a una miscela di idealismo,
indeterminismo e relativismo, frutto dell’esplosione dello stesso empirismo
logico in tante piccole sette, in conflitto tra loro, concentrate sullo sviluppo
della propria versione di idealismo filosofico. La filosofia di Popper, sorta
come reazione all’empirismo logico, ha fornito una accettabile critica del suo
modo di procedere, salvo poi sostituirvi una pratica altrettanto inadeguata.
Agli imperativi calati dall’alto dai neopositivisti, Popper sostituì altri
imperativi calati dall’alto, ugualmente inutili per il lavoro degli scienziati.
La teoria di Kuhn fu una boccata d’ossigeno per la scienza. Non più obblighi
morali ma una semplice descrizione dello sviluppo della varie discipline. Questo
è il principale merito ma anche limite della concezione kuhniana. Così essa ha
accelerato il declino delle vecchie religioni epistemologiche, ma ha anche
favorito il diffondersi di nuove e se possibili peggiori tendenze: l’anarchismo
metodologico, la sociologia della conoscenza. La ragione per cui le teorie di
Kuhn hanno funzionato da cavallo di Troia del ritorno all’idealismo è da
ricercarsi nella sua confusione in campo propriamente filosofico e
particolarmente nella teoria della conoscenza. Kuhn era principalmente uno
storico e non gli è mai riuscito (né interessato) di approfondire le basi
gnoseologiche delle proprie tesi. Le sue teorie sono descrizioni e non arrivano
mai a spiegare l’oggetto delle proprie descrizioni.
Ora, a giudizio dello scrivente, il punto centrale di ogni teoria
epistemologica è il rapporto tra le teorie e i fatti, ovvero, nella accezione
classica, tra il pensiero e l’essere. Questo è quanto divide le scuole e i
metodi. Questa è una delle mancanze della teoria di Kuhn. L’altra debolezza, su
cui i suoi critici puntano il dito, è l’indeterminatezza del concetto di
paradigma. Noi cercheremo di analizzare l’una e l’altra mancanza, proponendo
rimedi e cercando infine di dimostrare che la concezione di Kuhn, se
interpretata secondo una teoria della conoscenza più robusta, fornisce
indicazioni estremamente valide allo scienziato, al filosofo e allo storico.
2. Le rivoluzioni scientifiche
Nella descrizione di Kuhn, l’attività scientifica ordinaria (la scienza
normale), ignora o sottostima gli aspetti problematici di una teoria,
concentrandosi nell’arricchimento dei suoi punti forti. Per un certo periodo, le
anomalie cominciano ad accumularsi, sempre più inesorabili, sempre meno
eludibili. Ad un tratto, l’accumulo genera un effetto soglia, innescando una
rivoluzione scientifica che conduce all’abbandono del vecchio paradigma e al
sorgere di una nuova concezione scientifica.
Il punto centrale, in questa profonda descrizione dello sviluppo della
scienza, è fornire una convincente spiegazione del perché la stessa anomalia può
essere ignorata per anni e poi, in altre condizioni, provocare il crollo del
paradigma. La storia della scienza ci dice, infatti, che spesso non sono nuove
anomalie a provocare la crisi del paradigma, ma si tratta di problemi ben noti
ai ricercatori di quel settore, a volte addirittura precedenti al sorgere del
nuovo paradigma. La principale critica che si può rivolgere a Kuhn è che il suo
modello di scienza descrive come avvengono le rivoluzioni nella scienza,
ma non perché esse avvengono. Le scuole successive (essenzialmente
anarchismo metodologico e le diverse versioni della sociologia della conoscenza)
hanno fornito indicazioni importanti, ma su una base filosofica idealista e
relativista. Non essendo stata in grado di fornire una spiegazione obiettiva,
materialista, all’evoluzione scientifica, l’epistemologia ha dovuto prendere una
strada obbligata: considerare le rivoluzioni scientifiche come il risultato di
una lotta puramente ideologica e politica delle varie scuole.
Il mondo reale può anche esistere (queste scuole sono spesso agnostiche in
campo ontologico), ma è ininfluente. Il progresso scientifico sarebbe una
questione puramente culturale, sociologica: un gruppo di scienziati si dimostra
più furbo o spietato degli altri e impone al mondo la propria interpretazione su
cosa sia il reale. Il cammino cominciato secoli fa per fornire una spiegazione
razionale al sorgere e declinare delle teorie è così finito in una piena
vittoria dell’irrazionalismo. Oggi sappiamo che i fatti non possono decidere
univocamente della sorte delle teorie, le quali possono essere sempre difese con
stratagemmi ad hoc. Ma dobbiamo per questo rinunciare ad ogni analisi obiettiva
della scienza? Un argomento bisogna concederlo alla sociologia della conoscenza:
lo sviluppo della scienza procede sulla base di eventi esterni, che ne
condizionano profondamente le sorti.
Questo è vero, ma non è una novità. Costituisce un caposaldo della teoria
marxiana delle ideologie, a dimostrazione che si può mantenere un legame tra
scienza e società anche nell’ambito di una concezione materialista. Secondo tale
concezione, un’ideologia arriva a dominare una certa epoca storica perché
risulta funzionale alle caratteristiche fondamentali di un determinato modo di
produzione. Detto diversamente, un’ideologia è una rappresentazione distorta
della società che l’ha generata. Perciò, il prevalere di una o dell’altra
ideologia non dipende principalmente da aspetti soggettivi (l’abilità dello
scienziato) ma da aspetti storico-sociali, oggettivamente determinabili. Per
esempio, il creatore dell’anarchismo metodologico, Feyerabend, cerca di spiegare
per tutte le 300 pagine del suo libro più famoso (Contro il metodo) che
Galileo ebbe ragione della teoria tolemaica con l’astuzia, e non grazie a
migliori argomenti e prove.
Secondo la concezione marxista dell’ideologia, lo sviluppo dei nuovi rapporti
di produzione borghesi avrebbe condotto inevitabilmente al ridimensionamento del
potere ideologico della Chiesa. In particolare, il continuo rivoluzionamento
tecnologico necessario alla sopravvivenza del capitalismo è incompatibile con
dogmi di fede nel campo delle scienze naturali. Il ridimensionamento del ruolo
epistemologico della dottrina cristiana era una necessità storica. Le forme che
questa necessità hanno preso sono invece dovute a una combinazione di fattori
accidentali. La teoria copernicana, l’illuminismo, l’utilitarismo, l’economia
politica inglese, nessuno di questi fenomeni scientifici doveva per forza di
cose svilupparsi. Ma la sostanza che li accomuna (la critica alla religione, al
vecchio potere statale, ecc.) sarebbe inevitabilmente uscita fuori, veicolandosi
in questa o quella teoria.
E' dunque vero che, in ultima analisi, una rivoluzione scientifica si produce
per un cambiamento che si dà al di fuori di essa. Ma il legame tra scienza e
fattori “esterni” non è affatto soggettivo. Nella concezione materialista del
rapporto scienza-società, lo sviluppo delle teorie riproduce, in ultima analisi,
lo sviluppo della società, da cui mutua le proprie leggi generali di
funzionamento. Lo sviluppo del capitalismo è un fenomeno altrettanto oggettivo
della rotazione dei pianeti. Pertanto, la vittoria finale della teoria
copernicana su quella tolemaica era ineludibile come l’arrivo della primavera
dopo l’inverno. Se anche Galilei fosse stato un incapace, o semplicemente un
imprudente e dunque fosse finito arrostito, un altro avrebbe preso il suo posto,
finché qualche scienziato non fosse riuscito a far stare la gerarchia
ecclesiastica al suo posto. Di nuovo, la forma storica del conflitto tra
copernicani e Chiesa cattolica era contingente, ma l’esito storico della lotta
era già scritto. Alcuni filosofi riescono a vedere solo gli immediati processi
casuali e non riconoscono dietro ad essi le determinanti profonde della storia.
L’abilità di una casta di scienziati, e soprattutto la paura e la coercizione,
possono ritardare di decenni la vittoria di una rivoluzione scientifica, ma in
nessun modo possono invertire il processo oggettivo, storico che porterà al suo
trionfo. L’accanimento terapeutico non ha mai reso immortale nessuno.
Dunque, la scienza trae le sue ragioni profonde dalla società. Questo non
significa che ogni svolta scientifica possa spiegarsi con un cambiamento nelle
condizioni sociali di una data epoca. Il legame tra scienza e società è
infinitamente ricco, dialettico, complesso. Si può fare un’analogia con l’arte.
E' innegabile che vi sia un legame fra una certa espressione artistica e l’epoca
in cui è prodotta. Ma si tratta di un rapporto indiretto, mediato dalla
personalità dell’artista e da altri mille fattori. Ciononostante esiste. Picasso
avrebbe potuto dipingere Guernica solo negli anni ’30 del ventesimo secolo e in
nessun’altra epoca.
Allo stesso modo l’economia politica classica inglese non avrebbe potuto
affermarsi né un secolo prima né un secolo dopo. Né avrebbe potuto resistere
allo sviluppo del capitalismo, i cui conflitti sociali si sono riflessi in una
lacerazione della teoria economica classica in teorie contrapposte. Di nuovo,
Marx e Walras (i fondatori di queste teorie contrapposte) sono accidenti
storici, ma la teoria marxista e la teoria economica neoclassica, come
concezioni del mondo, sarebbero inevitabilmente sorte in base allo sviluppo del
capitalismo. Questa concezione del rapporto tra scienza e società, a ben
guardare, mantiene e realizza il senso profondo della visione popperiana e anche
positivista della scienza perché è in ultima analisi un “fatto” (lo sviluppo del
capitalismo) a decidere della nascita e della crisi di una teoria. Allo stesso
tempo, adotta la teoria di Kuhn come fedele descrizione della vita di un
paradigma. Solo, vi fornisce una spiegazione.
3. La scienza normale
Le rivoluzioni scientifiche rappresentano le svolte epocali che avvengono
nella storia e si tratta di eventi molto rari. Tra una svolta e l’altra si
svolge lo sviluppo di una determinata società. Quando a un determinato sistema
diviene impossibile continuare a svilupparsi, si creano le condizioni per una
nuova svolta. Ma non tutte le rivoluzioni scientifiche corrispondono a delle
rivoluzioni sociali. Questo vale solo per il quadro ideologico complessivo a cui
comunque tutte le singole teorie devono in un modo o nell’altro rifarsi. Accanto
agli sconvolgimenti davvero epocali (pensiamo alla rivoluzione francese, alla
rivoluzione russa, alla caduta dell’Impero romano d’occidente ecc.) esistono
cambiamenti di minore importanza ma pur sempre rilevanti. Per esempio, il
capitalismo ha subìto profondi cambiamenti dai tempi della rivoluzione
industriale. Sarebbe meccanico trasferire questi cambiamenti nella scienza e
proporre uno schema del tipo: grande cambiamento sociale = grande rivoluzione
scientifica; medio cambiamento sociale = media rivoluzione scientifica ecc.
Tuttavia, non bisogna sottovalutare l’effetto che ha sugli scienziati
l’atmosfera culturale che si respira, le pressioni provenienti, per mille vie,
dai conflitti sociali. Inoltre, fasi di rapido sviluppo economico conducono a
grandi innovazioni tecnologiche, che, nelle condizioni moderne, sono alla base
di quasi tutte le scoperte e teorie delle scienze naturali. Ma la connessione
tra scienza e società serve a mettere in luce un altro aspetto decisivo: il
ruolo della scienza normale. Come detto, le trasformazioni sociali sono
avvenimenti rari nella storia (in occidente 3-4 in migliaia di anni). Questo non
significa che tra due rivoluzioni non avviene nulla. La rivoluzione crea le basi
per una nuova epoca di sviluppo, sbarazzandosi repentinamente dei residui del
passato. Finché i nuovi rapporti di produzione si dimostrano fecondi a livello
generale (cioè, in ultima analisi, fin quando accrescono il rendimento del
lavoro sociale), non sussistono le condizioni per un altro cambiamento.
Questo non significa che i diversi soggetti sociali e politici accettino
tutto quello che viene come ineluttabile. Anzi, la storia ci insegna che subito
dopo la rivoluzione si aprono lotte spesso furibonde e non solo di retroguardia.
Ma queste lotte, finché il sistema si espande, sono destinate a ricomporsi, o
sono comunque perdenti. Ciò non le rende inutili: la lotta per la riduzione
dell’orario di lavoro, sviluppatasi già agli albori del capitalismo, consente
oggi a un operaio europeo di restare in azienda solo 8-9 ore, contro le 15-20
dell’Ottocento. Pretendere miglioramenti delle proprie condizioni di vita
all’interno di un sistema dato non è mai fuori luogo, anche se a volte non si
porta a casa nulla.
Ebbene, questa è proprio la condizione che Kuhn definisce scienza normale.
Una volta che un paradigma è formato, almeno nei suoi tratti fondamentali
scientifici e soprattutto ideologici, metodologici, politici, tutta la critica
al paradigma si trasforma in critica nel paradigma, il quale,
finché resta fecondo, convince gli scienziati a procedere riformandolo anziché
abbattendolo. Il parallelo è sia storico (perché per le ragioni dette, è tipico
che epoche di pacifico sviluppo quantitativo si accompagnino al fiorire della
scienza normale all’interno dei paradigmi scientifici dati), sia strutturale,
nel senso che segue una dinamica assai simile: anche nel paradigma vi sono
lunghi periodi di sviluppo quantitativo e poi brusche svolte rivoluzionarie.
Proprio come nella società, tra una rivoluzione scientifica e l’altra non vi
è affatto una desolante bonaccia. Gli scienziati, pur all’interno dello stesso
paradigma, si combattono aspramente, si criticano, producono scoperte rilevanti
e così via. Come noto, quando Kuhn propose la sua idea di scienza normale,
nessuno poté negare l’esistenza e l’importanza di questo fenomeno. Ci fu però
chi criticò moralmente gli “scienziati normali”. Popper arrivò a dire che si
dovevano vergognare e che lui, come il rivoluzionario Trotskij in politica, era
per la rivoluzione permanente.
Ora, un approccio critico è importante e su questo non si può che concordare
con Popper. Ma è ingenuo, e sviante, credere che l’atteggiamento degli
scienziati possa derivare da un imperativo morale caduto dall’alto, proprio come
avviene in politica. In fondo, gli stessi Lenin e Trotskij hanno passato la
maggior parte della loro vita a sognare una rivoluzione inattuabile. Per quanto
uno possa essere un fervente rivoluzionario, la rivoluzione necessita di
condizioni obiettive indipendenti da lui. Quando qualcuno ha tentato di
rovesciare il regime in assenza di queste condizioni è stato facilmente
annientato. Quando uno scienziato critica un paradigma, senza che si siano
ancora create le condizioni perché questo sia superato, potrà trovare un certo
ascolto, avere la sua rivista e i suoi discepoli, ma rimarrà sempre in posizione
minoritaria. Nei periodi normali, le dispute scientifiche si svolgono
all’interno del paradigma ed è perciò utile chiarire questo concetto, tirandolo
fuori dall’indeterminatezza in cui lo stesso Kuhn lo ha lasciato.
4. Sulla struttura dei paradigmi scientifici
Si potrebbe dire che per difendere il concetto di paradigma non c’è che da
osservarne la fortuna: il fatto che tutti gli epistemologi successivi a Kuhn
siano stati costretti a introdurre tale concetto nel loro sistema, seppur con
altri nomi, dovrebbe essere prova sufficiente della sua validità[1]. Lakatos in particolare, quale erede designato di Popper
avrebbe dovuto continuare la lotta all’epistemologia descrittiva di Kuhn, eppure
si è dovuto piegare, tentando malamente di conciliare le due scuole e creando un
sistema sincretico, che potremmo descrivere come retorica viennese in salsa
americana. Basti notare che il falsificazionismo “sofisticato”, cioè quello di
Lakatos, è sofisticato in quanto contaminato da Kuhn. Il concetto di paradigma
dunque ha una straordinaria potenza esplicativa, ma deve essere decisamente
reinterpretato per acquisire un ruolo progressivo nella comprensione del vero
sviluppo della scienza.
Premettendo che non è affatto nostra intenzione prenderci il merito di aver
proposto per la prima volta l’arricchimento del concetto di paradigma[2], l’idea è quella di considerare il paradigma come un
albero, formato da una vasta serie di riferimenti intellettuali (le radici),
convogliate da uno o più fondatori in un corpus organico (il tronco) che, non
appena la teoria acquisisce un certo successo, esplode in una ramificazione.
Dapprima essa è formata da pochi snodi principali; dopo anch’essi si suddividono
a loro volta finché l’albero, cioè il paradigma, non presenta una serie
molteplice di varianti, pur ognuna risalente, in un percorso (che è possibile
fare storicamente, ma che è anche analitico) sino al tronco e alle radici.
La metafora va approfondita. Il tronco è comune a tutto il resto. Questo
significa che le diverse scuole all’interno di un paradigma devono pur sempre
condividere una base minima. Non solo, ma tanto più le scuole hanno in comune
(sono cioè sullo stesso ramo o addirittura sullo stesso ramo secondario), tanto
più sostrato teorico ed empirico condividono. Procedendo nella ramificazione, il
paradigma si fa stringente e perciò più definibile da un punto di vista pratico.
Alla fine, in cima all’albero del paradigma, su un rametto, si situa una scuola
composta magari da un solo scienziato e dai suoi discepoli più ortodossi.
Ovviamente, esistono alberi ed alberi. Vi sono querce con centinaia di rami
molto distanti, e vi sono cipressi, i cui rami, ben stretti tra loro, puntano
tutti nella stessa direzione.
Ma la ramificazione rappresenta la situazione del paradigma anche da un altro
punto di vista. I rami hanno tra loro una gerarchia, ben rappresentata dal fatto
che non è possibile trovare un ramo più grosso del ramo che lo sostiene.
Trasposto nella vita della scienza, questo significa che mano a mano che il
paradigma attira ricercatori, si va dividendo, innanzitutto, tra alcune grandi
opzioni nell’interpretazione della rivoluzione scientifica che è avvenuta
(ovvero nella prima generazione, ma torneremo su questo). Poi, ogni ramo
comincia a fare una vita a sé, suddividendosi ulteriormente. Ma proprio come in
un albero, i rametti sono suddivisioni dei rami e così via a ritroso fino al
tronco. Così la singola scuola fa riferimento innanzitutto alla specifica
interpretazione da cui proviene e solo in seconda battuta al paradigma più
comprensivo, anche se, ovviamente, uno scienziato può cambiare idea e spostarsi
su un altro ramo (o addirittura albero). La ramificazione, serve anche a
comprendere come il paradigma si confronta con il materiale empirico. Le
anomalie (o falsificatori potenziali, come li definiva Popper) non sono tutte
uguali.
Normalmente, la disconferma empirica della teoria colpisce il rametto, o al
più un ramo, ma non arriva mai a segare il tronco, ovvero ad avviare una
rivoluzione scientifica, per la quale occorrono ben precise condizioni esterne.
Inoltre, proprio come con le piante, sono sempre i semi caduti dagli alberi di
oggi che consentono la nascita degli alberi di domani. Quando avviene una
rottura che, come detto, affonda le sue ragioni in eventi esterni al paradigma
stesso, ma che comunque interagiscono con lo sviluppo del paradigma, la forza
della rottura dipenderà sostanzialmente:
a) dalla misura in cui i livelli del paradigma sono omogenei tra loro;
b) dalla misura in cui sono presenti dei sostituti.
L’omogeneità significa l’accettazione di teorie legate analiticamente e/o
empiricamente tra loro. Se l’omogeneità è alta, l’anomalia può intaccare i rami
principali del paradigma, ottenendo un effetti soglia pressoché contemporaneo a
tutti i livelli. In generale, questo avviene quando l’anomalia è logica,
teoretica (si pensi a come il teorema di Gödel colpì negli anni ’30 ogni
tentativo di assiomatizzazione della matematica, a partire da quello di stampo
hilbertiano). Quando invece è empirica colpirà a partire dall’alto, cioè della
singola scuola, quella più direttamente legata alle previsioni in questione.
Lo stesso Kuhn spiegava come le anomalie vengano contestate e imputate allo
scienziato e non al paradigma, anche perché da stesse teorie generali si possono
trarre predizioni specifiche anche opposte. Questo processo, nelle fasi in cui
il paradigma conserva la sua forza di attrazione, avviene perché i diversi
scienziati del paradigma si combattono per l’egemonia. Lo scopo di queste
critiche non è affossare il paradigma, ma piuttosto distruggere le scuole
rivali, pur mantenendo valido il paradigma generale. Si vuole potare l’albero,
non abbatterlo.
Il fenomeno di attribuzione dell’insuccesso empirico è basilare per capire
come avvenga la lotta tra paradigmi e nel paradigma. E' inutile ribadire che in
realtà una teoria non si farà mai sconfiggere da un fatto, come credeva un tempo
Popper, piuttosto è nel conflitto tra teorie e paradigmi che si inserisce
l’interpretazione dei dati empirici. Analizzando l’evoluzione dei paradigmi,
appare chiaro che i risultati dell’attacco sono sempre connessi con l’esistenza
di un’alternativa: una teoria è colpita da un fatto nella misura in cui un’altra
ne è favorita, e quando nessuna teoria ha da proporre niente riguardo a un
argomento, ciò è indice di grave difficoltà della disciplina. Dato quel che si è
detto sulla stratificazione paradigmatica, le anomalie non possono più
considerarsi nemiche indiscriminate di un paradigma. In realtà possono colpire
più scuole di paradigmi diversi che due scuole dello stesso paradigma. Arriviamo
così al problema centrale della lotta teorica.
Accanto alle lotte tra paradigmi, che si concludono, come descritto da
Kuhn, con la vittoria di un paradigma che esilia il resto della scienza e
riscrive il passato a propria glorificazione, ci sono anche le lotte
intraparadigmatiche. Se una scuola accetta i capisaldi del paradigma, non
rivolgerà le armi contro di essi fintantoché non intenderà uscire dal paradigma.
Al singolo ricercatore potrà forse sembrare una decisione personale, ma come
detto, la scelta della rivoluzione o della riforma del paradigma si basa su un
processo oggettivo. Nel periodo di lotta all’interno della teoria comune, una
scuola attaccherà direttamente la rivale su questioni che le dividono. Questo
significa che sosterrà che la propria interpretazione del paradigma è l’unica
valida e gli altri rami sono dogmatici o devianti, traditori, rinnegati,
ecc.
Lo sbocco di questo tipo di lotte, che non dipende ovviamente solo da
questioni teoriche né empiriche, ha come conseguenza l’emerge di una visione
dominante all’interno del paradigma. Le scuole sconfitte possono confluire in
quella mainstream, adattarsi a restare nell’ombra per un po’ o anche, in
situazione particolari, scegliere di uscire dal paradigma e rilanciare il
confronto a livello di paradigma contro paradigma.
Come regola, si può dire che quanto più il livello dello scontro è “alto”
cioè analitico, astratto, tanto più grande sarà la battaglia e poi l’eventuale
scissione.
Naturalmente, poiché il nuovo paradigma non cade dal cielo ma è la risultante
della battaglia all’interno del vecchio quadro concettuale, spesso ne accoglie
molti elementi teorici. Tuttavia se se ne distingue, è perché il riferimento è
troppo labile per poter considerare la scissione una scuola solo più eretica di
altre. Inoltre sono gli stessi scienziati “scissionisti” a dichiarare di solito
la spaccatura, ma anche qui occorre fare attenzione. Per vari motivi ci possono
essere scienziati che fingono continuità che non ci sono, anche per facilitare
il successo del nuovo paradigma. L’idea di Kuhn che il proliferare di versioni
del paradigma sia la dimostrazione di una sua crisi è dunque superficiale e va,
a mio giudizio, rigettata. Il proliferare di versioni del paradigma è invece una
fase necessaria nello sviluppo scientifico e prepara le rivoluzioni e le nascite
dei nuovi paradigmi. Gli alberi con mille rami e fronde sono più in salute di
quelli spogli.
La stratificazione del paradigma avviene dopo che l’orientamento metodologico
di fondo che lo contraddistingue ha avuto la meglio. E' difficile infatti
pensare a un paradigma che arrivi al potere già pronto. Anche qui l’analogia ci
sembra illuminante. Gli alberi non nascono come piccoli alberi in miniatura, ma
con una forma totalmente differente e assai poco ramificata. Lo sviluppo della
pianta conduce alla sua ramificazione. Questo si sposa bene con l’idea kuhniana
di paradigma, che prevede esplicitamente che ci siano molte questioni lasciate
ancora aperte al suo sorgere, che attirino la curiosità intellettuale degli
scienziati. Sebbene i paradigmi non siano uguali l’uno all’altro, è però
possibile trovarvi almeno un elemento comune: tutti sono più o meno
stratificati.
Cerchiamo ora di studiare le dinamiche propriamente epistemologiche per cui
il paradigma si divide al proprio interno. Il paradigma nasce da una scuola
eretica della vecchia teoria. La lotta nel paradigma dominante crea le
condizioni per la nascita del nuovo paradigma. Non ci sono esempi noti in cui un
paradigma è potuto sorgere di punto in bianco già formato, senza nessun
riferimento alla scienza precedente. Non comunque nella scienza moderna. Il
paradigma nasce rifacendosi, magari per differenza, a quello dominante o alla
tendenza dominante, magari di altre discipline. Quindi diviene egemone e inizia
la sua espansione.
Se la scienza è già abbastanza evoluta, si tratterà principalmente di
convincere i recalcitranti “nostalgici” ad andarsene o a convertirsi. Quanti si
convertono sono spesso il germe della lotta intraparadigmatica futura, ma anche
qui il caso può essere rovesciato, e i convertiti possono dimostrarsi più
realisti del re. Inoltre contano anche aspetti quali il vantaggio da
differenziazione del prodotto scientifico (proporre un modello leggermente
diverso da quello standard per pubblicare di più), le diverse concezioni
nazionali, le tradizioni locali di un paradigma che si sono in qualche modo
trasfuse nel nuovo ecc.
La lotta che il nuovo paradigma fa contro gli avanzi del vecchio è condotta
con armi anche molto poco scientifiche e nobili: si tagliano i fondi e si
isolano gli irriducibili, si conquistano i comitati di redazioni delle riviste,
si piazzano in posti chiave i propri allievi, e così via. In questo, le analisi
fornite dai sociologi della conoscenza sono condivisibili. Inoltre, una teoria
ha per necessità dei punti deboli. Basta dimostrare che i punti deboli della
teoria precedente sono il fulcro della scienza e che la nuova li risolve ed ecco
che il nuovo paradigma si costruisce la giustificazione scientifica
dell’eutanasia del vecchio.
In questo entra anche il fenomeno di ricambio generazionale, come lo stesso
Kuhn aveva suggerito. Infatti la generazione che per lo più farà scienza
normale, raccogliendo l’eredità del caposcuola, si trova in una situazione molto
tempestosa e molto feconda. Un caposcuola di qualsiasi scienza è un pensatore
che crea un nuovo paradigma, rompendo con le vecchie concezioni. Per quanto
abbia vissuto il maestro, per quanto profusamente e chiaramente abbia scritto
sulle proprie teorie, avrà sicuramente lasciato agli allievi un mare di dubbi,
lacune, incertezze e contraddizioni. Tanto più questo accadrà con quei pensatori
originali e geniali che si sono occupati di molti aspetti del reale e da tante
angolazioni.
Le teorie del fondatore o dei fondatori risulteranno più o meno chiare ma
comunque ci sarà sicuramente un alone di interpretatività lasciato agli eredi.
La schiera di allievi inizia il processo di estensione e approfondimento del
paradigma. Questa estensione porterà alla nascita di scuole separate. Non
importa quanto fedeli o spregiudicati siano gli allievi nel giudicare il
pensiero del maestro, non importa quanto preciso sia il paradigma,
ineluttabilmente nasceranno scuole diverse e in varia misura rivali. Questo
processo è fondamentale per capire il nuovo concetto di paradigma e la sua
stratificazione, ed è un processo connesso con il ruolo della scienza normale.
In sintesi nell’ambito di una scuola, o più in generale di un paradigma, la
seconda generazione sviluppa il modello, la teoria, le conoscenze in qualche
direzione. Quali sono le forze che avvicinano o allontanano dal nuovo paradigma?
Premettendo che spesso le ragioni reali non sono chiare nemmeno allo stesso
scienziato, possiamo distinguere:
a) forze “attraenti”: principalmente la forza materiale del paradigma e i
problemi aperti. Il ‘potere’ è un argomento ovvio: che carriera garantisce
aderire? Che punizione si rischia convertendosi? Sono discorsi che gli
scienziati si fanno da quando sono all’università a quando ricevono il premio
Nobel. Ma contano molto anche i problemi aperti. E' per questo che la scienza
normale si lega inestricabilmente alla seconda fase della vita di un paradigma.
Quando il paradigma si è conquistato uno spazio nella propria disciplina,
riuscirà ad attirare studiosi solo se essi vedranno la possibilità di utilizzare
il paradigma per problemi nuovi. Essi vorranno cioè usare il paradigma per
risolvere nuovi problemi, smettendo di farsi domande sul paradigma in sé.
Se la teoria è insuscettibile di modificazioni progressive, gli scienziati se
ne disinteresseranno. In questo, gioca un ruolo anche la componente di vanità
intellettuale. Gli scienziati non amano applicare in modo routinario quanto
creato già in toto da altri. Ma soprattutto la teoria serve a spiegare le nuove
situazioni. Essa deve spiegare eventi nuovi che il fondatore non poteva avere in
mente se non in parte. Le condizioni oggettive sono poi, soprattutto nelle
scienze sociali, una spinta enorme, anche se non decisiva. E' chiaro, ad
esempio, che la profonda crisi economica degli anni ‘30 allontanò molti
economisti dalle teorie che negano che il capitalismo possa attraversare delle
crisi.
Ad ogni modo, il paradigma può conquistare il campo per varie ragioni, ma
mantiene la sua attrattiva se permette di fare ricerca delimitando il campo di
lavoro. In fondo il suo compito è proprio questo: fornire un quadro di
riferimento per il lavoro dello scienziato. Facilmente, un paradigma appena nato
sarà più movimentato ma anche “movimentista”, cioè poco inquadrato. In seguito,
accanto alla scuola fondatrice, che potrà addirittura essere messa in un angolo,
arriveranno una serie di nuove interpretazioni, estensioni, arricchimenti del
paradigma. Così, lo scienziato che comincia la carriera dopo la vittoria del
paradigma, non è attratto dal paradigma tout court ma dalla singola scuola del
paradigma.
Tutti questi processi nelle scienze naturali si vedono meno perché le
condizioni storico-sociali influiscono in modo più indiretto. Senz’altro, per il
successo del paradigma conta anche l’abilità del singolo scienziato o della
singola scuola, soprattutto nel breve periodo, ma non si può arrivare alle
esagerazioni di chi, come Feyerabend, dà a questo fattore un peso decisivo. Per
riprendere il caso di Galileo: come scrisse Gould, non basta essere perseguitati
per essere Galileo, bisogna anche avere ragione. E infatti oggi si parla ancora
delle teorie scientifiche di Copernico e Galileo perché erano un passo avanti
oggettivo. Non così per le teorie di altri eretici che pure furono
perseguitati ma non per aver scoperto nuovi “fatti”.
b) forze “repulsive”: lo scienziato sarà respinto da un paradigma in crisi o
troppo ortodosso o del tutto indefinito. Come detto, per Kuhn la proliferazione
delle versioni del paradigma è un male. In realtà, a meno che questa
proliferazione significhi una serie di vere scissioni in cui gli scienziati
abbandonano il paradigma, vale il contrario. La proliferazione all’interno del
paradigma lo rafforza, mentre l’estendersi delle defezioni è la conseguenza
della crisi del paradigma, non la sua causa. Ovviamente, in quel caso, le
proliferazioni a loro volta alimenteranno il processo di crisi.
Infine, la stratificazione dei paradigmi ha alle spalle un fenomeno
fondamentale della produzione moderna: la divisione del lavoro. Proprio perché
spesso i creatori del paradigma sono scienziati versatili, pensatori universali,
riescono a impostare nuove concezioni, ma in seguito, all’aumentare delle
ricerche sul paradigma, entra in funzione la specializzazione. La produzione
capitalistica spinge la scienza verso la parcellizzazione. Il paradigma perciò
viene stratificato per seguire in un certo senso la divisione del lavoro. Lo
stesso paradigma non si stratifica solo perché gli scienziati hanno opinioni
differenti sul medesimo argomento ma perché si occupano di argomenti diversi. La
teoria della stratificazione trova perciò una sua causa materiale nella
divisione sociale del lavoro. A un processo produttivo basato sulla divisione
del lavoro non può che corrispondere una scienza e un’epistemologia in cui gli
“specialisti” si dividono il lavoro. Il rapporto tra scienza e processo
produttivo passa per la divisione sociale e scientifica del lavoro.
5. Una riformulazione materialista della teoria di Kuhn
La concezione generale che abbiamo proposto sui legami tra scienza e storia
può essere ulteriormente affinata cogliendo più in dettaglio le analogie tra le
leggi di movimento delle rivoluzioni nella società e nella conoscenza.
Nella teoria della rivoluzione di Marx, lo sviluppo delle forze produttive è
un’accumulazione pressoché continua di nuovi mezzi di produzione, nuove
conoscenze ecc. I rapporti di produzione, che determinano il rapporto delle
classi nel processo produttivo, hanno il compito di orientare lo sfruttamento di
tali forze produttive. A un certo momento questa loro funzione orientativa viene
meno perché lo sviluppo delle forze produttive le supera. Subentra un periodo di
rivoluzione, i rapporti di produzione vengono trasformati e le forze produttive
possono continuare a crescere[3]. Per chi ha in mente la
descrizione che Kuhn fa dello sviluppo di nuovi paradigmi, la stretta analogia
dei due processi non può non colpire. Cominciamo dunque con il cercare di
“riportare” i concetti utilizzati da Marx nel mondo dei paradigmi scientifici.
Cosa sono le forze produttive nella scienza? Iniziamo col dire che il
concetto di forze produttive in Marx non è solo tecnico, quantitativo: egli vi
ricomprende la stessa classe dei produttori, nonché le conoscenze scientifiche
incorporate nelle macchine e in tale classe. Dunque dobbiamo definire forze
produttive scientifiche l’insieme delle conoscenze scientifiche e in genere
il “software” della conoscenza ma anche la classe degli scienziati e i
macchinari (l’“hardware”), ovvero i mezzi di produzione scientifici
(laboratori, centri di ricerca, strumentazione). Ci rimane da stabilire che
cosa siano i rapporti di produzione scientifici. Nella società, i
rapporti di produzione sono essenzialmente il modo con cui si relaziona la
classe che possiede i mezzi di produzione e si appropria dei risultati del
processo produttivo e la classe che aziona i mezzi di produzione.
Vi è dunque sia un aspetto statico (la proprietà) che dinamico (l’uso della
proprietà per espandere la sfera della produzione). Nella nostra epoca questi
due aspetti sono compendiati dal concetto di capitale, che incorpora tanto la
proprietà che la funzione dei mezzi che la società si è data per produrre. Nella
scienza, l’aspetto statico (la proprietà) non riveste particolare interesse
perché ciò che è materiale è ovviamente già di proprietà di qualcuno (il
laboratorio ecc.), e ciò che è immateriale serve solo se connesso alla
produzione. Ad esempio, uno scienziato che trova un nuovo materiale chimico,
finché mantiene questa scoperta su un foglio, non modifica nulla nel processo
produttivo (né nel suo conto in banca). Non appena questa scoperta o invenzione
entra nella sfera produttiva diviene utile, cioè appropriabile da qualcuno.
Pertanto, i rapporti di produzione all’interno della scienza derivano dalle
forme di proprietà dominanti in una determinata epoca. Non solo, ma il modo con
cui gli scienziati si rapportano con il proprio ruolo, e cioè la concezione
dominante di cos’è e come si fa la scienza (l’ideologia e l’epistemologia
dominanti), derivano dall’ideologia dominante a livello generale.
A) La rivoluzione
Sull’analogia e le relazioni tra rivoluzioni sociali e scientifiche si è già
detto. Lo sviluppo della scienza è fortemente collegato con lo sviluppo della
società e nella nostra epoca si tratta di un processo circolare, con le nuove
conoscenze scientifiche che permettono un aumento nella produttività sociale e
quindi uno sviluppo nelle forze produttive. Certo, ci sono anche casi nei quali
una scienza florida si contrappone a una società in crisi oppure casi nei quali
la società fa grandi passi avanti mentre la scienza latita o vivacchia. Comunque
questo non è il caso della nostra società. Anzi, nel capitalismo la retroazione
diviene sempre più stringente, con il risultato di una continua rincorsa fra
scienza e sviluppo dei mezzi di produzione.
Certo, definire il progresso scientifico è già in sé un problema insolubile
(come sappiamo dal fallimento del falsificazionismo), ma quello che ci interessa
valutare non è tanto la bravura speculativa degli intellettuali, quanto la
capacità di trasformare le nuove conoscenze scientifiche in un progresso
tecnologico. Il fatto stesso che gli scienziati si occupino di speculare senza
collegare quello che fanno con lo sviluppo produttivo potrebbe essere un segno
di crisi sociale. Facciamo l’esempio di Leonardo. Indubbiamente è stato uno dei
più grandi geni dell’umanità, il miglior campione della rinascita della
razionalità dopo la notte del Medioevo.
Come si sa Leonardo si occupò di tutto, “inventò” tutto, dal carro armato
all’elicottero. Eppure, nella misura in cui le trovate di Leonardo non
rappresentavano un certo grado di sviluppo della società ma solo alcune
straordinarie trovate di un genio, esse sono state quasi tutte inutili ai suoi
contemporanei. E oggi possiamo affermare che arricchiscono l’umanità più le
opere d’arte di Leonardo che non una serie di schizzi buoni forse per costruire
modellini e inutili sin dalla loro concezione, proprio come ora i libri di
fantascienza non aiutano in nessun modo un fisico a costruire un’astronave o una
macchina del tempo. Il caso di Leonardo serve a dimostrare che il progresso
scientifico non sta nelle trovate di una mente brillante, ma nella capacità di
sviluppare realmente le forze produttive.
Ma l’esempio più eclatante di una scienza rigogliosa in una società stagnante
è forse quella dei Greci dell’epoca classica. Per secoli i filosofi e matematici
greci hanno fornito al mondo idee e scoperte straordinarie, molte delle quali
sono in uso persino tuttora (si pensi alla geometria euclidea, alla logica
aristotelica, a molti problemi matematici archimedei e diofantei ecc.). Eppure
quella società era ben poco dinamica, essendo basata sullo schiavismo, che di
per sé impedisce ogni rapido progresso. E' un caso unico e lo si vede dal fatto
che l’Impero Romano, con risorse produttive infinitamente maggiori a
disposizione, ha dato contributi alla scienza e alla matematica infinitamente
minori. E' più importante un Platone per la storia della filosofia, o un
Archimede per la matematica, che tutti i filosofi e matematici di Roma, dalla
sua fondazione al crollo dell’Impero romano d’Occidente.
Nella Grecia classica i problemi concreti della società davano il via a
speculazioni di filosofi “specializzati” ad astrarre e a pensare al nocciolo
analitico del problema più che al suo risvolto operativo. Così la Grecia antica
fu invasa da praticamente tutti i suoi vicini, più forti militarmente. Eppure,
anche un bravo storico della filosofia troverebbe difficile ricordare il nome di
uno solo dei filosofi persiani o macedoni o romani di quel tempo. La scarsa
comunicazione tra scienza e tecnologia era dovuta al fatto che la classe a cui
era dispensato di lavorare, la classe dei Platone e degli Aristotele, non si
occupava di produzione. L’economia schiavile non investiva praticamente nulla.
Era un’economia in cui solo eventi straordinari al di fuori del ciclo normale
portavano dei cambiamenti (guerre, calamità). Con questi eventi eccezionali
arrivavano nuovi schiavi e la società aveva nuovo combustibile per andare
avanti. Il capitalismo invece ha creato un rapporto organico, permanente tra
scienza e processo produttivo. Un rapporto sostanzialmente di subordinazione
della scienza all’economia ma comunque fecondo.
Gli scienziati sono dei professionisti, la scienza è un mestiere, come anche
l’arte. Nell’arte come nella scienza vi è un canale già pronto che stimola,
raccoglie e sfrutta l’inventiva umana. Ovviamente, i fisici, gli economisti,
come i cantanti e gli attori, devono suonare una musica che non faccia
dispiacere (per usare un eufemismo) ai rispettivi produttori. Tuttavia, tanto
nell’arte come nella scienza vi è un ampio ventaglio di opinioni e i produttori
più intelligenti sanno servirsi dei propri “artisti” più dotati anche quando
sono dei ribelli. Il tutto certamente entro limiti prudenti: anche il guinzaglio
più lungo a un certo punto si tende. Allo stesso modo se uno scienziato vuole
rompere con l’ideologia dominante deve prepararsi ai freddi inverni
dell’eterodossia. Che comunque sono da preferire ai caldi inverni dei roghi di
eretici, o di libri, di tempi passati.
B) Lo sviluppo delle forze produttive scientifiche
Lo sviluppo delle forze produttive scientifiche è dato dalle risorse che la
società mette a disposizione della scienza. Queste risorse nel capitalismo sono
connesse ai profitti che l’innovazione tecnologica consente di generare. Gli
scienziati scoprono, grazie alle nuove risorse e agli studi precedenti, nuove
teorie. Le forze produttive scientifiche, proprio come le forze produttive
sociali, avanzano praticamente senza interruzione. Questa è l’essenza della
scienza normale, la sua base oggettiva e necessaria. Le forze produttive, in una
nuova società e in un nuovo paradigma, hanno davanti un certo periodo di
crescita, prima rapida e tumultuosa poi più arrancante, e questo sviluppo è del
tutto progressivo. L’incessante accumularsi di nuove scoperte e nuovi mezzi di
produzione, accrescendo le forze produttive, mette in crisi le vecchie teorie e
ideologie, spingendo verso rivoluzioni scientifiche e sociali (solitamente in
questo ordine), che danno vita, in un periodo di tumultuosi rivolgimenti, a un
nuovo paradigma e a una nuova società. Questo è il fondamento sul quale si
sviluppano le scienze.
Tuttavia le cause per cui un paradigma entra in crisi sono anche interne, per
esempio a causa di mancanza di coerenza logica o semplicemente per una
contraddizione tra nuove scoperte e vecchia teoria. Ma infinitamente più
importante e decisiva è la funzione che le classi assumono nello sviluppo
storico. Ogni classe è stata per un periodo la locomotiva della storia. A un
tratto della sua vita però, ogni classe diviene un peso, comincia a frenare il
convoglio e rischia perfino di farlo deragliare. Tuttavia questo meccanismo non
appare affatto così neutrale come lo descriviamo. Uno psicologo potrebbe notare
che a nessuno piace sentirsi vecchio, figurarsi a un intera classe che ha
dominato il mondo per secoli. Ma qui c’è anche ben altro. Sin dalla propria
ascesa storica una classe forgia le armi con cui dominerà il mondo. Innanzitutto
queste armi sono ideologiche e scientifiche. Sono in ultima analisi una visione
superiore del mondo. Superiore naturalmente rispetto alla classe che fino ad
allora aveva gestito la società.
Tale visione incorpora inevitabilmente una clausola e cioè che l’arrivo al
potere di quella specifica classe pone fine alla storia dell’uomo. In secondo
luogo i valori della classe in questione vengono inevitabilmente estesi oltre
ogni vincolo storico, divenendo la realizzazione dell’essenza stessa
dell’umanità. Questa ideologia muta poi nel tempo. Da rivoluzionaria diviene un
placido gestire giorno per giorno la fase della maturità. Infine, diviene una
arcigna e reazionaria difesa dell’esistente, quando la nuova classe dominante è
divenuta anch’essa un pezzo di ferraglia, da locomotiva qual era. Le clausole
sull’eternità che incorporava però rimangono. Sono anzi tali che plasmano la
visione stessa. Nella fase di ascesa, quando la classe che aspira a trasformare
il mondo è oggettivamente una classe progressista, la visione del mondo è
immancabilmente materialista. Pian piano diviene invece soggettivista,
relativista. Prima prevalevano concezioni universalistiche, progressiste. Pian
piano prendono il sopravvento visioni minute, particolaristiche, sempre più
conservatrici. Con il mutare della funzione che la classe ha, rispetto al
procedere delle forze produttive, cambia dunque anche la sua ideologia e con
essa molti paradigmi scientifici. Possiamo perciò dire che i paradigmi
scientifici non mutano solo con il mutare delle società, ma anche con il mutare
del ruolo delle classi che le compongono.
Tutto questo processo è complicato dall’esistenza della stratificazione
paradigmatica di cui abbiamo parlato. Infatti la rivoluzione scientifica, specie
nelle scienze sociali, non spazza via in una notte le teorie precedenti.
Piuttosto inizia attaccando l’ortodossia con una scuola eterodossa del paradigma
dominante. Ad un certo punto la scuola eterodossa fa una scissione oppure
semplicemente egemonizza il vecchio paradigma e lo cambia dall’interno. Spesso,
ai margini del vecchio paradigma ci sono varie scuole eretiche divise che pian
piano si unificano utilizzando nuove scoperte o riutilizzando vecchie teorie;
altre volte sono gli ortodossi di un tempo a farsi rivoluzionari ecc. I casi
sono vari, l’importante è connettere attraverso processi obiettivi la scienza e
la società. La vittoria di un paradigma su un altro ha a che vedere con fenomeni
esterni alla singola scienza o teoria, ma è la scienza nel suo complesso che è
legata inestricabilmente a questi processi. La crisi o la vittoria di un
paradigma sono in ultima analisi la crisi o la vittoria di una classe e di una
società.
6. Conclusioni
La scienza e la società, nel loro sviluppo, sono strettamente collegate. Non
solo le leggi di questo sviluppo sono precisamente le stesse, ma i due processi
si intersecano e influenzano a vicenda. Le esigenze sociali della classe
dominante si cristallizzano in un paradigma e nella sua storia di
stratificazioni, lotte intestine, parziali rivolgimenti, fino a una morte
decretata per lo più in concomitanza con la morte dei propri referenti sociali.
La spiegazione di questa stratificazione e delle basi oggettive della scienza
normale non ne vuole essere una giustificazione. Diamo assolutamente ragione a
Popper quando sostiene la “rivoluzione permanente” in campo scientifico (salvo
sostituirvi la reazione permanente in campo sociale), solo spieghiamo perché non
tutte le epoche storiche possono essere rivoluzionarie, per la scienza e per la
società.
Il grande contributo che Kuhn ha dato alla comprensione della scienza viene
purtroppo disperso nei meandri di un relativismo cinico e inutile, la cui difesa
dello status quo avviene attraverso l’equiparazione di ogni teoria scientifica,
di ogni credo e ideologia con la “scoperta” che è impossibile dirimere per vie
puramente scientifiche le controversie teoriche. Ma, seppure consideriamo questo
sviluppo della filosofia della scienza come nefasto, ne accettiamo un
presupposto che peraltro risale a molto tempo addietro e cioè che nessuno
scienziato può pensare di disinteressarsi non solo e non tanto della filosofia
della scienza ma soprattutto della società in cui vive. La scienza non può
sperare di lasciar perdere la politica credendo che essa lascerà perdere lei.
L’unico modo per avere le idee chiare sul proprio lavoro, come scienziati e come
cittadini di questa epoca, è di comprendere le determinanti dello sviluppo di
questa società.
7. Bibliografia
- AA VV (a cura di K. Pomian), Sul determinismo, Il Saggiatore, Milano,
1991,
- AA VV, “La scienza impropria. Metodi ed usi della teoria economica”, in
Metamorfosi n. 8 (antologia di temi epistemologici con scritti di G.
Lunghini, A. Vercelli, A. Carabelli, C. Preve e altri)
- AA VV (a cura di A. W. Coats), Methodological Controversy in Economics:
Historical Essays in Honor of T. W. Hutchinson, Jai Press, Londra, 1983
- AA VV (a cura di R. E. Backhouse), New Directions in Economic
Methodology, Routledge & Kegan, Londra, 1994
- Albergamo F., La teoria dello sviluppo in Marx e in Engels, Guida,
Napoli, 1973
- Apostel L., Materialismo dialettico e metodo scientifico, Einaudi,
Torino, 1968
- Ayer A. J., Il problema della conoscenza, Nuova Italia, Firenze, 1967
- Barletta G., Per una epistemologia materialista, Dedalo, Bari, 1976
- Bellone, Geymonat, Giorello e Tagliagambe, Attualità del materialismo
dialettico, Editori Riuniti, Roma, 1974
- Berger P. e Luckmann N., The Social Construction of Reality. A Treatise
in the Sociology of Knowledge, Penguin Press, Londra, 1967
- Bernstein E., Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der
Sozialdemokratie, Dietz Nachf Gmbh, Stoccarda, 1899
- Bloor D., La dimensione sociale della conoscenza, Cortina, Milano,
1994
- Cini M., L’ape e l'architetto, (con altri) Feltrinelli, Milano, 1976
- Cini M., Trentatre variazioni su un tema, Editori Riuniti, Roma, 1990
- Cini M., Un paradiso perduto, Feltrinelli, Milano, 1994
- Dietzgen J., La teoria di classe della conoscenza, Lavoro liberato,
Milano, 1975
- Dobb M., Storia del pensiero economico, Editori Riuniti, Roma, 1974
- Eddington A. S., La natura del mondo fisico, Laterza, Bari, 1987
- Engels F., AntiDhüring, Edizioni Rinascita, Roma, 1950
- Engels F., Ludwig Feuerbach e il punto d'approdo della filosofia classica
tedesca, Editori Riuniti, Roma, 1950 e 1985, (in appendice: Tesi su
Feuerbach)
- Engels F., Dialettica della natura, Editori Riuniti, Roma, 1967
- Feyerabend P. K., Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della
conoscenza, Feltrinelli, Milano, 1979 e 1991
- Feyerabend P. K., La scienza in una società libera, Feltrinelli,
Milano, 1982
- Feynman R., La legge fisica, Boringhieri, Torino, 1993
- Frye N., Anatomia della critica, Einaudi, Torino, 1969
- Gava G., Scienza e filosofia della coscienza, Angeli, Milano, 1991
- Geymonat L., Riflessioni critiche su Kuhn e Popper, Dedalo, Bari,
1983
- Gianquinto A., Critica dell'epistemologia. Per una concezione
materialistica della scienza, Marsilio, Venezia, 1980
- Giorello G., Introduzione alla filosofia della scienza, Bompiani,
Milano, 1994
- Goldmann L., Recherches Dialectiques, Gallimard, Paris, 1959
- Gould S. J., Il pollice del panda, Editori Riuniti, Roma, 1983
- Gould S. J., La vita meravigliosa, Feltrinelli, Milano, 1990
- Gramsci A., Il materialismo storico, Editori Riuniti, Roma, 1975
- Grassi E., L’“esposizione dialettica” nel Capitale di Marx,
Basilicata editrice, Roma, 1976
- Grossi F., Studio sulle rivoluzioni scientifiche nella storia del
pensiero economico, Giuffrè, Roma, 1976
- Hanson N. R., I modelli della ricerca scientifica. Ricerca sui fondamenti
concettuali della scienza, Feltrinelli, Milano, 1978
- Hausman, The inexact and separate Science of Economics, Cambridge
University Press, Cambridge, 1992
- Havemann R., Dialettica senza dogma. Marxismo e scienze naturali,
Einaudi, Torino, 1965, prefazione di C. Cases
- Hayek F., Conoscenza, mercato, pianificazione, Il Mulino, Bologna,
1988
- Hegel G. W. F., Lezioni sulla filosofia della storia, Nuova Italia,
Firenze, 1989
- Heisenberg W., Fisica e filosofia, Il Saggiatore, Milano, 1961
- Heisenberg W., Indeterminazione e realtà, Guida, Napoli, 1991
- Hill C. S., Sensations. A Defense of type Materialism, Cambridge
University Press, Cambridge, 1991
- Hook S., Dialectical Materialism and Scientific Method, FOY & Co,
Manchester, 1955
- Horkheimer M., Studi di filosofia della società, Einaudi, Torino,
1974
- Il'enkov E. V., La dialettica dell'astratto e del concreto nel Capitale
di Marx, Feltrinelli, Milano, 1961, prefazione di L. Colletti "Dialettica
scientifica e teoria del valore"
- Korsch K., Marxismo e filosofia, Sugarco, Milano, 1978
- Korsch K., Dialettica e scienza nel marxismo, Laterza, Bari, 1974
(raccolta di scritti), introduzione G. E Rusconi
- Kuhn T. S., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi
Torino, 1962 e 1970
- Labriola A., La concezione materialistica della storia, Laterza,
Bari, 1965
- Laudan L., Scienza e relativismo, Armando, Roma, 1997
- Lenk K, Marx e la sociologia della conoscenza, Il Mulino, Bologna,
1975
- Lenin (V. I. Ulianov), Materialismo ed empiriocriticismo. Note su una
filosofia reazionaria, Sapere, Milano, 1970
- Lenin (V. I. Ulianov), Quaderni Filosofici, Editori Riuniti, Roma,
1976
- Lorenz K., L’altra faccia dello specchio, Adelphi, Milano, 1980
- Lukacs G., Storia e coscienza di classe, Sugarco, Milano, 1967-1992
- Lukacs G., La distruzione della ragione, Einaudi, Torino, 1959
- Lunghini G., La crisi dell’economia politica e la teoria del valore,
Feltrinelli, Milano, 1977
- Luporini C., Dialettica e materialismo, Editori Riuniti, Roma, 1974
- Mannheim K., Sociologia della conoscenza, Dedalo, Bari, 1974
- Marx K., Il Capitale, Editori Riuniti, Roma, 1968-1970,
- Marx K., Lettere a Kugelmann, Editori Riuniti, Roma, 1976
- Marx K., Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica
1857-1858, La Nuova Italia, Firenze
- Marx K. e Engels F., L'ideologia tedesca. Critica della più recente
filosofia tedesca nei suoi rappresentanti Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e del
socialismo tedesco nei suoi vari profeti Editori Riuniti, Roma, 1958 e 1983
- Marx K. e Engels F., Carteggio, Editori Riuniti, Roma, 1972
- Marx K., Engels F. e Lenin, Sulla Scienza, Dedalo, Bari, 1977
(raccolta di scritti)
- Myrdal G., L’elemento politico nello sviluppo della teoria economica,
Sansoni, Firenze, 1981
- Ossowski S., Struttura di classe e coscienza sociale, Einaudi,
Torino, 1966
- Pheby J., Economia e filosofia della scienza, Il Mulino, Bologna,
1991
- Plechanov G. V., La concezione materialistica della storia,
Feltrinelli, Milano, 1972
- Popper K. R., Scienza e filosofia, Einaudi, Torino 1969
- Popper K. R., Objective Knowledge, Oxford University Press, New York,
1972-73
- Popper K. R., Congetture e confutazioni, Il Mulino, Bologna, 1972 e
1985
- Popper K. R., Poscritto alla logica della scoperta scientifica.
L'universo aperto, Il Saggiatore, Milano, 1984
- Popper K. R., La conoscenza e il problema corpo-mente, Mulino,
Bologna, 1996
- Popper K. R., Tre saggi sulla mente umana, Armando, Roma, 1994
- Popper K. R. e Lorenz K., Il futuro è aperto, Rusconi, Milano, 1989
- Robbins L., La base economica dei conflitti di classe, La Nuova
Italia, Firenze, 1952 e 1980
- Screpanti E. e Zamagni S., Profilo di storia del pensiero economico,
La Nuova Italia Scientifica, Firenze, 1989
- Solo R. A., The Philosophy of Science, and Economics, MacMillan,
Londra, 1991
- Tagliagambe S., L'epistemologia contemporanea, Editori Riuniti, Roma,
1991
- Veca S., Saggio sul programma scientifico di Marx, Il Saggiatore,
Milano, 1977
- Woods A. e Grant T., Reason in Revolt, Wellred Pubblications, Londra,
1995
[1] Si pensi alle tradizioni di Laudan, all’hard core e ai
programmi di ricerca di Lakatos, e così via.
[2] Sebbene non ci sia mai capitato di trovare un perfetto
equivalente della teoria che ora andremo a proporre, alcuni passaggi del libro
di M. Cini Un paradiso perduto, si avvicinano molto a queste idee (pagg.
200 e seguenti). Qualcosa di simile si trova anche negli scritti di Laudan e
Hausman citati in bibliografia.
[3] Ci riferiamo alla teoria dello sviluppo storico di Marx in
generale. Ma soprattutto abbiamo in mente il celeberrimo passo che, seppur un
po’ meccanicamente, la compendia in modo egregio:
“nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in
rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di
produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze
produttive materiali. L’insieme di questi rapporti di produzione costituisce la
struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una
sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate
della coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona,
in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la
coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro
essere sociale che determina la loro coscienza. A un dato punto del loro
sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in contraddizione
con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà (che ne
sono soltanto l’espressione giuridica) dentro i quali tali forze per l’innanzi
si erano mosse.
Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono
in loro catene. E allora subentra un’epoca di rivoluzione sociale. Con il
cambiamento della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta la
gigantesca sovrastruttura. Quando si studiano simili sconvolgimenti, è
indispensabile distinguere sempre fra lo sconvolgimento materiale delle
condizioni economiche della produzione, che può essere constatato con la
precisione delle scienze naturali, e le forme giuridiche, politiche, religiose,
artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che permettono agli uomini
di concepire questo conflitto e di combatterlo. Come non si può giudicare un
uomo dall’idea che egli ha di se stesso, così non si può giudicare una simile
epoca di sconvolgimento dalla coscienza che essa ha di se stessa; occorre invece
spiegare questa coscienza con le contraddizioni della vita materiale, con il
conflitto esistente fra le forze produttive della società e i rapporti di
produzione.
Una formazione sociale non perisce finché non si siano sviluppate tutte le
forze produttive a cui può dar corso; nuovi e superiori rapporti di produzione
non subentrano mai, prima che siano maturate in seno alla vecchia società le
condizioni materiali della loro esistenza. Ecco perché l’umanità non si propone
se non quei problemi che può risolvere, perché, a considerare le cose dappresso,
si trova sempre che il problema sorge solo quando le condizioni materiali della
sua soluzione esistono già o almeno sono in formazione. A grandi linee, i modi
di produzione asiatico, feudale e borghese moderno possono essere designati come
epoche che marcano il progresso della formazione economica della società. I
rapporti di produzione borghese sono l’ultima forma antagonistica del processo
di produzione sociale; antagonistica non nel senso di un antagonismo
individuale, ma di un antagonismo che sorga dalle condizioni di vita sociali
degli individui. Ma le forze produttive che si sviluppano nel seno della società
borghese creano in pari tempo le condizioni materiali per la soluzione di questo
antagonismo. Con questa formazione sociale si chiude dunque la preistoria della
società umana” (Prefazione a Per la critica dell’economia politica,
Editori Riuniti, Roma 1967, pp. 5-6).
|
Kuhn e
la scienza economica (1 - 2)
1. Introduzione: il ruolo del dibattito epistemologico nello sviluppo
scientifico
1.1 Il ruolo del metodo nello sviluppo di una scienza
Gli economisti si interessano poco a questioni epistemologiche. Nella loro
formazione i lati filosofici sono lasciati ai margini se non del tutto
eliminati.
La filosofia della scienza appare allo studente di economia un insieme di
problemi astrusi da cui rifuggire, concentrandosi invece sui ben più seri
modelli ‘pratici’, le cui premesse filosofiche però rimangono del tutto
inespresse. In questo modo si avalla una tendenza a dare per scontate le
premesse delle teorie per concentrarsi sui loro risultati. Si spinge lo studente
a considerare ovvie e obbligate tutte le scelte e le svolte della sua scienza,
lo si invita alla ‘scienza normale’ e a un generale conformismo, necessario in
mancanza di ogni consapevolezza critica della parzialità di ogni paradigma
scientifico[1]. Nessuna materia meglio della storia del
pensiero economico permette di evidenziare questa parzialità, aiutando la
consapevolezza critica di cui si è detto. D’altra parte anche nello studio
storico della scienza economica spesso si espungono gli aspetti di metodo. Per
questo mi sembra importante partire, in questa ricerca, proprio discutendo del
ruolo dell’epistemologia e del metodo per lo sviluppo della scienza e
dell’economia in particolare.
Gli economisti che scrivono di epistemologia tendono a presentare una visione
del ruolo del metodo riduttiva, frutto anche della marginalità della nostra
scienza rispetto allo sviluppo complessivo della filosofia della scienza. In
molti resoconti sullo sviluppo di una teoria ci viene presentata la rassicurante
visione di un ricercatore che, per qualche ragione ignota, trova sulla strada
verso la propria teoria il metodo corretto. Per mezzo di tale metodo, come fosse
la mappa del tesoro, giunge alla teoria corretta. In questa concezione il metodo
ha un ruolo evidentemente primario e soprattutto preventivo. Senza metodo, la
ricerca difficilmente approderebbe a qualcosa.
Tuttavia gli scienziati, quando cominciano la propria attività, hanno spesso
una conoscenza limitata dei problemi epistemologici. Più frequentemente avviene
il processo inverso: lo scienziato fa una ricerca ‘pratica’ negli anni di più
forte vigore fisico e intellettuale, mentre giunto alla fine della propria
carriera, prende a scrivere di problemi di metodo, dispensando consigli ai
colleghi più giovani. A volte si arriva a una giustificazione esplicita di
questa divisione generazionale dei ruoli. Così si sostiene che solo l’esperienza
data da decenni di ricerca sul campo permette allo scienziato di fornire ai suoi
colleghi riflessioni metodologiche utili e sensate.
Queste concezioni, seppur per ragioni diverse, non mi sembra che riescano a
inquadrare efficacemente il rapporto tra il metodo e la teoria o, se vogliamo,
tra l’epistemologia e la scienza.
1.2. Il metodo ‘preventivo’ e il metodo ‘successivo’
Secondo la prima opinione, il metodo è una serie di norme imperative a cui il
ricercatore deve attenersi al fine di fare un serio lavoro scientifico.
L’epistemologia è dunque una disciplina normativa, sostanzialmente etica, che
fornisce le leggi della ricerca alla scienza. Chi osasse mettere in dubbio
queste leggi verrebbe bollato come metafisico, come irrazionalista ecc. Le varie
‘sette’ filosofiche scaturite dall’empirismo logico e anche quelle successive al
suo crollo aderiscono in sostanza a questa concezione. Lo stesso Popper, che
pure fu un critico del neopositivismo, fornisce nelle sue opere principali una
serie di criteri senza i quali lo scienziato non può fare una ricerca degna di
tale nome.
Secondo l’altra concezione, quella ‘successiva’, solo i lunghi anni di
ricerca mettono in grado il ricercatore di fornire preziose indicazioni ai suoi
colleghi più giovani. Indubbiamente l’esperienza sul campo è importante per ogni
scienza. Il punto è che da sola non può fornire una filosofia della scienza,
così come la raccolta di fatti in sé non crea una teoria. Spesso gli scienziati
trasformatisi in filosofi non si sono mai o quasi mai occupati di tali problemi
nel corso della propria attività. Non hanno per lo più nessuna vera organica
concezione filosofica e si sono formati una serie di opinioni epistemologiche in
letture asistematiche, convegni casuali, discussioni ecc. Data la scarsa
elaborazione personale, la tendenza inevitabile è quella di riportare le teorie
filosofiche più alla moda nel campo specifico di appartenenza, in questo caso
l’economia, applicandole come meglio si può. Spesso, per altro, si riportano le
mode di dieci o venti anni prima, cosicché l’economia fa sempre la parte della
disciplina in ritardo che rincorre lo sviluppo dell’epistemologia e delle
branche più sviluppate della scienza accontentandosi dei loro avanzi[2].
Come detto, l’idea che gli anni di pratica scientifica aiutino la
teorizzazione metodologica non è scorretta, il punto è che non si può sostituire
a una seria e costante elaborazione il riassunto delle opinioni dominanti nella
filosofia della scienza di alcuni anni prima. Per capire la radice comune degli
errori di queste due concezioni occorre partire dall’aspetto centrale della
riflessione filosofica, dalla sua base ontologica. Uno scienziato può
considerarsi realista o relativista, idealista o materialista, ma innanzitutto,
per poter procedere su basi salde, deve chiarirsi le idee da un punto di vista
ontologico, ovvero da un punto di vista del rapporto tra il soggetto e il reale.
Ogni essere umano ha una sua ontologia, dunque anche tutti gli scienziati e gli
economisti. Il punto è che quasi tutti gli uomini, compresi gli economisti,
arrivano a un’ontologia in modo inconsapevole, senza riflettere su questi temi.
Di solito gli uomini tendono a credere che quello che vedono e toccano esista
veramente e così gli scienziati. Detto filosoficamente hanno una posizione
ontologica materialista: i loro occhi non riflettono la creazione del proprio
cervello ma oggetti che esistono indipendentemente da noi. Da questo punto di
vista l’ontologia qui descritta sembrerebbe una banalità. In fondo se la gente
tende a non passare con il semaforo rosso è perché crede nell’esistenza
oggettiva dei veicoli che attraversano l’incrocio, e ogni prova in proposito
convincerà chiunque della veridicità della propria posizione, che potremmo
definire, rozzamente, realista. Sulla base di questa prima considerazione
possiamo procedere quindi a studiare come la scienza si origini dal rapporto tra
soggetto e reale e come il metodo a sua volta maturi da questo sviluppo.
Eppure, anche se la maggior parte degli economisti accetterebbe di buon grado
la posizione descritta, rifiutando così il solipsismo filosofico, quando poi si
passa alla teorizzazione concreta, queste posizioni vengono dimenticate e si
propende per un soggettivismo metodologico che contrasta completamente con
quella posizione.
1.3 E' possibile superare questa contrapposizione unilaterale
Le due posizioni presentate non riescono a dar conto del reale rapporto tra
la scienza e il metodo. Il metodo non può essere un insieme di leggi etiche
imposte alla ricerca, né d’altro canto può essere il risultato spontaneo del
lavoro di ricerca. La pura deduzione e la pura induzione sono parimenti
unilaterali e fuorvianti. Il metodo sorge dall’interazione tra la scienza e la
filosofia. L’epistemologia si sviluppa insieme alla scienza. Le scoperte
concrete aprono anche nuovi orizzonti filosofici; allo stesso tempo
l’epistemologia può essere decisiva per indirizzare correttamente la ricerca.
Anche se ci occuperemo della teoria di Kuhn in seguito, già possiamo cogliere la
sua importanza proprio da questi temi. L’idea di una separazione netta tra
scienza ed epistemologia viene superata con il concetto di paradigma che
le compendia.
La teoria economica neoclassica è un esempio chiarissimo. Essa è inseparabile
dal suo metodo riduzionista e soggettivista, il quale orienta la ricerca in ben
precisi ambiti e canali. Non a caso l’individualismo metodologico, una volta
secondario nella teoria macroeconomica, ha modificato e modifica anche questa
branca (come per esempio dimostra il dibattito sulle ‘microfondazioni’),
costringendo tutti i settori della scienza economica a rendersi coerenti alla
propria base metodologica. D’altra parte, gli scienziati che ritengono le teorie
neoclassiche del tutto inutili a spiegare l’economia, si accorgono ben presto
che devono anche sbarazzarsi della filosofia della scienza che ne è la spina
dorsale, altrimenti, tramite questo, giungono nuovamente alle conclusioni
teoriche neoclassiche. Lo sviluppo di metodo e teoria è dunque interattivo,
dialettico. Questo non significa che tra essi non sorgano contraddizioni. Ma
queste contraddizioni devono risolversi in un senso o nell’altro. O prevale la
ricerca empirica, superando i limiti del metodo e giungendo a un nuovo e
superiore rapporto con la filosofia, oppure prevale il metodo e la ricerca
esclude i problemi, le contraddizioni dal campo della scienza ufficiale. Quando
le contraddizioni giungono a mettere in pericolo il rapporto filosofia-scienza,
subentra la crisi del paradigma e il suo declino.
1.4 L’economia e la filosofia della scienza
Se si analizzano le pubblicazioni dedicate dagli economisti a questioni
metodologiche si ha l’impressione di un ampio e profondo dibattito e
complessivamente di un serio interessamento all’epistemologia. In realtà la
situazione mi sembra più fosca. Innanzitutto la filosofia della scienza
dominante si occupa poco di scienze sociali, che considera organicamente
sottosviluppate. I fondatori del circolo di Vienna erano quasi tutti matematici
o logici. I loro padri spirituali (Frege, Russell, Wittgenstein) erano logici e
matematici. Il falsificazionismo di Popper è sorto nella mente del suo creatore
paragonando la teoria di Einstein (una teoria fisica) a quella di Marx (una
teoria sociale) e di Freud (una teoria psicologica).
Ovviamente la relatività faceva la parte dell’esempio buono, il marxismo e la
psicoanalisi quello delle pecore nere. Kuhn è essenzialmente uno storico della
scienza, in particolar modo della fisica. Lo stesso può dirsi per tutti gli
altri principali epistemologi del nostro secolo. La fisica, in queste
concezioni, è sempre la regina delle scienze, la pietra di paragone. L’economia
è una specie di ultima ruota del carro. Gli economisti assecondano totalmente
questa tendenza, prendendo loro per primi la fisica a modello di scienza. Quanto
più una teoria economica si confonde con una teoria fisica, tanto più sembra
inattaccabile. Non solo la fisica è l’esempio di come fare scienza ma
l’epistemologia che da essa si origina viene applicata, o almeno si tenta di
applicarla, tout court all’economia.
Ma l’economia ha implicazioni politiche infinitamente più rilevanti della
fisica e di ogni altra scienza. Certo, le opinioni politiche e sociali
condizionano tutti gli scienziati. Per esempio Heisenberg interpretò il
principio d’indeterminazione in modo tale da giustificare il suo appoggio al
regime nazista in Germania. Un comportamento simile ebbe Konrad Lorenz con
l’etologia. Ma questi sono casi particolari facilmente superabili. Il principio
d’indeterminazione non ha nessuna connessione necessaria con le teorie naziste
né ne ha l’etologia. Nelle scienze naturali, almeno nel medio e lungo periodo,
le incrostazioni ideologiche vengono facilmente smascherate ed emarginate. Non è
così con l’economia, come poi vedremo meglio. Qui basti ricordare che gli stessi
filosofi della scienza hanno agito in modo difforme dai loro standard usuali
quando hanno sostenuto o respinto teorie economiche. Basti ricordare l’esempio
di Popper. Popper si è sempre preoccupato di applicare con severità i controlli
sulla falsificabilità di una teoria fisica. Ma quando si è trattato di teorie
economiche ha agito con altri scopi e ben altra serietà. Di fatto ha scelto
prima la teoria da appoggiare (per ragioni politiche) e quindi l’ha difesa[3]. Proprio l’opposto di quanto il suo metodo impone. Altri
filosofi hanno agito in modo simile.
1.5 Sintesi del presente lavoro
In tutto questo quadro la filosofia della scienza di Kuhn presenta dei
caratteri di novità e di specificità, particolarmente rilevanti per gli studiosi
di scienze sociali. Quando Kuhn pubblicò il suo lavoro più famoso, La
struttura delle rivoluzioni scientifiche, l’idea che l’epistemologo dovesse
spiegare cos’è la scienza più che dire cosa dovrebbe essere, era un’eresia.
Popper, che era il più importante epistemologo del tempo, lanciò un attacco
profondo alle concezioni kuhniane. Ma la migliore prova che la teoria di Kuhn
stava conquistando rapidamente terreno venne data proprio dai seguaci di Popper.
Lakatos, che era l’allievo prediletto e l’erede designato di Popper, elaborò una
teoria, il cosiddetto falsificazionismo sofisticato, che si distingueva
dal falsificazionismo originale, ingenuo, del fondatore proprio in quanto
fortemente ispirata alle teorie di Kuhn[4].
Come vedremo la teoria di Kuhn è nettamente diversa da quelle variamente
neopositiviste. Con Kuhn cambia totalmente il ruolo della filosofia della
scienza e anche il suo rapporto con le scienze concrete. In questa ricerca
intendiamo esporre, succintamente, i punti deboli e i punti forti della teoria
kuhniana, la particolare rilevanza che la sua teoria ha per la scienza economica
e infine vogliamo proporre alcuni approfondimenti necessari per rendere le sue
concezioni pienamente in grado di spiegare la vera natura del progresso
scientifico.
2. Il ruolo di Kuhn nella filosofia della scienza
2.1 I punti forti
La filosofia della scienza di Kuhn è notissima. Non occorrerà dunque
descriverla qui. Sarà invece interessante esporre quelli che sono i suoi
cardini, gli aspetti essenziali e anche più riusciti. Passeremo quindi a
descrivere quelli che appaiono essere i punti infelici, irrisolti della teoria e
infine esporremo brevemente le critiche portate ai concetti qui espressi.
Il primo punto di forza della teoria kuhniana è il suo radicarsi saldamente
nella storia del pensiero scientifico. I libri di Kuhn sono essenzialmente un
commento ragionato alla storia della fisica e della chimica. Essi abbondano di
esempi e casi storici che dimostrano la notevole competenza del filosofo
americano in materia. Da questo punto di vista la novità è chiara. Se si
scorrono le riviste e i saggi in cui gli esponenti del Circolo di Vienna o di
Berlino, ma anche i logici inglesi discutevano di filosofia si vede una sequenza
di teoremi, dimostrazioni logiche, assunti, ipotesi astratte ecc., tutto tranne
che il vero sviluppo della scienza. Kuhn raccontò una volta di come nel 1947,
ancora studente di dottorato, dovette affrontare lo studio della fisica di
Aristotele. Per lui era ovvio che le teorie aristoteliche non contenevano nulla
di rilevante per la scienza di oggi. Ma l’aspetto che lo colpì di più fu proprio
il fatto che tali teorie avevano una loro logica e un loro coerente sviluppo e
che nessuna semplice confutazione empirica avrebbe, allora, potuto scalfirle.
Erano semplicemente un altro paradigma. Questo concetto di paradigma fu
essenziale a Kuhn per interpretare e spiegare lo sviluppo discontinuo della
storia della fisica. Esso è senz’altro un pilastro della sua filosofia. Tuttavia
occorre subito specificare che esso costituisce al contempo un punto forte e un
punto debole.
Detto diversamente: Kuhn non lo ha sviluppato al punto tale da superare le
indubbie ambiguità che lo rendono indeterminato. In seguito vedremo che a questo
scarso sviluppo si può rimediare. Qui occorre ricordare che la scienza, secondo
Kuhn, si sviluppa proprio sulla base di un paradigma condiviso da almeno una
parte degli scienziati. Pensiamo alla meccanica classica, alla meccanica
quantistica e, in economia, alla scuola classica, alla scuola neoclassica ecc.
Un paradigma non è solo un insieme di teorie, né soltanto una concezione in
senso lato del mondo. Esso è a un tempo un insieme di regole di comportamento,
di teorie condivise e sostanzialmente inattaccabili, di un metodo di ricerca e
di demarcazione scientifica e infine un orientamento indispensabile nel lavoro
degli scienziati. Nella carriera di un ricercatore, l’incontro con il paradigma
dominante nella propria disciplina avviene molto presto, almeno in periodi
“normali”, a volte perfino nei primi anni di scuola.
All’università lo studente approfondisce le varie aree di ricerca in cui il
paradigma si suddivide, impara quali sono gli insiemi di norme che regolano la
scienza, impara quali assunti deve considerare immutabili, al di fuori della
critica, e quali sono i problemi all’ordine del giorno, di attualità. Infine, se
intraprende la carriera di ricercatore, si concentra tipicamente in una piccola
area di ricerca, nell’attività di “puzzle-solving”, di scienza normale. Trova,
come è ovvio, difficoltà nel confronto del paradigma con il materiale empirico.
Riesce a risolvere queste difficoltà e, se è brillante, da queste difficoltà fa
avanzare il paradigma e lo sviluppa. La ricerca è essenzialmente scienza
normale. Quale scienziato intraprende una ricerca in un campo ben sviluppato con
l’intento di trovare i dati per rovesciare la teoria stabilita? Nessuno, né lo
si pretenderebbe. Ma, sosterrebbe un falsificazionista, dovrebbe almeno
sottoporre la propria teoria a test i più severi possibili in modo da
corroborare la stessa.
Eventuali difficoltà dovrebbero portare a capire che la teoria va
abbandonata. In realtà, come dimostrato dal filosofo americano, la scienza
normale ha un ruolo preciso e soprattutto necessario nello sviluppo di una
teoria e nessuna ‘protesta’, seppur qualificata come quella di Popper, potrebbe
farla scomparire. Kuhn, tra i primi, ha evidenziato che la scienza si sviluppa
dunque in modo discontinuo, all’interno di un paradigma la cui struttura
fondamentale rimane immutata finché non subentra una crisi, il declino ed alla
fine la sostituzione. Kuhn ha introdotto il concetto di “anomalia” per dar conto
di questo processo. Nella ricerca lo scienziato trova dei problemi, delle
anomalie che la teoria, nonostante tutta l’inventiva del ricercatore, non riesce
a eliminare. Il caso classico è l’orbita di Mercurio che, seppur descritta
egregiamente dalla meccanica newtoniana, presentava delle irregolarità
inspiegabili. Le anomalie segnalano l’arresto della fase progressiva del
paradigma. Da motore di sviluppo il paradigma diviene in qualche modo un freno
ad ulteriori sviluppi e le difficoltà si accumulano e si rafforzano.
A questo punto le concezioni alternative poste fino ad allora ai margini
della scienza, oppure concezioni che sorgono ex novo, possono attirare sempre
più ricercatori. Si instaura un’epoca di transizione che può durare anche un
considerevole lasso di tempo, ma spesso è breve. Infine il nuovo paradigma viene
riconosciuto, le vecchie teorie vengono spiegate all’interno delle nuove o
rifiutate. E' curioso, e Kuhn lo fa notare molto acutamente, che la storia della
scienza dominante non segnali affatto queste discontinuità e questi cicli di
crisi e di dominio. Ogni volta che un paradigma prende il sopravvento, avviene
una riscrittura della storia che ricorda quella descritta da Orwell in
1984.
Tutta la storia della disciplina viene a quel punto interpretata, quasi
escatologicamente, come una serie di tappe che portano all’avvento del paradigma
dominante[5]. Si segnalano i precursori, che improvvisamente si
moltiplicano, si redarguiscono i rappresentanti delle vecchie concezioni e si
riporta la ricerca nell’alveo della scienza normale, solo su altri fronti.
Possiamo dunque dire che l’aspetto decisamente progressivo e innovativo della
teoria di Kuhn è la presa d’atto della vera forma di sviluppo della scienza.
Nella scienza ci sono rivoluzioni, cambiamenti profondi che trasformano le
teorie, i metodi, le prassi accettate, il modo di essere dello scienziato. Esse
si alternano a lunghi periodi di evoluzione graduale in cui la scienza normale
sviluppa e incanala la ricerca in modo da trarre il massimo possibile dal nuovo
paradigma.
2.2 I punti deboli
Se il punto forte della concezione kuhniana è il riconoscimento che
descrivere il vero significato storico della scienza è il primo passo per
capirne il funzionamento, il punto debole sta nel fatto che lo storico che si
limiti a descrivere i fatti della cronaca, produce un racconto superficiale e
non una vera analisi storica. Non basta descrivere i fenomeni, occorre
spiegarli. Occorre cioè proporre dei nessi causali che spieghino il
concatenamento dei processi in un modo necessario. Questo in Kuhn manca
totalmente. Egli non riesce a spiegare perché ci sono le rivoluzioni
scientifiche, perché si susseguono a fasi di scienza normale. Sarebbe come se un
biologo scrivesse che a fasi alterne, gli animali si accoppiano, fanno un figlio
e si riaccoppiano, senza spiegare perché fanno queste cose e che nessi vi sono.
La teoria di Kuhn è dunque una pura, ancorché lodevole e realistica, descrizione
della scienza. Questo lato descrittivista inficia anche l’analisi delle
anomalie. Si può infatti obiettare a Kuhn che la stessa identica anomalia è
stata trascurata per decenni o secoli ed è divenuta cruciale in seguito. Qual è
la vera origine delle crisi dei paradigmi? A questo il filosofo americano non
può dare risposta.
2.3 Le critiche
Le varie critiche portate alle concezioni kuhniane seguono, naturalmente, i
punti deboli, reali o presunti, di esse.
Kuhn è stato attaccato sin dalla pubblicazione del suo libro, nel 1962, a
causa della vaghezza del concetto di paradigma. C’è addirittura chi si è
divertito a contare ventitré modi diversi di usare questo concetto[6], e lo stesso Kuhn ha ammesso tale vaghezza. Tuttavia la
correzione da lui tentata non è servita. Infatti la “matrice disciplinare” al
posto del paradigma non cambia granché, anche se orienta maggiormente la teoria
verso un’analisi sociale della scienza[7]. Il punto è che con
il concetto di paradigma Kuhn vuole intendere molte e diverse cose. Vedremo in
seguito come sia possibile superare questa vaghezza.
L’altra grande critica che si fa a Kuhn è che questi sembra giustificare e
anche favorire il ruolo della scienza normale fra gli scienziati, accentuando
così la conservazione e la “pigrizia” epistemologica. Su questo punto il più
feroce avversario dello storico della scienza americano è sicuramente Popper,
che vede la scienza normale come un crimine contro l’umanità, una barbarie.
Popper arrivò a dire che la scienza normale esiste ma “è una cosa di cui bisogna
vergognarsi”[8]. Entrare in questo importante dibattito ci
porterebbe fuori strada. Quanto ci interessa è vedere se la scienza normale è
veramente così dannosa e che ruolo ha nell’economia. Iniziamo proprio dalle
posizioni di Kuhn.
A dire il vero Kuhn non giustifica la scienza normale nella sua opera
principale. Piuttosto ne fornisce una spiegazione. In linea con il suo indirizzo
che è quello di fare epistemologia descrittiva, egli vuole semplicemente dar
conto della realtà innegabile della scienza normale. Dire, come fece Popper, che
chi la fa deve vergognarsi è sterile perché utopistico. Come disse Spinoza “non
ridere né piangere ma capire". E in questo caso capire significa afferrare il
ruolo della scienza normale nella crescita della conoscenza. E' noto che Popper
ironizzando ha esaltato, nei suoi libri, la parola d’ordine marxista della
“rivoluzione permanente” che per lui è la base dell’onestà intellettuale quando
si fa scienza. Ma ha sempre dimenticato che anche le rivoluzioni sociali sono
eventi particolari che durano un ben limitato periodo di tempo che aprono un
epoca di sviluppo graduale permesso proprio dalla rivoluzione.
Le rivoluzioni, nella storia della società e della scienza, hanno un ruolo
necessario ma sono eventi rari che trasformano la situazione (nella produzione,
ovvero il sistema produttivo, e nella scienza, ovvero il paradigma) elevandola a
nuovi livelli e dando così il via a un’epoca di sviluppo su nuove e superiori
basi. La realtà cambia non linearmente, attraverso periodi caotici di repentini
sconvolgimenti e poi con periodi di lunga evoluzione graduale[9]. La scienza nel suo progredire riflette la non linearità della
storia (non solo di quella economica). In periodi di sviluppo graduale sia nella
produzione che nella scienza, quali stimoli vengono per fare scienza
rivoluzionaria? Certamente gruppi isolati possono farne, ma a livello della
massa degli scienziati l‘attenzione sarà orientata a consolidare la teoria che
si ha. Fare scienza normale è solo marginalmente una necessità
logico-strutturale della scienza (la necessità di organizzare le novità,
eliminare le contraddizioni, formalizzare i risultati, ecc.).
E' piuttosto una caratteristica storica, sociale e quindi varia con i periodi
e con la società. Essa varia anche da scienza a scienza in dipendenza del
rapporto fra scienza, società e ruolo dello scienziato. Per esempio è chiaro che
la matematica è più “conservatrice” dell’economia. Infatti è influenzata dallo
sviluppo sociale solo nel lunghissimo periodo e ha una struttura logica che
tende molto di più ad accumulare teorie e risultati rispetto ad altre scienze.
Nelle scienze sociali il rapporto fra realtà e lavoro dello scienziato ci
permette di stabilire un contatto concreto tra sviluppo economico e scienza.
Durante i periodi rivoluzionari avvengono i cambiamenti di paradigma. Il ruolo
della scienza normale è invece quello di scegliere le teorie del periodo
rivoluzionario che più sono funzionali al nuovo ciclo di sviluppo.
Questo non implica che la scienza rivoluzionaria ci sia solo in periodi di
crisi. Come detto questo è vero solo a livello complessivo. Il singolo
scienziato può riflettere la realtà sociale in ogni modo. C’è sicuramente una
certa autonomia della teoria e del suo creatore rispetto alla realtà. Ma di
solito l’autonomia non è mai tanto forte né tocca più di qualche individuo.
Insomma il ruolo della scienza normale in economia non deve valutarsi secondo
criteri romantici, come fa Popper. Non ci rincresce se uno scienziato fa scienza
normale perché non è critico o non lotta per falsificare la sua teoria. La
scienza normale riflette, in ultima analisi, un’epoca di pace sociale.
Avendo esposto succintamente i punti forti, i punti deboli e le critiche
principali che riguardano la teoria dello sviluppo scientifico di Kuhn,
passeremo, nella seconda parte, a legare tale teoria alla scienza economica,
approfondendo infine alcuni aspetti di questo rapporto.
3. Kuhn e l’economia: lo sviluppo ciclico della scienza
La teoria di Kuhn descrive lo sviluppo di un ciclo di ascesa, dominio e crisi
di un paradigma come il normale percorso con cui progredisce la scienza. La tesi
che esistano dei cicli nella storia del pensiero economico è stata espressa
chiaramente già da Schumpeter che anticipò Kuhn di qualche anno. Le somiglianze
tra le due concezioni, la teoria di Schumpeter e la teoria kuhniana della
scienza, sono molteplici. Occorre tuttavia notare che, come ricordato, la
filosofia di Kuhn è nata dallo studio delle scienze naturali, nelle quali lo
sviluppo della società si riflette molto poco. Restiamo dunque delusi nella
nostra attesa di una spiegazione soddisfacente dei cicli che pure sono
innegabili nella storia del pensiero economico. Lo studio della storia delle
scienze sociali e dell‘economia in particolare suggerisce un modo per rendere
più realistico e aggiornato il modello kuhniano. Infatti nelle scienze sociali
il legame tra conflitti sociali e dinamiche teoriche è molto stretto. Questo fa
sì che le anomalie puramente logiche contino poco rispetto alle esigenze
sociali, nella lotta fra i paradigmi e nel paradigma. L’economista, più o meno
coscientemente, difende nella teoria una posizione politica e sociale. La
dinamica dei paradigmi dipende perciò dal rapporto di forza delle classi in
quella data epoca. Parafrasando Marx potremo dire che “tutta la storia è storia
di lotta di classe e relativi paradigmi scientifici”.
L’economia, dato il suo particolare legame con la società, presenta dunque
uno sviluppo altrettanto particolare. Le rivoluzioni scientifiche in economia
sono fortemente connesse alle svolte decisive nello sviluppo del capitalismo,
esse ne sono una rappresentazione teorica. Questo legame tra economia e società
è appunto il nesso mancante nella teoria kuhniana. Studiando la storia del
pensiero economico invece vediamo chiaramente questi legami. Le ‘anomalie’ con
cui i primi neoclassici hanno seppellito la teoria di Smith e Ricardo erano
problemi che gli economisti classici consideravano risolti da tempo. Non è per
questi problemi però che la scuola classica è stata emarginata! Allo stesso modo
la vittoria delle concezioni interventiste keynesiane non è derivata da una
superiore esplicatività della General Theory rispetto alla scuola
neoclassica, essa piuttosto rifletteva l’impasse del capitalismo mondiale dovuto
alla Grande Crisi. Passata questa, la scuola keynesiana è stata pian piano
espunta dall’analisi economica mainstream. Si è addirittura giunti a
interpretare in senso monetarista la Grande Crisi, come se fosse una novità,
come se i monetaristi non ci fossero stati anche negli anni ‘30. Solo che
allora, prudentemente non proponevano le proprie interpretazioni[10].
Se si accetta la connessione tra economia e società si vedrà chiaramente che
la teoria di Kuhn non solo può spiegare egregiamente la storia del pensiero
economico ma ne può fornire una suddivisione razionale. E' in questo cambiamento
che Kuhn può aiutare la nostra disciplina Al contempo la storia del pensiero
economico può fornire i nessi causali che Kuhn non si preoccupò di
stabilire.
4. Sviluppi della teoria di Kuhn
4.1 La “stratificazione” paradigmatica
Abbiamo visto come il concetto di paradigma, per via della insufficiente
strutturazione fornitagli dallo stesso Kuhn, si sia dimostrato uno strumento
troppo vago di analisi storica.
A mio avviso, questo problema si risolve partendo dal fatto che tale concetto
può essere reso stringente se applicato alle stesse “grandezze”. Intendo dire
che l’errore di Kuhn è quello di usare lo stesso concetto per spiegare sia la
struttura generale del paradigma, fatta di molteplici teorie, decine di teoremi,
con molti scienziati, molta scienza normale e così via (pensiamo al paradigma
neoclassico in economia o al paradigma newtoniano), sia piccole scuole che sono
inserite a loro volta in tradizioni più ampie e infine nel paradigma generale
come in una matrioska. Poiché egli non distingue tra scienza (sia normale che
rivoluzionaria) che incide su tutto il paradigma complessivo e quella che tocca
solo la ridotta cerchia della scuola alla base del paradigma,
Kuhn è costretto a mettere sullo stesso piano una rivoluzione scientifica
epocale, fondamentale, come la nascita della fisica quantistica, o la teoria di
Darwin, e rivoluzioni rilevanti solo nell’ambito di una branca secondaria di una
sottoscuola del paradigma[11]. Insomma il concetto di
paradigma, per mantenere il notevole potere esplicativo che, a mio giudizio,
potrebbe avere, deve essere stratificato cioè applicato a livelli diversi
della tradizione scientifica. Esisterà perciò il paradigma come struttura
generale e poi avremo un albero ramificato fatto di livelli sempre più piccoli,
rametti attaccati a rami più grossi collegati a loro volta al tronco, nei quali
sempre meno scienziati vanno elaborando una propria visione del paradigma
all’interno prima di poche grandi scuole e poi di piccoli gruppi che vanno
espandendo il paradigma come le fronde di un albero. Ne risulterà una
stratificazione paradigmatica che ci permetterà di capire come possano
esistere rivoluzioni scientifiche che riguardano solo una parte del paradigma
complessivo.
Questo spiega anche come sia possibile all’interno dello stesso paradigma una
guerra tra scuole rivali. Che sia perché le teorie dello stesso paradigma sono
più commensurabili fra loro, o forse perché hanno fini convergenti, è però un
fatto che la lotta intraparadigmatica è stata spesso più feroce di quella contro
i paradigmi rivali. La stratificazione paradigmatica ci aiuta a capire perché,
trasformando il concetto di paradigma in una serie di assunti a livelli sempre
più generali. Ma per eliminare la vaghezza del concetto di paradigma occorre
anche ancorarlo a livello storico. Infatti Kuhn non ha mai spiegato come poteva
mutare il paradigma nei vari periodi, anzi egli trasse esempi scientifici
indifferentemente da tutti i periodi storici. Ma la qualità e la quantità degli
scienziati varia nel tempo.
Il concetto di paradigma come scala di stratificazioni successive serve
proprio per tentare di spiegare il paradigma nei vari periodi storici. Non è la
stessa cosa se dieci persone si occupano di una teoria o se gli studiosi sono
10mila. Se la quantità deve a un certo punto diventare qualità il paradigma
muterà col tempo. Ecco perché i vari paradigmi sono sempre più stratificati. In
presenza di questa realtà storica è ovvio che il concetto di paradigma tout
court non funziona. Perché viene applicato a livelli diversi fra loro. L’idea è
che se al posto del concetto di paradigma come tradizione scientifica
indifferenziata, poniamo il concreto operare a diversi livelli del paradigma,
riusciremo a spiegare le varie lotte fra le scuole e altre questioni che erano
“anomalie” nella teoria pura di Kuhn. L’esempio della sintesi neoclassica può
essere utile a vedere come la modifica qui proposta funzioni.
La sintesi neoclassica ha avuto al suo interno una serie enorme di varianti,
scuole, interpretazioni. Tutti piccoli pezzi del paradigma complessivo. Le
interpretazioni del paradigma erano diverse ma non tanto da mettere in dubbio il
nucleo fondamentale della teoria comune. Ma due scuole di questo paradigma
potevano avere in comune anche molto poco. Si poteva andare da neoclassici puri
che usavano il modello IS-LM solo per ortodossia, a keynesiani che mal si
adattavano alla storpiatura operata alle concezioni dell’economista inglese.
Comunque si andava avanti nello stesso paradigma. Poi irruppero nuove scuole.
Per esempio, il monetarismo fa parte forse di un altro paradigma? In fondo se
Friedman e gli altri monetaristi hanno potuto dibattere così tanto con i
“neokeynesiani” è proprio perché condividevano quasi tutti gli assunti base del
modo di fare scienza[12]. I monetaristi e i neokeynesiani
combattevano dunque una lotta intraparadigmatica. Negli ultimi due decenni è
venuta alla ribalta la teoria delle aspettative razionali. Essa è un’altra
interpretazione del paradigma “neokeynesiano”? Oppure un altro paradigma? I
teorici delle aspettative razionali sono solo monetaristi più conseguenti e
“duri” o hanno fatto una rivoluzione scientifica creando un nuovo paradigma? A
mio parere essi non hanno lottato più per la loro interpretazione del paradigma,
ne hanno fatto un altro.
E qui sorge il problema di come decidere che cos’è scienza rivoluzionaria.
Infatti perché possiamo dire che Lucas, Sargent e Wallace hanno fatto una
rivoluzione scientifica e Friedman o Tobin no? Restare nel paradigma dominante
vuol dire per forza fare scienza normale? Nella concezione kuhniana questo è
inevitabile perché la scienza rivoluzionaria è orientata solo alla costruzione
di nuovi paradigmi. Ma se concepiamo il paradigma come stratificazione storica e
teorica di scuole che hanno anche poco in comune, possiamo concepire scienza
rivoluzionaria anche all’interno del paradigma iniziale. Poiché la scuola opera
a un livello più basso del nucleo centrale, essa potrà anche essere
eterodossa all’interno del paradigma ortodosso. Inoltre essa potrà lottare per
“riformare” il paradigma senza uscirne, se crede che possa offrire ancora spunti
utili alla ricerca. I monetaristi hanno fatto anche loro una rivoluzione
scientifica, come gli aspettativisti, ma senza rompere con il paradigma
dominante, piuttosto lottando per sconfiggere l’interpretazione allora dominante
del paradigma. Potremo avere così situazioni in cui scienziati ortodossi fanno
scienza rivoluzionaria mentre “eretici” fanno una piatta scienza normale.
Penso di aver chiarito con questo paragrafo come si possa buttare l’acqua
sporca (vaghezza del concetto) senza il bambino (concetto di paradigma). Basta
adattarlo alla realtà sociale che cambia. Anche qui le intuizioni di Kuhn sono
veramente feconde. Occorre solo approfondire il rapporto scienza-società, che
Kuhn ha comunque impostato, rispetto al fisicalismo puro dei suoi
predecessori.
4.2. Sulla struttura del paradigma scientifico
Se si accetta che il paradigma non è un mare magnum nel quale navigano
indistintamente scienziati che la pensano più o meno allo stesso modo, ma è una
serie di restringimenti successivi, tanto più definibile quanto più si proceda
verso “cerchi” meno ampi, si dovrà anche interpretare diversamente il concetto
di rivoluzione scientifica. Come ricordato, uno dei problemi che la descrizione
kuhniana dell’attività scientifica pone, è che sembra che l’accumulo inesorabile
delle anomalie generi un effetto soglia capace di costringere gli scienziati a
cambiare paradigma.
Ma poiché è immediatamente ovvio a chiunque conosca la storia di una
qualsiasi scienza che non c’è mai questo effetto diretto e necessario di
anomalie sulla teoria dominante, l’esito della descrizione di Kuhn può essere un
ritorno all’idealismo, al relativismo e infine all’irrazionalismo. La principale
critica che abbiamo infatti rivolto a Kuhn è che il suo modello di scienza
descrive come avvengono le rivoluzioni nella scienza, ma non riesce mai
ad arrivare al perché esse avvengono. Non a caso le due tendenze che si
sono susseguite ai suoi lavori sono l’anarchismo metodologico e la sociologia
della conoscenza, le quali sono entrambe varianti del più classico
soggettivismo. Se non si è in grado di fornire una base scientifica alla
struttura delle rivoluzioni scientifiche, la strada obbligata è quella di
considerarle il risultato di una lotta puramente ideologica e politica delle
varie scuole. Da qui si passa a eliminare ogni riferimento al mondo reale: le
scuole combattono e chi vince decide cos’è la realtà.
Perché, invece, una teoria vince?, perché un paradigma sbaraglia i
concorrenti? Deve sempre esserci un cambiamento nella situazione oggettiva
perché la scienza, che di questa realtà è una riproduzione astratta, possa
subire a sua volta una trasformazione. Il cambiamento non è per forza una
scoperta nella scienza stessa, anzi questa scoperta, che spesso assume come
prima cosa la funzione di anomalia, è proprio una conseguenza della nuova
situazione. Che cosa s’intende per nuova situazione? Ovviamente dipenderà dalla
scienza in esame. Per le scienze sociali si tratterà di un nuovo modo di
produzione o di una nuova fase del modo di produzione. Per le scienze naturali
lo sviluppo della società ha riflessi sia diretti sia indiretti.
Non solo gli scienziati rispondono alle mutazioni sociali, ma il progresso
sociale ha delle evidenti ricadute tecnologiche e scientifiche che formano la
base per una rivoluzione scientifica. Con ciò leghiamo il concetto di
rivoluzione scientifica a una trasformazione reale. Occorre però spiegare come
la nostra proposta di stratificazione paradigmatica incida sul concetto di
rivoluzione scientifica. La nostra idea è che, come nella realtà, nella
struttura delle rivoluzioni scientifiche si alternano fasi di cambiamento
graduale, di lenta evoluzione che si mutano improvvisamente in brusche rotture,
in violente trasformazioni del reale e della scienza. In queste fasi di
passaggio, di crisi, tutta la struttura del paradigma subisce delle scosse
violente.
Gli scienziati sono portati a criticare tutte le assunzioni della propria
scuola, ogni principio, anche i più sacri, viene analizzato criticamente e
rovesciato. In questi periodi nascono i nuovi paradigmi, in questi scenari gli
scienziati da puzzle-solver si trasformano in innovatori della scienza e del
reale. Quando la situazione ha trovato un pur precario equilibrio, quando un
nuovo e più alto punto di assestamento è stato trovato a livello sociale, anche
la scienza si avvia a una fase di assestamento, iniziando una nuova fase di
lento progresso. La temperatura delle dispute scientifiche inizia ad abbassarsi
e dal crogiolo della critica teorica e pratica prende forma il nuovo paradigma.
Una volta che esso è formato, almeno nei suoi tratti fondamentali scientifici e
soprattutto ideologici, metodologici, politici, tutta la critica al
paradigma si trasforma in critica nel paradigma. Non bisogna credere che
nelle fasi di scienza normale non succeda nulla. Anche da un puro punto di vista
intellettuale l’attività di semplice puzzle-solving non stimolerebbe abbastanza
a rimanere in un certo paradigma.
Comincia così la lotta tra le scuole per la conquista del paradigma. Il
paradigma ha ora abbastanza spazio per far pensare agli scienziati di poter
procedere riformando l’esistente, anziché trasformando la realtà. In questo c’è
un evidente e necessario parallelo tra lo sviluppo della società e della
scienza. Quando un nuovo modo di produzione emerge dalle rovine del precedente,
la classe che domina la produzione assume un ruolo progressista nella storia e
ha di fronte a sé secoli di sviluppo del modo di produzione che dirige. Le
trasformazioni sociali, come quelle della scienza, non avvengono quando qualche
persona lo decide, fosse anche la maggioranza. Arriva un momento in cui il modo
con cui la società, e di conseguenza la scienza, è organizzata non riesce più a
incrementare le risorse, ovvero è un freno all’ulteriore sviluppo.
Si apre allora un’epoca, anche molto lunga, in cui la trasformazione diventa
una possibilità e una necessità. Così come, la scienza, nonostante la struttura
della meccanica classica, con i suoi sistemi isolati e il suo riduzionismo,
doveva di necessità imbattersi nella non meccanicità e linearità dell'universo,
anche se non era affatto detto che dovesse farlo con quelle esatte modalità, con
gli esperimenti di Rutherford, le teorie di Planck, Einstein ecc. Sintetizzando
possiamo dire che, mentre la costruzione di nuovi paradigmi è l’esito di
processi rivoluzionari, sociali, reali e anche scientifici, la
stratificazione paradigmatica, la divisione in frazioni diverse dello stesso
paradigma è la conseguenza di un periodo di relativa tranquillità o comunque di
trasformazioni relativamente ridotte. L’idea di Kuhn che il proliferare di
versioni del paradigma sia la dimostrazione di una sua crisi è dunque
superficiale e va a mio giudizio scartata. Il proliferare di versioni del
paradigma è invece una fase necessaria nello sviluppo scientifico e prepara le
rivoluzioni e le nascite dei nuovi paradigmi.
La situazione di lotta tra teorie è dunque molto variegata. La distanza tra
esse e i modi con cui si combattono, dipendono sempre dalla situazione esterna
al paradigma stesso. Ci possono essere periodi in cui scuole che pur
appartenendo allo stesso paradigma, subiscono una sorte molto differente, e
sembrano andare ognuna per la sua strada, costruendo versioni contrastanti del
paradigma. Questo è lampante nel caso della teoria neoclassica: nel dopoguerra
le varie scuole neoclassiche non solo si sono differenziate, ma si sono
combattute aspramente. Probabilmente questa estensione del concetto di paradigma
non eviterebbe l’accusa di vaghezza rivolta anche a Kuhn. E un kuhniano
ortodosso vorrebbe forse evitare la spiacevole idea che ci siano lotte
all’interno del paradigma. Occorre però vedere la stratificazione del paradigma
generale in livelli tali che scuole diverse si combattano aspramente pur
accettando quel tanto o quel poco bastante a contenerle nello stesso paradigma.
La rivoluzione scientifica può dunque avvenire a livelli diversi, può
coinvolgerlo tutto oppure solo una parte.
4.3 Le lotte all’interno del paradigma
Il processo di attribuzione dell’insuccesso empirico è basilare per capire
come avvenga la lotta tra paradigmi e nel paradigma. E' inutile ribadire che in
realtà una teoria non si farà mai sconfiggere da un fatto, come credeva un tempo
Popper, piuttosto è nel conflitto tra teorie e paradigmi che si inserisce
l’interpretazione dei dati empirici. Nutriamo ben poca fiducia nel ruolo
dirimente dei ‘fatti’, soprattutto nelle scienze sociali e non solo per motivi
metodologici. Comunque è evidente che una teoria è colpita da un fatto nella
misura in cui un’altra ne è favorita, e quando nessuna teoria ha da proporre
niente riguardo a un argomento, ciò è indice di grave difficoltà della
disciplina.
Dato quel che si è detto sulla stratificazione paradigmatica, le anomalie non
possono più considerarsi nemici omogenei di un paradigma. In realtà possono
colpire più scuole di paradigmi diversi che due scuole dello stesso paradigma.
Arriviamo così al problema centrale della lotta teorica. Dobbiamo qui
distinguere due tipi principali di scontri: da un lato ci sono le lotte tra
paradigmi, lotte che si svolgono come descritto da Kuhn con il predominare
di volta in volta di un paradigma che esilia il resto della scienza e riscrive
la storia a propria glorificazione. Ma ci sono anche le lotte
intraparadigmatiche. Queste non solo non sono meno forti e frequenti ma sono
a volte più interessanti ai fini della crescita della conoscenza e della stessa
storia della scienza moderna. In ogni caso non è una scelta che spetta al
soggetto quella di creare un nuovo paradigma o di lottare per una sua
riforma.
Se una scuola accetta i capisaldi del paradigma, non rivolgerà le armi contro
essi fintantoché non ne intenda uscire. Al soggetto potrà forse sembrare una
decisione consapevole, ma come detto la scelta della rivoluzione o della riforma
del paradigma si basa su un processo oggettivo. Nel periodo di lotta all’interno
della teoria comune una scuola attaccherà direttamente la rivale su questioni
che le dividono. Lo sbocco della lotta non dipende ovviamente da questioni
teoriche né empiriche, tuttavia in linea di massima se si arriva a una sconfitta
abbastanza decisa, il vittorioso tenterà di omogeneizzare gli altri livelli al
suo, imponendo la sua visione del paradigma. Riprendendo l’esempio della sintesi
neoclassica: essa ha avuto un successo nel monopolizzare la ricerca scientifica
almeno per quarant’anni. Al suo interno era difficile trovare due economisti che
avessero le stesse idee e le frazioni abbondavano, eppure il paradigma ha retto
fino agli anni ‘70.
Il risorgere dei cicli di recessione e crescita, dopo 25 anni di forte boom,
la stagflazione, il riaccendersi dei conflitti sociali ecc., hanno segnato la
crisi del paradigma. Come possiamo affermare che il monetarismo di Friedman era
solo una scuola del paradigma della “sintesi” e il monetarismo di Lucas e degli
altri aspettativisti è una nuovo paradigma? Non basterebbe ovviamente né il
ricorso alle conclusioni analitiche a cui arrivano, né un’analisi dei loro
rispettivi strumenti concettuali. E' l’analisi della realtà a suggerirci la
sistemazione della crescita della conoscenza. La trasformazione della situazione
reale ha portato alla nascita del nuovo paradigma. Questo esempio, tracciato qui
schematicamente, dovrebbe chiarire quali sono le forze propulsive che decidono,
fondamentalmente, lo sviluppo della scienza e dei paradigmi.
In sintesi, quello che è importante notare è che le diatribe scientifiche non
si svolgono solo tra paradigmi diversi, durante i periodi di rivoluzione
scientifica. Ci sono anche lotte tra tendenze e scuole dello stesso paradigma (e
con scuole di altri paradigmi ovviamente), durante le fasi di evoluzione
graduale della scienza. Crediamo che una volta comprese le ragioni oggettive per
cui si alternano rivoluzione ed evoluzione e dunque scienza rivoluzionaria e
scienza normale, si abbia la chiave per comprendere come si svolgono le lotte
scientifiche tra e nei paradigmi.
4.4 Crescita della conoscenza e cambiamenti sociali
Lo sviluppo della scienza è fortemente collegato con lo sviluppo della
società nel suo insieme e almeno da un certo punto in poi questo diviene un
processo circolare in cui le nuove conoscenze scientifiche permettono un aumento
nella produttività sociale e quindi uno sviluppo nelle forze produttive. Nel
capitalismo il processo circolare diviene sempre più stringente, con il
risultato che la rincorsa fra scienza e sviluppo dei mezzi di produzione si fa
rapidissima. La scienza naturale fornisce la base tecnica per lo sviluppo
economico, l’economia dovrebbe fornirne la spiegazione sociale.
Molto spesso si fa fatica a concepire la scienza come un prodotto di classe
perché si pensa alla scienza come alle teorie delle scienze naturali. Come
possono gli elettroni, le cellule, gli idrocarburi, essere un prodotto di
classe? Il fatto è che la scienza non è solo l‘elettrone, ma soprattutto il
ruolo che la meccanica quantistica ha nella società e il riflesso sociale che
l’elettrone ha sulla società. Per usare la denominazione di Popper: non è il
mondo uno, ma il mondo due e tre che la scienza va a modificare direttamente.
Non dimentichiamoci che i quark sono esistiti per miliardi di anni prima che noi
arrivassimo al grado di sviluppo necessario per capire che c’erano. Il fatto che
noi parliamo di scienza come un prodotto sociale e dunque, poiché la società è
divisa in classi, di classe, non significa che gli elettroni sono stati scoperti
perché esiste la borghesia o l’elettricità perché esistevano gli schiavi. Questo
sarebbe idealismo alla Berkeley. E' ovvio che gli elettroni, come detto, sono
una realtà naturale, preborghese e preumana. Ma che cosa significano gli
elettroni per la nostra epoca? Uno dei costituenti della materia? Certo, ma
soprattutto significano l’energia nucleare, ecc. Riassumendo: la scienza è il
prodotto delle conoscenze della società a un dato grado del proprio sviluppo. In
quanto tale il suo metodo, le sue applicazioni e i suoi rapporti col processo
produttivo e cioè le sue qualità fondamentali, sono legate al ruolo che in
questa fase le varie classi hanno nella produzione.
4.5 Conclusioni: come la teoria di Kuhn può aiutare gli economisti e
viceversa
In questa breve ricerca si è tentato di dimostrare l’importanza della
filosofia di Kuhn per l’analisi storica del pensiero economico. Si è anche
mostrato come tramite la struttura dello sviluppo scientifico proposto dal
filosofo americano sia possibile capire l’andamento ciclico e discontinuo della
scienza. Al contempo si è osservato come l’economista debba andare oltre il
modello kuhniano per poter apprezzare veramente il significato della storia del
pensiero economico. La base sociale delle rivoluzioni scientifiche è molto più
importante della semplice struttura logica dei paradigmi. Dalla storia della
nostra scienza ci giunge un aiuto insostituibile per comprenderne gli sviluppi
presenti e le sue linee di tendenza.
Kuhn ci ha insegnato quanto poco utili siano le storie della scienza basate
sulla glorificazione della teoria dominante, quanto poco lungimiranti e
ideologicamente distorte. In questo senso gli economisti dovrebbero veramente
imparare molto di più dalla storia della propria scienza che dalla sua
modellistica contemporanea.
L’economia però non ha solo da apprendere dalla filosofia kuhniana. Essa può
anche dare degli apporti decisivi per un suo approfondimento. Senza la
spiegazione del rapporto tra sviluppo sociale ed economico e riproduzione
scientifica di questo processo la teoria di Kuhn rimane sospesa a mezz’aria, una
sorta di ritratto realistico che però non si è in grado di attribuire a nessun
personaggio concreto. L’economia fornisce anche degli esempi fondamentali per
superare la vaghezza del concetto di paradigma tramite una sua stratificazione e
ramificazione nel senso che qui abbiamo delineato. Proseguendo nel senso che si
è abbozzato in questo lavoro, un’analisi critica della storia del pensiero
economico e la filosofia della scienza di Kuhn possono illuminare la via del
ricercatore sia all’indietro, per comprendere la storia passata della propria
disciplina, sia in avanti, per afferrarne i principali sviluppi futuri.
BIBLIOGRAFIA
Opere di autori vari
- Il disagio degli economisti
- , La Nuova Italia, Firenze, 1976,
presentazione R. Fiorito (antologia su temi di teoria e metodo)
- "La scienza impropria. Metodi ed usi della teoria economica", in
Metamorfosi n. 8 (antologia di temi epistemologici con scritti di G.
Lunghini, A. Vercelli, A. Carabelli, C. Preve e altri)
- Methodological Controversy in Economics: Historical Essays in Honor of T. W.
Hutchinson
- , Jai Press, Londra, 1983, a cura di A. W. Coats
- New directions in economic methodology
- , Routledge & Kegan, Londra,
1994, a cura di R. E. Backhouse
* * *
- Blaug M., The Methodology of Economics, Cambridge University Press,
1992
- Brofenbrenner M., The “Structure of Revolutions” in Economic Thought,
in “History of Political Economy” vol. 3/1 1971
- Dasgupta A. K., Epochs of Economic Theory, Basil Blackwell, Oxford,
1985 [traduzione G. Nobile, revisione di M. Mosca, La teoria economica da
Smith a Keynes, il Mulino, Bologna, 1987]
- Geymonat L., Riflessioni critiche su Kuhn e Popper, Dedalo, Bari,
1983
- Grossi F., Studio sulle ricoluzioni scientifiche nella storia del
pensiero economico, Giuffré, Roma, 1976
- Hicks J., Causality in Economics, Basil Blackwell, Oxford, 1979
[traduzione M. Ziliotti, Analisi causale e teoria economica, Il Mulino,
Bologna, 1981, a cura di S. Zamagni]
- Kuhn T. S., The Structure of Sientific Revolutions, University of
Chicago Press, Chicago, 1962 [traduzione A. Carugo, La struttura delle
rivoluzioni scientifiche, Einaudi Torino, 1962 e 1970]
- Kunin L. e Weaver F. S., On the Structure of Scientific Revolutions in
Economics, in “History of Political Economy” vol. 3/2 1971
- Marx K. Einleitung, in Grundrisse der Kritik der politischen
Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858, Dietz Verlag, Berlino, 1953 [traduzione e
presentazione di E. Grillo, Introduzione del '57 in Lineamenti
fondamentali della critica dell'economia politica 1857-1858, La Nuova
Italia, Firenze, 1968]
- Myrdal G., Das Politische Element in der nationalökonomischen
Doktrinbildung, Junker und Dünnhaupt Verlag, Lipsia, 1932 [traduzione
dall'inglese P. L. Cecioni, L'elemento politico nello sviluppo della teoria
economica, Sansoni, Firenze, 1981; con introduzione e prefazione
dell'autore]
- Oldroyd D., The Arch of Knowledge, Methuen, New York, 1986
[traduzione L. Sosio,Storia della filosofia della scienza, Saggiatore,
Milano, 1989]
- Pheby J., Methodology and Economics, MacMillan, Londra, 1968
[traduzione A. Minali Economia e filosofia della scienza, Il Mulino,
Bologna, 1991]
- Popper K. R., “Congetture e confutazioni” di Popper e il dibattito
epistemologico post-popperiano, Paravia, Torino, 1988; a cura di G. Brianese
- Schumpeter J. A., -History of Economic Analysis, Oxford University
Press, New York, 1954 [traduzione P. Sylos Labini, L. Occhionero, Storia
dell'analisi economica, Boringhieri, Torino, 1990, introduzione G. Lunghini]
- - Business Cycles: a theoretical, historical and statistical analysis of the
Capitalist Process
- , vol I 1939
- Screpanti E. Cicli, rivoluzioni e situazioni classiche nello sviluppo
delle idee economiche, 1988
- Screpanti E, Zamagni S., Profilo di storia del pensiero economico, La
Nuova Italia Scientifica, Firenze, 1993
- Solo R. A., The Philosophy of Science, and Economics, MacMillan,
Londra, 1991
- Tagliagambe S., L'epistemologia contemporanea, Editori Riuniti, Roma,
1991
[1] Questa tendenza viene poi aiutata da una metodologia
pseudo-empirista, secondo cui la storia attuale di una scienza è il risultato di
una selezione dei suoi contributi migliori. Un simile approccio,
incrementalista, a “palla di neve” come è stato definito, invita espressamente a
disinteressarsi della storia del pensiero economico e della filosofia della
scienza. Che da un punto di vista filosofico tale approccio sia stato gettato
alle ortiche da almeno un secolo non sembra impressionare gli economisti che se
ne fanno alfieri. Evidentemente l’incrementalismo, per loro, vale solo in
economia. Cfr. l’introduzione a Screpanti E, Zamagni S., Profilo di storia
del pensiero economico, La Nuova Italia Scientifica, Firenze, 1993.
[2] Se si leggono le varie opere collettive di economisti sulla
metodologia dell’economia questa impressione appare chiarissima. In bibliografia
se ne danno alcuni esempi significativi.
[3] L’economista Robert Solo fu il primo allievo di Popper alla
London School of Economics, quando il filosofo austriaco vi arrivò. Entusiasmato
dalla concezione falsificazionista preparò una tesi di dottorato di 700 pagine
per dimostrare come, applicando scrupolosamente il falsificazionismo alla teoria
neoclassica, di questa non sarebbe rimasta pietra su pietra. Qualche giorno
prima che la tesi venisse discussa Popper si recò a casa di Solo per
costringerlo a ritirarla. Per la descrizione di questo episodio e di altri che
illuminano le ragioni delle scelte “economiche” di Popper si veda: Solo R.
A., The Philosophy of Science and Economics, MacMillan, Londra,
1991.
[4] Cfr. Storia del pensiero economico, op. cit., pag.
21 e ss.
[5] La già segnalata epistemologia incrementalista teorizza
perfino questa riscrittura come il corretto modo di fare scienza! Ma se tale
metodo orwelliano venisse applicato alla storia dell’epistemologia economica
dovremmo semplicemente dimenticarci delle idee dei vari Pantaleoni, Blaug ecc.
Un esito che forse loro stessi non avevano considerato.
[6] Citato in Oldroyd D. The Arch of Knowledge, Methuen,
New York, 1986 [traduzione L. Sosio, Storia della filosofia della
scienza, Saggiatore, Milano, 1989].
[7] La “matrice disciplinare” è stata proposta nella seconda
edizione della Struttura delle rivoluzioni scientifiche .
[8] La cosa divertente è che i vari allievi di Popper (Watkins,
Lakatos, Bartley ecc.) produssero una mole non indifferente di libri contro Kuhn
e la scienza normale, non accorgendosi di un curioso paradosso. Infatti,
difendendo il metodo del maestro e attaccando la scienza normale, stavano per
l’appunto facendo scienza normale! Per una spiegazione del dibattito Cfr.
“Congetture e confutazioni” di Popper e il dibattito epistemologico
post-popperiano, Paravia, Torino, 1988; a cura di G. Brianese.
[9] Se Kuhn volesse o meno espandere la sua concezione
discontinuista alla storia e alla società è difficile a dirsi. Nella
Struttura delle rivoluzioni scientifiche ci sono accenni che fanno
propendere per questa ipotesi, tuttavia rimane il fatto, già accennato, che la
sua teoria rimase sempre sul piano di una semplice descrizione fenomenica della
scienza, senza neppure osare affrontare i problemi del rapporto tra essa e lo
sviluppo della società.
[10] Questi esempi sono i più chiari nella storia del pensiero
economico. Il legame di cui si è parlato si riflette anche, ovviamente, nel
successo personale di taluni scienziati. Un esempio lampante è a tal proposito
L. Robbins, il quale negli anni del trionfo keynesiano costituiva un isola di
eterodossia ‘austriaca’ in terra britannica. Ma oggi le sue opere degli anni ‘30
ricevono ben più alti onori di quelle dominanti allora. Anche la ‘rinascita’ del
libro di Gossen ne è un buon esempio. I primi neoclassici facevano di tutto per
negare la rottura metodologica con la scuola classica, tentando al contempo di
nobilitare i propri precursori. Per tutto questo Cfr. Storia del pensiero
economico, op. cit., capitolo V.
[11] Questa accusa di non vedere le differenze fra le
rivoluzioni epocali e quelle difficilmente distinguibili dalla scienza normale
viene mossa a Kuhn da varie parti. Cfr. per esempio L. Geymonat Riflessioni
critiche su Kuhn e Popper , Dedalo, Bari, 1983.
[12] Un ottimo esempio a riguardo è costituito dal raffronto
tra la teoria del reddito permanente di Friedman e quella del ciclo vitale di
Modigliani. Quando vennero enunciate sembravano teorie simili di teorici
apparentemente lontani, in realtà si capì pian piano che erano teorie parallele
di teorici dello stesso paradigma.
(aprile 1997)
KUHN E LA STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (1 - 2)
1. Introduzione
Non esporrò il modello di crescita della conoscenza proposto da Kuhn perché è
molto noto. Vorrei invece, prima di parlare del rapporto tra la struttura delle
rivoluzioni scientifiche e la storia dell'analisi economica, incentrarmi su
quelli che sono i punti più deboli dell'analisi kuhniana.
2. Il concetto di paradigma: una ridefinizione
Kuhn è stato attaccato sin dalla pubblicazione del suo libro nel 1962 per via
della vaghezza del concetto di paradigma. C'è addirittura chi si è divertito a
contare 23 modi diversi di usare questo concetto[1], e lo
stesso Kuhn ha ammesso tale vaghezza. Tuttavia la correzione da lui tentata non
è servita. Infatti la "matrice disciplinare" al posto del paradigma non cambia
granché, anche se orienta maggiormente la teoria verso un'analisi sociale della
scienza. A mio avviso questo problema si risolve partendo dal fatto che il
concetto di paradigma può essere reso stringente se applicato alle stesse
"grandezze" epistemologiche. Intendo dire che l'errore di Kuhn è quello di usare
il paradigma per spiegare sia tradizioni lunghe e poderose fatte di decine di
teorie, migliaia di scienziati, biblioteche di scienza normale e così via
(pensiamo al paradigma neoclassico o al paradigma newtoniano), sia piccole
scuole inserite a loro volta in tradizioni più ampie e infine nel paradigma
"astronave madre" come in una matrioska.
Poiché non distingue tra scienza (sia normale che rivoluzionaria) che incide
su tutto il paradigma complessivo e quella che tocca solo la ridotta cerchia
della scuola alla base del paradigma, Kuhn è costretto a mettere sullo stesso
piano una rivoluzione scientifica epocale, fondamentale come la nascita della
fisica quantistica, o la teoria di Darwin, e rivoluzioni rilevanti solo
nell'ambito di una branca secondaria di una sottoscuola del paradigma[2]. Insomma il concetto di paradigma per mantenere l'enorme potere
esplicativo che, a mio giudizio, potrebbe avere, deve essere "stratificato" cioè
applicato a livelli diversi della tradizione scientifica. Esisterà perciò il
paradigma come scuola generale (il marxismo, la teoria neoclassica, la meccanica
newtoniana, la chimica del flogisto, ecc.) e poi avremo un "cono" fatto di
livelli sempre più stringenti come dei gironi danteschi, nei quali sempre meno
scienziati vanno elaborando una propria visione del paradigma all'interno prima
di poche grandi scuole e poi di piccoli gruppi che vanno espandendo il paradigma
come il delta di un fiume.
Ne risulterà una stratificazione paradigmatica che ci permetterà di capire
come possano esistere rivoluzioni scientifiche che riguardano solo una parte del
paradigma complessivo. E potrà anche spiegare come sia possibile all'interno
dello stesso paradigma una guerra "fratricida" tra scuole rivali. Abbiamo
infatti visto analizzando le teorie delle onde lunghe, che i dibattiti più aspri
si sono avuti proprio all'interno dello stesso paradigma. Forse perché le teorie
dello stesso paradigma sono più commensurabili fra loro, forse perché hanno fini
convergenti. E' un fatto che la lotta intraparadigmatica è stata spesso più
feroce che quella contro i paradigmi rivali. La stratificazione paradigmatica ci
aiuta a capire perché, trasformando il concetto di paradigma in una serie di
assunti a livelli sempre più di base. Ma per eliminare la vaghezza del concetto
di paradigma occorre anche ancorarlo a livello sociale concreto.
Voglio dire che Kuhn non ha mai spiegato come poteva mutare il paradigma nei
vari periodi storici, anzi trae esempi scientifici indifferentemente da tutti i
periodi storici. Ma la qualità e la quantità degli scienziati varia nel tempo.
Il mio concetto di paradigma come scala di stratificazioni successive nasce
proprio per tentare di plasmare il paradigma nei vari periodi storici. Non è la
stessa cosa se dieci persone si occupano di una teoria o se gli studiosi sono
10mila. Non è lo stesso se quei dieci scienziati sono semidilettanti, senza
mezzi, isolati o se invece hanno alle spalle laboratori, centri di ricerca, una
lunga esperienza e così via. Se la quantità deve a un certo punto diventare
qualità il paradigma muterà col tempo.
La nostra epoca è quella con la produttività più alta della storia. Mai una
frazione relativamente così alta della popolazione ha avuto un'istruzione
superiore (nei paesi industrializzati). Mai così tanti sono stati esentati dal
lavoro manuale per potersi dedicare al lavoro intellettuale. Nell'ultimo secolo
sono vissuti la stragrande maggioranza dei pensatori che siano mai nati[3]. Ecco perché i vari paradigmi sono sempre più stratificati.
Facciamo l'esempio del marxismo. Esso è nato nella teoria e nella pratica di
Marx ed Engels[4]. Dopo appena un decennio dalla morte di
Engels quante variazioni! I riformisti e i rivoluzionari, gli "economicisti" e i
"sottoconsumisti" e all'interno di ogni scuola sotto divisioni ulteriori. In
presenza di questa realtà storica è ovvio che il concetto di paradigma tout
court non funziona. Perché viene applicato a livelli diversi fra loro.
L'idea è che se al posto del concetto di paradigma come tradizione
scientifica indifferenziata, poniamo il concreto operare a diversi livelli del
paradigma, riusciremo a spiegare le varie lotte fra le scuole e altre questioni
che erano "anomalie" nella teoria pura di Kuhn. L'esempio della sintesi
neoclassica può essere utile a vedere come la modifica proposta funzioni. La
sintesi neoclassica, nata utilizzando pezzi addomesticati della teoria
keynesiana uniti alla teoria neoclassica ha avuto al suo interno una serie
enorme di varianti, scuole, interpretazioni. Tutti piccoli pezzi del paradigma
complessivo. Le interpretazioni del paradigma erano diverse ma non tanto da
mettere in dubbio il nucleo fondamentale della teoria comune.
A parte questo due scuole di questo paradigma potevano avere in comune anche
molto poco. Si poteva andare da neoclassici puri che usavano il modello IS-LM
solo per ortodossia a keynesiani che mal si adattavano alla storpiatura operata
alle concezioni dell'economista inglese. Ma comunque si andava avanti nello
stesso paradigma. Poi irrompono nuove scuole. Per esempio il monetarismo fa
parte forse di un altro paradigma? In fondo se Friedman e amici hanno potuto
dibattere così tanto con i "neokeynesiani" è proprio perché condividevano quasi
tutti gli assunti base del modo di fare scienza[5]. I
monetaristi e i "neokeynesiani" combattevano una lotta intraparadigmatica. Negli
ultimi due decenni è venuta fuori la teoria delle aspettative razionali.
Un'altra interpretazione del paradigma "neokeynesiano"?
A mio giudizio un altro paradigma. I monetaristi così conseguenti e "duri" da
portare avanti la teoria delle aspettative razionali hanno fatto una rivoluzione
scientifica creando un nuovo paradigma. Non hanno lottato più per la loro
interpretazione del paradigma, ne hanno fatto un altro. E qui sorge il problema
di come decidere che cos'è scienza rivoluzionaria. Infatti perché possiamo dire
che Lucas, Sargent e Wallace hanno fatto una rivoluzione scientifica e Friedman
o Tobin no? Restare nel paradigma dominante vuol dire per forza fare scienza
normale? Nella concezione kuhniana questo è inevitabile perché la scienza
rivoluzionaria è orientata solo alla costruzione di nuovi paradigmi. Ma se
concepiamo il paradigma come stratificazione storica e teorica di scuole che
hanno anche molto poco in comune, possiamo concepire scienza rivoluzionaria
anche all'interno del paradigma iniziale.
Poiché la scuola opera a un livello più basso del "core" centrale, essa potrà
anche essere eterodossa all’interno del paradigma ortodosso. Inoltre essa potrà
lottare per "riformare" il paradigma senza uscirne, se crede che possa offrire
ancora spunti utili alla ricerca. I monetaristi hanno fatto anche loro una
rivoluzione scientifica, come gli aspettativisti, ma senza rompere con il
paradigma dominante, piuttosto lottando per sconfiggere l'interpretazione
ortodossa del paradigma. Potremo avere così situazioni in cui scienziati
ortodossi fanno scienza rivoluzionaria mentre "eretici" fanno piatta scienza
normale. Infatti i primi potrebbero essere una scuola eretica del paradigma
mainstream e i secondi potrebbero essere i dittatori del paradigma eterodosso
(esempio: i monetaristi e gli stalinisti. I primi ortodossi nel paradigma e
rivoluzionari nella scuola. I secondi eretici nel paradigma e ortodossi fino al
ridicolo come interpretazione del paradigma).
Descritto questo c'è da precisare che non tutte le rivoluzioni scientifiche
vanno nella medesima situazione. Ci sono le rivoluzioni e le controrivoluzioni
(teoriche e politiche). Ma mi preme notare che anche nell'epistemologia, come
nella storia "le leggi della rivoluzione sono le stesse della controrivoluzione"
(Trotskij). Per questo quella monetarista è una rivoluzione al pari di quella
operata da Marx. Che poi fossero una rivoluzione per conservare e l'altra per
trasformare è un altro discorso. Prima ho accennato alla "riforma" del
paradigma. Intendevo dire che, se vogliamo proprio essere precisi e delineare la
rivoluzione scientifica in senso tradizionale, dobbiamo ammettere che la lotta
per trasformare il proprio paradigma è una riforma non una rivoluzione.
La rivoluzione avviene proprio quando lo scienziato non ha più fiducia nel
vecchio paradigma, quando questo ha esaurito tutte le sue risorse[6]. Tuttavia ho preferito chiamarle rivoluzioni entrambe perché se
è già difficile tracciare una demarcazione fra rivoluzioni scientifiche e
scienza normale alla luce della stratificazione, immettere anche la "riforma
scientifica" mi sembra complicare troppo il quadro. Comunque è un'altra analogia
tra metodologia e scienza politica che meriterebbe un'analisi seria. Penso di
aver chiarito con questo paragrafo come si può buttare l'acqua sporca (vaghezza
del concetto) senza il bambino (concetto di paradigma). Basta adattarlo alla
realtà sociale che cambia. Anche qui le intuizioni di Kuhn sono veramente
feconde. Occorre solo spingere ulteriormente sul pedale del rapporto
scienza-società. Cosa che comunque Kuhn ha già fatto molto rispetto al
fisicalismo puro dei suoi predecessori.
3. Il concetto di scienza normale
L'altra grande critica che si fa a Kuhn è che questi sembra giustificare e
anche favorire il ruolo della scienza normale fra gli scienziati, accentuando
così la conservazione e la "pigrizia" epistemologica. Su questo punto il più
feroce avversario dello storico della scienza americano è sicuramente Popper,
che vede la scienza normale come un crimine contro l'umanità, una sorta di
inspiegabile barbarie. Popper arrivò a dire che la scienza normale esiste ma "è
una cosa di cui bisogna vergognarsi"[7].
Entrare in questo importante dibattito ci porterebbe fuori strada, quanto ci
interessa è vedere se la scienza normale è veramente così dannosa e che ruolo ha
essa nell'economia. Iniziamo proprio dalle posizioni di Kuhn. A dire il vero
Kuhn non giustifica la scienza normale nella sua opera principale. Piuttosto ne
fornisce una spiegazione. In linea con il suo indirizzo che è quello di fare
epistemologia descrittiva, egli vuole semplicemente dar conto della realtà
innegabile della scienza normale. Dire, come fece Popper, che chi la fa deve
vergognarsi è sterile perché niente viene fatto nella società che non abbia la
sua origine da qualche esigenza di qualsiasi tipo. Sarebbe come dire che chi è
razzista deve vergognarsi. Prima bisogna capire perché c'è il razzismo, a chi fa
comodo, da dove viene.
Come al solito "non ridere né piangere ma capire" (Spinoza). E in questo caso
capire significa afferrare il ruolo della scienza normale nella crescita della
conoscenza. E' noto che Popper, vigoroso anticomunista, ha esaltato ironizzando
nei suoi libri la parola d'ordine trotskista della "rivoluzione permanente" che
per lui è la base dell'onestà intellettuale quando si fa scienza. Ma ha sempre
dimenticato che anche i rivoluzionari a un certo punto devono sintetizzare il
lavoro svolto. Anche nelle rivoluzioni socialiste ci sono i periodi "normali". E
questo perché, soprattutto nelle scienze sociali, la realtà cambia non
linearmente, ogni giorno dopo l'altro, ogni giorno uguale, ma piuttosto cambia
attraverso periodi caotici di repentini cambi di fronte e poi con periodi di
calma sociale. La analisi fatta delle onde lunghe aiuta un po' a mostrare
questo.
La scienza nel suo progredire riflette la non linearità della storia (non
solo di quella economica). In periodi di calma sociale, quali stimoli vengono, a
livello sociale, per fare scienza rivoluzionaria? Certo gruppi isolati possono
farne (vedi Marx negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, Sweezy
durante il maccartismo, ecc.), ma a livello della massa degli scienziati
l'attenzione (e i soldi delle borse di studio) sarà orientata a consolidare la
teoria che si ha. Fare scienza normale è solo marginalmente una necessità
logico-strutturale della scienza (la necessità di organizzare le novità,
eliminare le contraddizioni, formalizzare i risultati, ecc.). E' piuttosto una
caratteristica storica, sociale e quindi varia con i periodi e con la società. E
varia anche da scienza a scienza in dipendenza del rapporto fra scienza, società
e ruolo dello scienziato.
Per esempio è ovvio che la matematica è per sua natura più "conservatrice"
dell'economia o anche della fisica. Infatti non solo è influenzata dallo
sviluppo sociale solo nel lunghissimo periodo, ma ha una struttura logica tale
che non ha quasi mai bisogno di eliminare teorie e risultati, piuttosto li
accumula[8]. Nelle scienze sociali invece il rapporto fra
realtà e lavoro dello scienziato ci permette di stabilire un contatto fra ciclo
economico, scienza rivoluzionaria e lotta di classe. Come vedremo tra poco,
questo può intendersi direttamente come un legame empirico tra cicli lunghi e
momenti rivoluzionari nella scienza economica. Il ruolo della scienza normale è
invece quello di scegliere le teorie del periodo rivoluzionario che più sono
funzionali al nuovo ciclo di sviluppo. Questo non implica che la scienza
rivoluzionaria ci sia solo in periodi di crisi. Come detto questo è vero solo a
livello complessivo. Il singolo scienziato può riflettere la realtà sociale come
gli pare.
C'è sicuramente una certa autonomia della teoria e del suo creatore rispetto
alla realtà. Ma di solito l'autonomia non è mai tanto forte né tocca più di
qualche individuo. Insomma il ruolo della scienza normale in economia non deve
valutarsi secondo criteri romantici come fa Popper. Non ci rincresce se uno
scienziato fa scienza normale perché non è critico o non lotta per falsificare
la sua teoria. La scienza normale riflette in ultima analisi un'epoca di pace
sociale. In base a questa affermazione mi sento di dire che nel prossimo periodo
le possibilità di fare scienza normale saranno veramente poche.
4. Kuhn e l'economia politica
Da quanto detto sinora si capisce che apprezzo molto l'opera di Kuhn che per
la prima volta nella storia della filosofia della scienza ha rotto la pessima
abitudine di dare consigli e dettare ordini dall'alto dell'epistemologia
dominante. Se questo è vero per i fisici lo è mille volte di più per gli
economisti la cui materia è la società stessa. La storia della filosofia della
scienza dal 1962 (anno di pubblicazione della "Struttura delle rivoluzioni
scientifiche") a oggi si è andata via via orientando verso la descrizione,
lasciando le regole epistemologiche alla supponenza degli arroganti.
E' in questo cambiamento che Kuhn ha aiutato la nostra disciplina. E' ovvio
poi che il suo modello, opportunamente adattato nel tempo e nella struttura, è
utilissimo per aiutare a capire la storia anche della nostra disciplina. Ma più
del modello in sé conta il nuovo metodo. Come i primi storici greci seri
iniziarono a fare ricerca storica contro la tradizione della storia mitologica
espressa fino ad allora, così Kuhn, non a caso uno storico della scienza e non
un filosofo, ha fondato lo studio storico della scienza contro i miti e le
leggende scientiste e normative precedenti[9]. Questo è stato
il ruolo principale di Kuhn. Il fatto poi che un famoso economista avesse
anticipato Kuhn nello spiegare le epoche di teoria economica, ma senza trovare
ascolto, dimostra solo che anche le idee più brillanti per fiorire devono
trovare l'humus adatto. Altrimenti rimangono le intuizioni delle schiere dei
precursori di qualche teoria.
[1] citato in "Storia della filosofia della scienza" D.
Oldroyd
[2] Questa accusa di non vedere le differenze fra le
rivoluzioni epocali e quelle a mala pena distinguibili dalla scienza normale
viene mossa a Kuhn da varie parti, cfr per esempio "Riflessioni critiche su Kuhn
e Popper" L. Geymonat
[3] Come ricordato in "Profilo di storia…" cit. pag 14
[4] E c'è anche chi ipotizza un'interpretazione diversa del
materialismo storico nei due! (Per esempio Colletti in "Intervista
filosofico-politica")
[5] Vedi per esempio la teoria del reddito permanente di
Friedman e quella del ciclo vitale di Modigliani. Teoria simili di teorici
apparentemente lontani, in realtà teorie parallele di teorici dello stesso
paradigma.
[6] A questo proposito viene spontaneo avvicinare la struttura
delle rivoluzioni scientifiche alla descrizione marxiana delle rivoluzioni
sociali (per esempio nella famosa "Prefazione a per la critica dell'economia
politica"). Cambiando qualche aggettivo sembra una descrizione perfetta, ma non
ho la possibilità di trattare come meriterebbe questa analogia.
[7] citato in "Congetture e confutazioni" a cura di G.
Brianese
[8] Questa è l'opinione di C. Boyer. Cfr "Storia della
matematica" pag. 386
[9] Con ciò non intendo dire che Kuhn è stato il primo a fare
storia del metodo. Anzi abbiamo già accennato al fatto che Schumpeter ha
proposto molto prima un modello analogo proprio per l’economia. E ancora prima
altri avevano dato contributi ma fino a Kuhn il paradigma dominante costringeva
ad intendere il ruolo dell'epistemologo come una sorta di legislatore
onnipotente. Dopo Kuhn, grazie anche a Lakatos, Feyerabend e altri questo è
finito.
Sul concetto kuhniano di paradigma e sul rapporto fra Kuhn e l'economia.
- Geymonat L. Riflessioni critiche su Kuhn e Popper, 1983
- Grossi F. Studio sulle rivoluzioni scientifiche nella storia del pensiero
economico, 1976
- Hutchinson T. W. On the History and Philosophy of Science and
Economics, 1976
- Kuhn T. S. La struttura delle rivoluzioni scientifiche, 1978
- Myrdal G. Crisi e cicli nello sviluppo della scienza economica, 1976
- Oldroyd D. Storia della filosofia della scienza, 1989
- Pheby J. Economia e filosofia della scienza, 1991
- Popper K. R. Congetture e confutazioni, 1984 e 1991
- Screpanti E. Cicli, rivoluzioni e situazioni classiche nello sviluppo
delle idee economiche, 1988
- Stark. W The History of Economics in its Relations to Social
Development, 1944
- Tagliagambe S. L'epistemologia contemporanea, 1992
Csepel - Xepel
|
RIFLESSIONE E RAZIONALITA' NELLO SVILUPPO
SCIENTIFICO
Da molti secoli esiste nella storia della conoscenza l'interesse per la
riflessione, ma la sua portata metodologica ha cominciato a rivelarsi
solo nel XX sec. R. Brauer, p. es., criticando la matematica e la logica
classica, ha suscitato un forte interesse per i fondamenti della scienza
matematica. La scoperta dei paradossi nella teoria degli insiemi ha stimolato in
maniera determinante la riflessione matematica ab intra. Le ricerche
intensive nella logica e nella metamatematica hanno avuto per effetto una
migliore comprensione della struttura logica del sapere esatto. Si è cioè potuto
stabilire una distinzione più netta fra i livelli oggettivo e metaoggettivo
della teoria, fra il sistema formale e l'interpretazione. Le discussioni ancora
oggi si sprecano sui problemi metodologici legati alle nozioni di verità e di
precisione, di rigore matematico e di logica.
Tuttavia, il ruolo metodologico della riflessione s'è manifestato soprattutto
nello sviluppo della fisica. Il passaggio dalla fisica classica a quella
moderna ha comportato un mutamento nella concezione stessa di cosa significa
conoscere la realtà fisica. La rottura con le idee epistemologiche della fisica
di Newton si è approfondita dopo l'inizio del XX sec., e oggi nuovi principi
metodologici si vanno formando, anche nell'ambito della riflessione che concerne
i rapporti fra coscienza morale e problemi globali dell'umanità. Quanto più
cresce il ruolo del 'fattore umano' nei campi della conoscenza e dell'attività
pratica, tanto più si avverte la portata culturale generale della
riflessione, specie in quelle società in cui sono fortemente in crisi gli
orientamenti normativi di fondo.
* * *
Se noi consideriamo il ruolo della dimensione umana nel meccanismo
dell'attività cognitiva, tre tappe nella storia dello sviluppo delle scienze
esatte possono essere evidenziate, in modo più o meno convenzionale: quella
aristotelica, quella galileiana e quella bohriana. Nella
prima le scienze esatte sono allo stadio della loro formazione, quando i limiti
erano quelli della coscienza pratica quotidiana. Il tratto distintivo della
scienza aristotelica era il suo orientamento verso quello strato della realtà
immediatamente accessibile alla percezione umana. Ciò in quanto ci si limitava
ad osservare -secondo le regole del buon senso- le connessioni empiriche
elementari. Il principio di oggettività (il più importante requisito della
razionalità scientifica) si fondava su diversi assunti implicitamente ammessi.
Si trattava cioè delle 'evidenze' dell'esperienza quotidiana e della cultura
dell'epoca: anzitutto, la convinzione che il fenomeno è identico, nel suo
contenuto, a ciò che viene concretamente percepito e, in secondo luogo, l'idea
che una teoria scientifica è deducibile direttamente dalla natura, quale mera
esperienza sensoriale. Proprio questa esperienza, per gli antichi, garantiva
l'oggettività della teoria. Ed esperienza voleva soprattutto dire che i
meccanismi di percezione di tutti gli uomini sono uguali, cioè universali, per
cui il progresso della conoscenza deve necessariamente eliminare gli elementi
arbitrari della soggettività, sia a livello di strumenti cognitivi che a livello
dei risultati ottenuti.
Una posizione, questa, ingenua e affascinante allo stesso tempo, poiché se
l'identità di verità ed evidenza fosse veramente applicabile, lo
sviluppo della scienza sarebbe caratterizzato da un progresso impetuoso.
Purtroppo invece il salto nel buio del millennio medievale sta proprio a
dimostrare il contrario. L'acquisizione della verità scientifica è un processo
lento e faticoso, ove s'impongono drammi e rotture, impennate in avanti e
clamorosi balzi indietro.
La differenza principale del metodo aristotelico rispetto a quello galileiano
nello studio della natura è in pratica la seguente. Aristotele dapprima si
chiede il perché questo o quel fenomeno si produce, poi dà la sua
spiegazione metafisica, considerando pacifico che il fenomeno si manifesti
esattamente nel modo come viene osservato. Galileo invece si chiede anzitutto
come il fenomeno si produce realmente, dopodiché ne ricerca la causa,
formulandola sì in astratto, ma per cercare subito dopo una verifica
sperimentale. La svolta metodologica di Galileo ha imposto l'uso di un apparato
concettuale specializzato, solo grazie al quale è possibile cogliere esattamente
il senso 'fisico' della realtà. Il ricercatore diventa ora un professionista e
il suo ruolo creativo, legato alla necessità di formulare nuovi significati,
nuove ipotesi interpretative, che possano trovare riscontri nell'esperienza
quotidiana, cresce enormemente.
Galileo e, prima di lui, Copernico riuscirono a convincere il mondo che
l'esperienza della realtà necessita di un atteggiamento critico, in quanto
l'esperienza in sé non è qualcosa di identico al mondo degli oggetti. E' vero
che l'esperienza resta la pietra di paragone della teoria, tuttavia ora
l'esperienza quotidiana, per essere vera, deve trasformarsi in esperienza
scientifica. E questa trasformazione deve seguire tre direttive
fondamentali:
- prima di decidere il 'perché' bisogna rispondere alla questione del 'come'.
A tale scopo si deve predisporre la costruzione (più o meno simulata) di
situazioni sperimentali in cui l'osservazione dei fenomeni 'allo stato puro' sia
possibile. I dati dell'esperienza servono a formulare delle ipotesi sulle
strutture fondamentali della realtà, espresse generalmente in linguaggio
matematico.
- Per poter combinare l'ipotesi espressa in modo matematico con l'esperienza,
occorre che l'esperienza stessa sia metricamente organizzata, ovvero che i dati
dell'esperienza vengano espressi quantitativamente.
- Secondo la concezione degli scienziati di tipo galileiano, l'esperienza non
è la base da cui si può trarre la verità fondamentale di una teoria, in quanto
essa può sempre ingannare. L'esperienza e quindi l'esperimento possono tutt'al
più 'suggerire' nuove idee, mentre la loro principale funzione è quella di
essere strumenti di verifica della teoria, mediante il confronto delle sue
conseguenze ultime con i dati empirici.
A partire da questo momento il progresso verso la verità oggettiva si trova
mediato dalle costruzioni scientifiche, che nello stadio iniziale sono meramente
ipotetiche. Tuttavia, con la fisica nucleare di Niels Bohr la situazione cambia
radicalmente. Com'egli infatti sottolinea, tutta la struttura concettuale della
fisica classica (galileiana) riposava sull'ipotesi che fosse possibile fare una
distinzione fra il comportamento degli oggetti materiali e la loro osservazione.
Senonché, mentre per questo tipo di fisica l'interazione fra gli oggetti e gli
strumenti di misurazione poteva essere tranquillamente ignorata, per la fisica
quantistica invece -afferma lo scienziato- questa interazione fissa un limite
assoluto alla nostra possibilità di parlare ad es. del comportamento degli
elementi atomici, che sono indipendenti dai mezzi di osservazione. La scienza,
in pratica, si trova nuovamente posta di fronte al problema che aveva angosciato
i filosofi dell'antichità: come conciliare la nostra situazione di attori e
spettatori nel grande dramma dell'esistenza? I vecchi principi di descrizione
oggettiva e di coordinamento razionale della teoria con l'esperienza si rivelano
del tutto inadeguati nella nuova situazione di studio dell''infinitamente
piccolo'.
Naturalmente, la necessità di prendere in considerazione il contributo del
soggetto ai risultati della conoscenza, ovvero l'impossibilità di eliminare
completamente il 'fattore umano', ha spinto alcuni ricercatori occidentali a
interpretare tutto ciò come un ostacolo insormontabile alla conoscenza oggettiva
della natura. Oggi però molti altri tendono a sostenere il contrario, e cioè che
il contributo del soggetto non è affatto un ostacolo, ma anzi la necessaria
condizione di uno studio adeguato del micromondo.
* * *
Volgiamo ora lo sguardo verso la moderna matematica. Si sa che negli ultimi
30 anni K. Gödel, A. Tarski e altri hanno ottenuto dei risultati fondamentali
sul problema della dialettica formale/pertinente, riflessivo/non riflessivo nei
sistemi deduttivi. Si è cioè scoperto che una teoria può essere ridotta a
formule simboliche manipolabili all'interno di un certo insieme di regole. In
tal modo si può fare astrazione dal contenuto cognitivo espresso dalla stessa
teoria scientifica sottoposta a formalizzazione.
Questa metodologia 'simulativa' ha creato dei problemi epistemologici assai
delicati. Il primo dei quali è il seguente. Come noto, la conoscenza umana
(qualunque forma oggettivata le si conferisca) resta 'conoscenza' solo per quel
tanto che noi riusciamo a decifrarla in virtù di codici interpretativi presenti
nella nostra coscienza. Ebbene, proprio questa modalità, necessaria al sapere
pertinente, è stata scartata nella suddetta formalizzazione. In secondo luogo,
l'assunto secondo cui il sapere umano è sempre un sapere su qualcosa posto al di
fuori del sapere stesso, è stato contraddetto da un altro assunto, quello
secondo cui la particolarità del sapere oggettivato consiste nel fatto ch'esso
stesso rappresenta una certa realtà, un certo 'corpo' del sapere. Per cui, in
caso di necessità, è possibile fare astrazione totale dalle connessioni
relazionali della teoria con la realtà.
Moltissimi matematici si sono chiesti fin dove è possibile spingersi sulla
strada di questa forte dissociazione del sapere formale e contenutistico. Ci si
chiede cioè se il contenuto cognitivo di una teoria scientifica può essere
riflesso in modo esaustivo da una formalizzazione di questo tipo. Ora, come
noto, l'esperienza delle ricerche sui fondamenti della matematica ha dimostrato
anzitutto che è impossibile eliminare completamente il soggetto, sia dal
processo che dal risultato della conoscenza; in secondo luogo, che è possibile
indicare dei limiti all'interno dei quali l'astrazione dal fattore soggettivo
può essere razionalmente giustificata.
Lo sviluppo intensivo di campi conoscitivi come la biologia contemporanea,
l'ecologia, l'insieme delle scienze umane, la genetica ecc., mostra chiaramente
come la separazione totale del soggetto dall'oggetto sia cosa assai utopica. Il
ricercatore non può rinnegare la sua individualità quando prende in esame le
manifestazioni della soggettività: azioni, avvenimenti, cultura, opere d'arte
ecc. La conoscenza di un soggetto da parte di un altro soggetto deve saper
preservare le qualità personali di quest'ultimo: coscienza, libertà, unicità,
altrimenti è impossibile comprendere adeguatamente le qualità personali del
soggetto in esame. Un intervallo di astrazione dalla soggettività può essere
tollerato solo quando l'oggetto in causa non è immediatamente riconducibile
all'azione dell'uomo.
E' evidente, in sostanza, che i ricercatori non possono più nascondersi la
tendenza integrativa della dimensione umana nel processo cognitivo. Nelle tappe
anteriori dello sviluppo scientifico l'oggettivazione dei risultati acquisiti
avveniva con l'aiuto dei mezzi ordinari elaborati dalla scienza. Oggi è
diventato necessario mettere sotto controllo le procedure stesse che
garantiscono i risultati oggettivi. Si deve cioè tornare a valorizzare -come
nell'antichità- l'esigenza del momento soggettivo, ma a partire da una capacità
di riflessione e di analisi completamente diversa.
* * *
In cosa consista questa capacità di riflessione è presto detto. Essa è una
caratteristica tipica dell'uomo. Nella storia della filosofia e della scienza la
ritroviamo nell'ironia socratica, nel dubbio cartesiano, nel dialogismo dello
stile euristico galileiano, nelle antinomie kantiane, ecc. Fu però Marx a
scoprire per primo, nelle Tesi su Feuerbach, la differenza fra la
riflessione dialettico-materialistica e quella materialistico-contemplativa. Per
la prima volta si capì che l'uomo è un essere attivo, teleonomico, capace di
trasformare praticamente il mondo. L'epistemologia tradizionale, essendo qui
gravemente lacunosa, quando si accingeva allo studio dei modi della conoscenza
scientifica, lasciava sempre fuori dal suo campo d'indagine gli orientamenti
metodologici e i fondamenti storico-culturali degli atti cognitivi
(ragionamenti, procedure, metodi). Viceversa, oggi lo studio della struttura e
della dinamica dei sapere scientifico richiede sia una forte comprensione delle
interazioni fra elementi consci e inconsci del sapere, che una riflessione
critica, da parte dello spirito scientifico, sui propri presupposti
d'indagine.
Qual è dunque la struttura del sapere riflessivo contemporaneo? Anzitutto
esso è consapevole che il campo di sua competenza, la sua profondità e le sue
possibilità semantiche sono sempre limitate da dei presupposti impliciti.
La riflessione, come la verità, è sempre sottesa da alcune premesse, che ne sia
cosciente o no il ricercatore. Ovviamente queste premesse hanno un peso diverso
a seconda che sia in causa un'analisi meramente empirica del dato oggettivo o
invece un'analisi riflessiva sullo stesso sapere scientifico. In questo secondo
caso lo scienziato tende a trasformarsi in filosofo o metodologista, e la
scienza in questione potrebbe chiamarsi 'metagnostica' (una riflessione sulla
riflessione).
Storicamente parlando, il tipo più semplice di comprensione si situa al
livello del 'buon senso'. Le sue premesse implicite sono gli assiomi
dell'esperienza pratica quotidiana, con le sue generalizzazioni obiettivamente
vere e tutte le sue illusioni storicamente inevitabili. La comprensione,
nell'antichità e fino a Galileo, si fondava sul postulato, implicitamente
ammesso come universale, dell'identità dell'esperienza personale con quella di
altri esseri umani. Questa proposizione garantiva una relativa validità della
comprensione (e della comprensione reciproca), in quanto possedeva alcuni
fondamenti razionali:
- l'identità oggettiva di queste o quelle azioni pratiche,
- la somiglianza dei meccanismi psico-fisiologici di percezione di tutti gli
uomini.
Oggi tuttavia la pensiamo diversamente. Riteniamo cioè che l'essere umano
possa adottare un atteggiamento critico verso ciò che i suoi organi di
senso considerano 'evidente', oppure che possa chiedersi se i dati della
percezione corrispondano alla situazione oggettiva. Per risolvere questo
problema occorre superare un certo limite epistemologico reale che separa
l'oggettivo dal soggettivo. In tal caso esistono almeno due possibilità:
- utilizzare le indicazioni degli organi di senso secondo altre modalità,
- realizzare un'interazione pratica dell'oggetto osservato con un altro.
Dall'effetto previsto, ottenuto o no, noi potremo giudicare la validità del
nostro primo giudizio.
Un livello più elevato di comprensione è legato, nella storia della
cognizione, all'apparizione d'un quadro teorico particolare: il 'paradigma', che
si oppone alla consapevolezza quotidiana e che viene adottato da una determinata
comunità scientifica. Di qui il problema di trasferire i 'sensi della scienza'
nell'ambito della cultura generale. Benché tutto ciò sia il prodotto
dell'attività consapevole degli scienziati, molti aspetti restano al livello del
'sapere implicito'. Eppure la questione del significato di questi o quei termini
scientifici è priva di senso al di fuori di una posizione cognitiva dello
scienziato. L'analisi riflessiva serve appunto a esplicitare i fondamenti
oggettivi dei postulati inespressi.
Se si interpreta la posizione cognitiva come un aspetto puramente soggettivo
che non determina né il mondo conoscibile delle cose, né i modi storicamente
dati d'interazione pratica con esse, si dovrà o rinunciare alla razionalità
scientifica, quale principio regolatore, oppure interpretare erroneamente questo
principio stesso nello spirito del soggettivismo (vedi ad es. la posizione di T.
Kuhn). Naturalmente una posizione cognitiva può anche essere inadeguata e può
deformare poco o molto la realtà riflessa. Ma il problema è appunto quello di
sapere come sia possibile una comprensione adeguata del soggetto e non quello di
negare al soggetto l'utilità di questo compito. Ciò di cui bisogna tener conto,
nell'individuare le condizioni oggettive della conoscenza, sono due fattori: il
punto di vista del soggetto conoscente, che definisce la prospettiva
intellettuale della sua visione della realtà; e una certa misura obiettiva,
esterna al soggetto, che il soggetto può cogliere, nel mentre analizza
l'oggetto, con l'aiuto dei mezzi pratici e concettuali di cui dispone.
Dal punto di vista della razionalità scientifica delle scienze naturali
classiche, la realtà soggettiva era intesa come qualcosa di storicamente
astratto, opposto al mondo oggettivo, secondo un limite stabilito una volta per
tutte. Oggi invece, la metodologia dell'approccio concreto considera il campo
d'interazione del soggetto e dell'oggetto come una formazione pluridimensionale,
in cui è possibile identificare un intervallo di opposizione fra soggetto e
oggetto solo attraverso l'analisi riflessiva, in ogni specifico caso. La
mobilità della linea di demarcazione fra il soggetto e l'oggetto s'è interamente
manifestata per la prima volta durante lo studio del micromondo fisico. E
comunque, nella misura in cui nel futuro appariranno nuove 'dimensioni umane'
della scienza, la dialettica dei rapporti soggetto/oggetto diventerà sempre più
parte in causa della riflessione critica e
autocritica. |
|
1453:
l’uomo non è al centro del mondo
Nel 1543 viene pubblicato a Norimberga il De revolutionibus orbium
coelestium (Le rivoluzioni delle sfere celesti), il libro che, contro
l’evidenza dei sensi, contro un’antica tradizione astronomica e contro la
Bibbia, ferma il Sole al centro del mondo, riduce la Terra a semplice pianeta e
la fa girare.
E’ il frutto, ponderoso e di non facile lettura, di un lavoro avviato più di
trent’anni prima. L’autore è Niccolò Copernico (1473-1543), matematico e
astronomo polacco (o tedesco?).
Completato nel 1532, il libro è rimasto nel cassetto. Copernico ne ha
comunicato i clamorosi contenuti ad amici e studiosi (anche il papa Clemente VII
n’è stato informato nel 1533), ma ha esitato a pubblicarlo e ha continuato a
lavorarci su. Lo pubblica, su pressione di amici, solo in prossimità della
morte.
Nei secoli, il sistema tolemaico, già molto complesso in origine, si è sempre
più complicato. La complessità tolemaica si fa sentire pesantemente anche sui
lavori di riforma del calendario.
Le difficoltà insuperabili della riforma del calendario, nella quale è
coinvolto, e la disarmonia di un sistema appesantito da troppi correttivi,
spingono Copernico, convinto dalla sua formazione neoplatonica e pitagorica
dell’assoluta armonia dei movimenti celesti, a mettere in discussione la teoria
geocentrica.
Degli astronomi tolemaici e del loro ricorso a espedienti sempre più
complicati (cerchi omocentrici, eccentrici, epicicli, ecc.) per aggiustare il
sistema, Copernico scrive:
“A loro capitò proprio come ad un artista che, prendendo da luoghi diversi
mani, piedi, testa e altre membra, molto belle in sé, ma non fatte per un solo
corpo, anzi per nulla tra loro corrispondenti, formasse così un mostro invece
che un uomo”.[1]
L’importanza del Sole nella simbologia neoplatonica, cui è molto sensibile,
gli suggerisce la centralità del Sole. Lo studio del pitagorismo antico rafforza
il suggerimento e lo convince a rovesciare il rapporto tra la Terra e il Sole.
Lavora per decenni con calcoli matematici alla nuova ipotesi ed elabora un nuovo
sistema.
Per vincere le forti resistenze della tradizione tolemaica, configura,
secondo lo spirito rinascimentale, la novità rivoluzionaria come un ritorno alla
sapienza antica. Per vincere le resistenze del senso comune si serve di
elementari esperienze di relatività ottica: quando parte una nave, chi è a bordo
ha l’impressione che sia la riva e non la nave a muoversi; “quando una nave
naviga senza scosse, i navigatori vedono muoversi a immagine del suo movimento
tutte le cose esterne e inversamente essi credono di essere fermi rispetto a
tutto quello che è con loro”.[2]
“Copernico non è ancora in grado di avanzare ragioni fisiche del moto della
Terra (per questo bisognerà attendere Newton), ma solo argomentazioni di
carattere estetico e religioso: il mondo da lui raffigurato risulta, per la sua
armonia e semplicità, più degno della sapienza divina che non il mondo
geocentrico di Tolomeo”.[3]
Copernico dedica l’opera rivoluzionaria al papa Paolo III, già a conoscenza
del contenuto. Pensa di trovare in lui un autorevole sostegno contro gli
avversari.
Copernico, però, è malato e della pubblicazione si cura Andrea Osiander, un
teologo convertito al luteranesimo che, già nel 1540, aveva proposto a Copernico
di presentare la sua teoria come un semplice strumento di calcolo, privo di ogni
valore di verità sull’ordine reale delle cose.[4]
Osiander tenta di salvare capra e cavoli: la natura solo ipotetica del
copernicanesimo non offende la fede nella verità biblica e lascia intatta
l’utilità di calcoli matematici molto importanti per la riforma del
calendario.
Ma la reazione dei paladini della verità biblica è già scattata.
Lutero, già nel 1539, venuto a conoscenza del lavoro di Copernico, scrive,
senza nominarlo, di un astronomo “nuovo” che ha voluto dimostrare “che la terra
si muove e va in giro”. E aggiunge: “Il folle vuole sconvolgere tutta la scienza
dell’astronomia, ma, come la Sacra Scrittura mostra, fu al Sole e non alla Terra
che Giosuè ordinò di fermarsi”.[5] Anche
Melantone, nel 1541, afferma che è assurdo il tentativo di un “Sarmaticus
Astronomus” di muovere la terra e di fermare il sole e che un governo saggio non
dovrebbe permettere la diffusione di tali idee.[6]
Copernico sa di esporre il suo lavoro ad ampia e profonda ostilità. Nella
dedica al papa ricorda la prudenza dei Pitagorici che “erano soliti affidare i
misteri filosofici solo a parenti ed amici … perché cose bellissime e ricercate
con molto zelo da grandi uomini non andassero sciupate fra le mani di quelli che
o non intendono occuparsi di cultura se non per lucro o … per ottusità d’ingegno
vivono tra i filosofi come fuchi tra le api”.[7] Ma aggiunge: “Né posso dubitare che i matematici dotti e
sapienti saranno assolutamente d’accordo con me, se, come la filosofia
soprattutto esige, vorranno conoscere ed esaminare non superficialmente ma a
fondo le argomentazioni che nella mia opera porto a disposizione di queste cose
… E se tuttavia ci saranno dei chiacchieroni i quali, pur ignorando tutte le
scienze matematiche, pretendano di trinciare giudizi su di esse, in virtù di
qualche brano delle Sacre Scritture, di cui abbiano malamente stravolto il senso
per i loro scopi, e osino attaccare e schernire questa mia opera, non me ne curo
affatto fino, anzi, a disprezzare il loro giudizio come temerario”.[8]
Copernico è convinto della verità della sua teoria.
E’ anche orgoglioso dei suoi meriti nei lavori di riforma del calendario.
Finisce, infatti, la sua dedica al papa, scrivendo:
“Sotto Leone X, quando si discuteva nel Concilio Lateranense la questione
della riforma del calendario ecclesiastico, essa restò senza soluzione
unicamente perché la lunghezza degli anni e dei mesi, e i moti del sole e della
luna non si ritenevano ancora determinati a sufficienza. Da quel tempo, appunto,
io volsi l’attenzione ad osservare con più cura quei fenomeni … Come io mi sia
distinto in questa ricerca, lascio poi soprattutto al giudizio di Vostra Santità
e anche a quello di tutti gli altri dottori matematici. E perché non sembri a
Vostra Santità che io prometta, sull’utilità di quest’opera, più di quanto possa
effettivamente dare, passo direttamente all’argomento”.[9]
Con il geocentrismo la riforma del calendario restava inceppata, con
l’eliocentrismo si sblocca. La nuova teoria è utile perché vera. Non è solo
un‘ipotesi matematica che facilita i calcoli.
L’Osiander fa però stampare, di sua iniziativa e quando ormai Copernico non
può più impedirlo, sul verso del frontespizio, un’avvertenza anonima, “Al
lettore sulle ipotesi di quest’opera”, per precisare che “non è necessario che
quelle ipotesi siano vere, anzi neppure che siano verosimili, ma basta solo che
mostrino il calcolo in armonia con i fenomeni osservati … Né alcuno si aspetti
dall’astronomia nulla di certo riguardo le ipotesi, non potendolo essa affatto
mostrare, affinché prendendo per vere cose escogitate per un fine diverso, non
si allontani da questo studio più ignorante di quando vi si accostò”.[10]
L’operazione riduttiva non attenua la reazione protestante.
In campo cattolico, invece, l’interesse delle alte gerarchie alla riforma del
calendario e la tradizionale tendenza all’interpretazione allegorica della
Bibbia smorzano le opposizioni e l’operazione di Osiander aiuta la teoria
eliocentrica a penetrare mascherata, come un cavallo di Troia, in un mondo di
certezze antiche e profonde e salva il libro dalla messa all’Indice fino al
1616.
Nel 1582 Gregorio XIII incassa gli utili dell’ipotesi eliocentrica e vara la
riforma del calendario.
Nel 1584 Giordano Bruno pubblica a Londra La cena de le ceneri, in cui
strappa la maschera di Osiander: “E’ certo che il Copernico ha inteso come la
disse, e con tutto il sforzo la provò … Al Copernico non ha bastato dire
solamente che la terra si muove; ma ancora protesta e conferma quello, scrivendo
al Papa, e dicendo che le opinioni dei filosofi son molto lontane da quelle del
volgo, indegne d’esser seguitate, degnissime d’esser fuggite, come contrarie al
vero e dirittura”.
La premessa di Osiander, “certa Epistola supeliminare attaccata non so da chi
asino ignorante e presuntuoso”, è per Bruno smentita a chiare lettere dalla
dedica dell’opera al Papa.[11]
Per Bruno non si può usare la Bibbia contro Copernico: nelle Scritture Dio
parla agli uomini per ordinare la loro vita morale, non per insegnare
l’astronomia ai sapienti, e, per farsi capire, usa il linguaggio popolare e si
adegua alla cultura popolare.[12]
Bruno inserisce il copernicanesimo nel suo mondo infinito, senza confini e
senza centro, e così ne esalta la carica eversiva.
Il 17 febbraio 1600 Giordano Bruno finisce sul rogo, ma il copernicanesimo
non è stato all’origine del suo arresto veneziano del 1592. Nella denuncia di
Mocenigo tra le tante eresie indicate c’è la teoria “che sono infiniti mondi, e
che Dio ne fa infiniti continuamente”, ma non il movimento della Terra.[13] Questo, però, compare come quinta tra le
otto censure del 1997.[14]
All’Inquisizione romana è arrivato Roberto Bellarmino e comincia la lotta
della Chiesa contro la verità del copernicanesimo.
Intanto Keplero (1571-1630) perfeziona il sistema copernicano.
“Keplero era un grande astronomo e un grande matematico, ma anche un
appassionato astrologo e un mistico, vicino ai neoplatonici, dei quali
condivideva l’entusiasmo per la simbologia solare. Se egli abbraccia con slancio
la teoria copernicana è proprio per la posizione centrale che Copernico assegna
al Sole: per Keplero, il Sole è il simbolo della prima persona della Trinità,
«l’abitacolo di Dio Padre», e per questa ragione egli ritiene che gli spetti di
diritto il posto centrale nell’universo, l’unico che si addica alla sua
dignità.
Nella centralità del Sole e nella posizione decentrata della Terra Keplero
non vede una svalutazione dell’uomo e un ostacolo a pensare che egli sia il fine
per cui tutte le cose sono state fatte: anche se non occupa più fisicamente il
centro dell’universo, anche se non gli spetta quel «trono regale», è lui a
fruire della luce e del calore del Sole. Inoltre, dopo il Sole, non vi è globo
più nobile e adatto all’uomo della Terra: essa è posta al centro dei globi
primari, si trova in una posizione di privilegio rispetto agli altri pianeti,
quella che, secondo Keplero, meglio consente all’uomo la visione
dell’universo”.[15]
La fine del geocentrismo non compromette l’antropocentrismo.
Servendosi dell’ellisse invece che di circoli combinati in modo sempre più
complesso riesce a realizzare un sistema planetario dei cui movimenti individua
le tre leggi che portano il suo nome. Promuove l’idea del mondo come di un
meraviglioso orologio.
Keplero vede nella regolarità meccanica e matematica del suo
universo-orologio la prova sicura della trascendenza di Dio. Egli è convinto che
l’idea di Dio come anima del mondo, presente in tanta filosofia del
Rinascimento, sia riduttiva perché attribuisce all’opera l’onore che spetta al
suo Creatore. Trova più onorevole e più degna di Dio l’idea nuova di un Dio
orologiaio e ingegnere.
L’universo perde l’anima. Il divino viene messo al di sopra, ma anche fuori
del mondo, relegato nella trascendenza.
L’animazione universale del naturalismo e della magia del Rinascimento si
spegne. Anche la fisica di Aristotele va in crisi.
La considerazione quantitativa e meccanicistica della natura s’impone come
tratto distintivo della nuova scienza e le idee di sostanza e di fine incontrano
serie difficoltà anche in filosofia.
E’ iniziato il disincanto moderno del mondo. L’uomo non è più al centro del
mondo, ma si attrezza di mezzi conoscitivi e tecnici per realizzarne il
controllo e servirsene come se fosse un meraviglioso prodotto artigianale, una
grande macchina, l’orologio di Dio.
Pitagora e Prometeo si sono incontrati e muovono insieme alla conquista del
mondo.
Con Galileo lo scontro sulla verità del copernicanesimo esplode. Nel 1615
Antonio Foscarini, un padre carmelitano, pubblica a Roma un’opera in difesa del
copernicanesimo. Roberto Bellarmino, l’inquisitore più colto del processo a
Giordano Bruno, gli scrive il 12 aprile 1615, chiamando in causa anche Galileo:
«Primo, dico che V. P. et il Sig.r Galileo facciano prudentemente a contentarsi
di parlare ex suppositione e non assolutamente, come io ho sempre creduto
che habbia parlato il Copernico. Perché il dire, che supposto che la Terra si
muova e il Sole sia fermo si salvano tutte le apparenze meglio che con porre gli
eccentrici et epicicli, è benissimo detto, e non ha pericolo nessuno; e questo
basta al mathematico: ma volere affermare che realmente il Sole stia nel centro
del mondo e solo si rivolti in sé stesso senza correre dall'oriente
all'occidente, e che la Terra stia nel 3° cielo e giri con somma velocità
intorno al Sole, è cosa molto pericolosa non solo d'irritare i filosofi e
theologici scolastici, ma anco di nuocere alla Santa Fede con rendere false le
Scritture Sante».
Come Osiander! E, come Copernico, Galileo respinge il consiglio.
L’anno dopo il libro di Copernico finisce all’Indice e l’Inquisizione
ammonisce Galileo ad abbandonare la teoria copernicana, a non insegnarla e a non
difenderla.
Nel 1633 Galileo evita il rogo con l’abiura e finisce i suoi anni in
condizioni molto penose di carcere domiciliare.
Con lui la nuova scienza acquista sicura autonomia metodologica. Tuttavia, è
ancora una metafisica di tradizione pitagorica e platonica a fondare la sua
validità: la scienza è vera perché si serve della matematica, la lingua della
creazione divina e, quindi, il codice per decifrare la natura e dominarla.
[1] N. Copernico, Opera, Utet,
Torino 1979, p. 172, dedica al papa Paolo III.
[2] Ibidem, libro I, pp. 199-200.
[3] F. de Luise, G. Farinetti, Lezioni
di storia della filosofia B, Zanichelli 2010, p. 81.
[4] N. Copernico, Opera, Utet,
Torino 1979, p. 157-8, prefazione di F. Barone.
[5] Ibidem, p. 159 nota 4.
[6] Ibidem, p. 159 nota 4.
[7] Ibidem, p. 169.
[8] Ibidem, p. 176.
[9] Ibidem, p. 177-178.
[10] Ibidem, p. 165-167.
[11] La cena de le Ceneri, terzo
dialogo, in Opere Italiane 1, Utet 2002, pp. 491-493.
[12] Ibidem, inizio del quarto dialogo,
p. 522 e seg.
[13] Luigi Firpo, Il processo di
Giordano Bruno, Salerno editrice 1993, p. 143.
[14] Ibidem, pag. 82: La successiva
censura “circa motum terrae” colpiva l’entusiastica adesione all’ipotesi
copernicana palesata dal Bruno nella Cena delle Ceneri. Lo scarno sommario già
aduna in compendio i motivi antitetici che cozzarono quattro e sette lustri più
tardi nei processi di Galileo: con tono spiccatamente fermo e sicuro asserì il
Bruno di aver dimostrato “il modo e la causa del moto della terra e della
immobilità del firmamento” con “raggioni e autorità, le quali sono certe e non
pregiudicano l’autorità della divina scrittura, come ognuno ch’ha buona
intelligenza dell’una e dell’altra sarà sforzato anco al fine di ammettere e
concedere”. Gli furono allora citati i versetti biblici che parevano
contraddirle, ma egli fu pronto a spiegare il Terra autem in aeternum stat di
Eccle. I, 4, rilevando che l’accento va posto sull’eternità, non già
sull’immobilità del nostro mondo; quanto al sol oritur et occidit del versetto
seguente, seppe prontamente ribattere richiamandosi al moto solare apparente ed
all’uso del linguaggio quotidiano, enunciando così la spiegazione che concilia
realtà naturale e infallibilità scritturale e che la Chiesa stessa ha poi fatta
sua. Con uguale lucidità, obbiettandogli i giudici la contrastante autorità dei
S. Padri, egli ribatté che la sua tesi non contraddiceva ad essi “in quanto sono
santi, buoni ed esemplari, ma in quanto che sono meno de’ filosofi prattichi e
meno attenti alle cose della natura”.
[15] F. de Luise, G. Farinetti,
Lezioni di storia della filosofia B, Zanichelli 2010, p.
82.
Fonte: ANNO ACCADEMICO 2010-11 - UNIVERSITA’ POPOLARE DI TORINO
Giuseppe Bailone ha
pubblicato Il
Facchiotami, CRT Pistoia 1999.
Nel 2006 ha pubblicato Viaggio
nella filosofia europea, ed. Alpina, Torino.
Nel 2009 ha pubblicato, nei Quaderni della Fondazione Università Popolare di
Torino, Viaggio
nella filosofia, La Filosofia greca.
Due
dialoghi. I panni di Dio – Socrate e il filosofo della caverna (pdf)
Plotino
(pdf)
L'altare
della Vittoria e il crocifisso (pdf) |
|
LA BARBA DI PLATONE E I CONTI DI
EINSTEIN
Didattica estemporanea alla riscoperta degli universali
“I sofisti ritenevano che non esistesse una verità oggettiva su quel che è
bello o brutto, giusto o ingiusto, virtuoso o vizioso. Ben diversa è infatti la
virtù dell'uomo e della donna, del fanciullo e del vecchio, dello schiavo e del
cavallo. E sul giusto e l'ingiusto ogni popolo ha leggi e costumi differenti,
talché sovente i greci considerano empio quel che è ritenuto santo presso i
barbari e viceversa. Socrate sembra aver suggerito che se le varie forme di
virtù potevano nondimeno venir chiamate con l' unico nome di 'virtù' doveva pur
esserci qualcosa di comune a tutte, qualcosa che facesse di tutte loro degli
esempi di virtù. Il relativismo sofistico, foriero di disimpegno e corruzione
morale, si poteva perciò superare considerando non le singole virtù, ma la Virtù
stessa, non gli esempi particolari, ma l'intima essenza della virtù; lo stesso
poteva dirsi della bellezza, della giustizia, ecc.”
Così, sintetizzando per la mia terza liceo le precedenti lezioni di
filosofia, chiarisco l'affermazione di Aristotele secondo cui Socrate sarebbe
stato il primo ad introdurre gli “universali”. Contemporaneamente mi accingo ad
introdurre la “teoria delle idee” di Platone. Per i miei studenti si tratterà
del primo contatto con i grandi sistemi filosofici, una specie d'iniziazione con
cui li sottrarrò per sempre alla primitiva innocenza del senso comune,
schiudendo loro in compenso una nuova dimensione di realtà, accessibile solo
all'occhio del filosofo. E' un risultato non da poco, ottenibile solo mediante
un magistrale esercizio d'abilità, la cui esecuzione è sempre fonte per
l'insegnante di nuovo legittimo orgoglio (oltre ad assicurare, in prospettiva,
il pane per sé e per i suoi colleghi futuri).
“Che cosa è mai un universale? - chiedo - Qual è la sua natura, e dove si
trova? Noi possiamo vedere e indicare questo o quel gesto virtuoso, possiamo
toccar con mano questa o quella cosa bella. Ma la Virtù stessa, la Bellezza, o
la loro essenza, dove sono e che aspetto hanno? Allo stesso modo, possiamo
tracciare col gesso o ritagliare nella carta svariati triangoli particolari, e
per strada incontriamo e stringiamo la mano a degli uomini particolari; ma
dell'universale Triangolo o dell'universale Uomo, della Triangolarità e
dell'Umanità, che dire? E' certo che non si tratti di oggetti materiali, perché
nessun triangolo materiale, per quanto attentamente tracciato, avrà lati
perfettamente rettilinei e senza spessore, mentre questo è proprio ciò che
intendiamo pensando al Triangolo o alla Triangolarità; ogni uomo fisico sarà
biondo o moro, alto o basso, mentre l'Umanità in quanto tale non si caratterizza
secondo alcuna di queste alternative; infine, la pura essenza della virtù non si
trova in questo mondo, in cui la perfezione non esiste e le azioni degli uomini
son sempre animate da un miscuglio di impulsi nobili e meno nobili. Ma se non
sono oggetti materiali, cosa sono? e se non in questo mondo, dove si
trovano?”
Dopo un attimo di riflessione Samantha, un'alunna della prima fila,
azzarda:
“Mah, sono... sono nella mente! ... sono idee”
Mica male, per una principiante. Ma naturalmente, qualunque cosa lei intenda
per “idea”, di certo non è ancora quel che intende Platone. Così incalzo:
“Bene, ma queste idee sono nella mente in quanto è in essa e da essa che
nascono, o invece esistono già prima e altrove, finché la mente le scopre, le
comprende e le fa proprie? Ad esempio, la Triangolarità ha cominciato ad
esistere con le riflessioni del primo geometra, od esisteva anche prima? E
sarebbe esistita, se non fossero mai esistiti uomini od altre creature
razionali?”
“Forse no ... ” ipotizza Samantha.
“Mettiamola così: - faccio io - “il teorema del quadrato della diagonale è
diventato vero quando Pitagora o chi per lui ne diede la prima
dimostrazione?”
“No, lo era anche prima” replicano all'unisono Christian e altri due o
tre.
“Da quanto tempo?”
“Da ... da sempre!”
“Dunque, è eterno. Ma poiché esso parla della Triangolarità, non avrebbe
potuto essere vero se essa non fosse esistita. Dunque, anche la Triangolarità
deve essere esistita prima delle menti umane e dei triangoli materiali. Inoltre,
da Socrate abbiamo appreso che pur non sapendo bene cosa siano la Virtù e la
Bellezza, ci è possibile cercarle, e forse riusciremo anche a scoprirle. E non
avrebbe senso parlare della Giustizia e ricercarla, anche se nessun uomo ne
possedesse un'idea precisa? Dunque, gli universali esistono al di fuori della
mente umana.”
I ragazzi non possono che annuire, convinti, e quindi concludo:
“In sintesi, gli universali non sono oggetti materiali ne', in prima istanza,
idee della mente. E allora? Platone, che li chiama “idee” o “forme”, dice
appunto che essi esistono in sé, in una dimensione ulteriore che non è quella
fisica né quella psichica.”
La cosa è abbastanza misteriosa, ma ormai nessuno dubita che sia così, e i
ragazzi si sentono addirittura sollevati quando aggiungo che anche per Platone
questa terza dimensione restava oscura, e proprio per indicarne la radicale
alterità la collocava in una misteriosa regione situata oltre il cielo. E'
fatta: se ai loro occhi l'Iperuranio assume ormai un'aria quasi familiare, il
rovesciamento gestaltico dal senso comune alla sapienza filosofica è avvenuto,
ed anche oggi mi sono guadagnato la giornata.
Purtroppo, quasi in ogni classe c'è uno studente (talora anche più d'uno) per
cui qualsiasi cosa esca dalla bocca dell'insegnante è ipso facto
sospetta, e va contestata. Si tratta di individui molesti, che t'impediscono
persino di riposarti sui piccoli allori quotidiani, una delle poche
soddisfazioni che ancora concede la professione docente; ma in fondo, danno
anche più stimolo e gusto all'insegnamento. E' così vedo sollevarsi la mano di
Alex, che con tono di falsa umiltà (in effetti è di sfida sottile)
“Professore, - mi fa - ma non potrebbe la mente giungere a queste idee
universali partendo dalle cose materiali? In fondo, non è a partire dagli atti
virtuosi che ci facciamo un'idea di virtù, anche se inizialmente vaga? E non è
sempre discutendo sugli esempi particolari che via via la chiarifichiamo,
proprio come faceva Socrate? E davvero c'è bisogno che il triangolo con lati
perfettamente rettilinei e senza spessore esista separatamente nell'Iperuranio?
Non può darsi che la mente abbia la capacità di vedere in un triangolo materiale
la pura idea geometrica del triangolo, un po' come Willy il coyote mentre guarda
Bip-Bip il roadrunner vi scorge già un arrosto fumante?”
Allarme rosso: è un'obiezione che rischia di far crollare tutto il mio bel
castello di carte metafisico, afflosciando il perfetto soufflé didattico da me
servito. Ma mi considero un insegnante aperto e democratico, e d'altro canto non
so reprimere tra me e me una certa soddisfatta ammirazione: sono svegli, questi
ragazzi, se non hanno ancora iniziato lo studio di Platone e già mi escono con
qualcosa che assomiglia assai da vicino alla teoria dell'astrazione di
Aristotele. Decido così di stare al gioco, e rilancio:
“Sì, ma come potrebbe la mente trovare qualcosa di non materiale nelle cose
materiali, e qualcosa di perfetto nelle cose imperfette? Non solo, ma poiché
nessun triangolo da noi disegnato è simile a un altro, e ogni uomo fisico è
unico e diverso dagli altri, come troveremo nei particolari l'universale, ossia
qualcosa di identico in tutti?”
Da qualche minuto ho notato che Oscar segue la discussione con vivo
interesse, e dallo sguardo e da una certa agitazione mi accorgo che sta
rimuginando qualcosa. Infatti, eccolo alzare la mano:
“Ma sì, - dice in risposta ai miei interrogativi - perché nello spessore dei
lati di un triangolo materiale sono contenuti dei segmenti senza spessore e
perfettamente rettilinei che costituiscono i lati di un vero Triangolo non
materiale; nelle azioni di una persona virtuosa è presente la Virtù, per quanto
frammista a motivi egoistici o meno nobili; e in ogni uomo, al di sotto dei
caratteri particolari, c'è un'unica natura umana. E' come una banana, si scarta
la buccia e ci resta il frutto che c'è dentro.” (Si sente qualche risatina).
“Bravi, ragazzi! - mi complimento - Non è proprio come la buccia e il frutto,
ma avete colto qualcosa di importante. Vedremo infatti nelle prossime lezioni
che alla teoria platonica si contrappone quella aristotelica, secondo cui gli
universali non stanno nell'Iperuranio, ma nelle cose stesse, di cui
costituiscono la forma. Non vi sono contenute come un oggetto materiale
in un altro, ma come l'essenza, la natura o le proprietà di un oggetto sono
contenute in esso: la Triangolarità è appunto la forma (cioè l'essenza, la
natura) dei triangoli, la virtù delle azioni virtuose, l'Umanità degli uomini, e
il Rosso delle cose rosse. Ecco perché l'universale è unico e permette di
applicare uno stesso nome ai molteplici particolari: è proprio quella forma o
quell'insieme di caratteristiche che essi hanno in comune. L'universale esiste
prima della mente, proprio perché esiste nelle cose stesse. Aristotele sostiene
poi che la mente ricava le forme dalle cose astraendole, ossia
separandole dalla materia in cui sono calate. Ma non corriamo troppo, e per ora
torniamo al nostro Platone.”
“Un momento, Professore.” Mi giro e mi accorgo con un vago senso di
frustrazione che è di nuovo Alex ad impedirmi di cogliere i frutti della mia
ispirata didattica. “Questo non è esattamente ciò che intendevo. Se davvero un
segmento geometrico non è materiale, non vedo come possa esser contenuto
in qualcosa di materiale. Vi sfido a togliere tutto lo spessore che volete e
mostrarmi quando ottenete un segmento senza larghezza. E che significa che
l'Umanità è nell'uomo, cioè nell'uomo in carne ed ossa? Ci sono le ossa,
appunto, i muscoli, il cuore e la milza, e se togliete la pelle li vedete. Ma se
togliete ossa, muscoli, ecc., cioè tutta la parte materiale, non troverete certo
l'Umanità. Io non intendevo dire che la mente estrae gli universali dalle cose,
ma semplicemente che prende spunto da esse per formarsi delle idee che prima non
esistevano affatto, e che non possono esistere al di fuori di essa. Noi vediamo
segmenti dotati di spessore e approssimativamente rettilinei, e ne traiamo
spunto per immaginare segmenti perfettamente rettilinei e senza spessore.
Vediamo uomini concreti e tutti diversi, e ne estrapoliamo un'idea di uomo che
prescinda dai vari fattori di differenziazione. In realtà non si tratta
dell'idea di un uomo (l'avete mai visto, un uomo che non abbia un certo colore
di capelli, una certa statura, ecc.?), e così diciamo che è l'idea dell'Umanità.
Allo stesso modo, da qualunque cosa imperfetta prendiamo spunto per formarci
un'idea di perfezione, scartando quegli aspetti che però in realtà esistono.
Solo così possiamo pensare a delle forme separate dalla
materia: dove può esistere un'umanità senza uomini, una
Virtù senza atti virtuosi o del Rosso senza cose
rosse? Dove, se non nella mente?”
Quella di Alex si sta ormai chiaramente rivelando una posizione di tipo
concettualistico. Ma se non posso più, a questo punto, convincere la classe
della validità del realismo platonico, decido almeno di tenere la linea del
Piave di un moderato realismo aristotelico. Replico dunque immediatamente:
“Un universale non è necessariamente qualcosa di separabile dalla materia o
dai particolari concreti ed esistente ante rem, come credeva Platone.
Possiamo credere all''Umanità, alla Virtù o al Rosso, e tuttavia ammettere che
essi esistono esclusivamente in re, ossia nella materialità delle cose
concrete a cui danno forma, proprio come diceva Oscar ... cioè, Aristotele.”
“Quel che volevo dire, professore, è che fuori dalla mente non esistono
affatto, nemmeno uniti alla materia, perché sono semplicemente dei pensieri: gli
universali esistono solo in quanto pensati.”
“Cioè, esistono solo come concetti. Certo, si tratta di una tesi legittima ed
anzi illustre: fu sostenuta nell'antichità dagli Stoici, nel Medioevo da
filosofi scolastici come Abelardo di Nantes, ed in seguito da altri, fino al
moderno intuizionismo di Brouwer e oggi di Dummett. Nel Medioevo questa tesi fu
detta appunto “concettualismo”, e “realismo” fu detta la tesi opposta, secondo
cui gli universali sono qualcosa di reale e non solo di pensato. Ma di ciò
parleremo più avanti, verso la fine dell'anno, e...” Qui suona la campanella, e
non mi resta che rimandare la conclusione a domani.
A casa rifletto che se proprio i ragazzi desiderano esercitare il loro
spirito critico (dopotutto, secondo i programmi ministeriali, questo è uno degli
obbiettivi didattici dell'insegnamento della filosofia) avremo modo di tornare
ancora su questo problema; per ora, e proprio per rendere l'esercizio più
interessante in seguito, è opportuno che imparino ad apprezzare fino in fondo la
forza delle ragioni che militano in favore del realismo. Decido così di proporre
alcune delle considerazioni di Bolzano, Frege e Husserl contro lo psicologismo.
Da un punto di vista filologico, me ne rendo conto, si tratta di un colpo basso;
ma che importa, se vale a rendere più interessante la discussione? Inoltre mi
darà l'occasione per un utile richiamo quando, in quinta, riparleremo di questi
autori. Così, l'indomani riprendo:
“Ragazzi, ricordate la tesi di Alex secondo cui gli universali sarebbero
creature del pensiero, inesistenti al di fuori della sfera mentale? Ebbene, c'è
un problema. Come nessuno di noi è perfettamente uguale agli altri, così anche i
nostri pensieri, sensazioni e immagini mentali. Io posso spiegarvi all'incirca
la sensazione che provo, ma non potrò mai farvela provare o comunicarvela
esattamente e compiutamente. Se invece sto pensando a un universale, ve lo posso
comunicare con assoluta precisione, per quanto complesso o insolito possa
essere. Se ad esempio ho in mente, al posto del solito triangolo, l'idea del
dodecaedro regolare col lato di trentatré pollici e mezzo, posso dirvi di che si
tratta, e quando l'avrò fatto voi avrete in mente esattamente lo stesso
universale che avevo io. Dunque, possiamo anche sostenere che gli universali
sono concetti, ma dovremo ammettere che si tratta di concetti oggettivi:
si comunicano da un soggetto all'altro senza subire variazione alcuna. Dico di
più: ciascuno di noi ha un modo diverso di recepire uno stesso ed identico
concetto; io, ad esempio, mi posso immaginare il dodecaedro come visto da una
certa distanza, piuttosto piccolo, di colore grigio, ecc.; un altro può
visualizzarlo in primo piano, grande e incombente, di color rosa pallido; un
altro ancora, forse, associa al suo pensiero l'immagine mentale di una pagina
del manuale di geometria, ed un quarto nessuna immagine ma dei numeri o delle
formule. Tutte queste differenze, però, riguardano i modi di pensare il
concetto, e non il concetto stesso, che resta unico per tutti. Il
pensiero con cui afferriamo il concetto è dunque un atto della nostra
mente, e come tale variabile e soggettivo (Husserl lo chiamerà “noesis”);
invece ciò che è pensato, il concetto propriamente detto, che Husserl chiama
“noema”, è indipendente dalla sfera mentale: non appartiene né al mondo
degli oggetti fisici, né a quello degli oggetti psicologici, ma appunto, come
sosteneva Platone, ad un terzo mondo diverso dai primi due.”
“Professore, - scatta Oscar quasi ancor prima di alzare la mano - ho letto su
Focus che secondo Popper le teorie scientifiche, i libri e le opere
d'arte nascono dal secondo mondo, quello dei pensieri della mente, ma una volta
nati ne diventano indipendenti e costituiscono appunto il terzo mondo. Ad
esempio, il concetto di numero primo è un'invenzione umana, ma quanti numeri
primi vi siano tra 0 e 100 è qualcosa che non possiamo decidere noi; tant'è vero
che inizialmente non lo sappiamo nemmeno, e dobbiamo compiere una piccola
ricerca per scoprirlo.”
“Certo, - replico - quello di Popper è uno strano compromesso tra
concettualismo e realismo platonico. Ma se vale ciò che ho appena detto, resta
difficile capire come entità del terzo mondo possano esser generate da entità
del secondo, quali sono gli stati o gli atti della mente. Dall'espressione del
viso comprendo che l'interrogante, pur non ritenendosi del tutto soddisfatto, al
momento non sa bene come replicare, e non ci proverà. Chi invece non è per nulla
soddisfatto, e lo dichiara immediatamente, è - di nuovo - Alex. E come non tardo
a rendermi conto, anche lui nel frattempo si è documentato:
“Professore, ho letto che invece secondo alcuni filosofi gli universali non
sarebbero altro che segni: si tratta di Roscellino, Guglielmo di Baskerville,
Berkeley ...”
“Vuoi dire Guglielmo di Occam!”
“Bah, non ricordo bene; ma insomma, vengono detti nominalisti, in
quanto per loro non c'è nulla di comune a tutti i triangoli, a tutti gli esempi
di virtù o a tutti gli uomini, se non il nome! E' semplice e geniale, e spiega
proprio quella che lei ha chiamato l'oggettività dei concetti: i
contenuti oggettivi degli atti mentali soggettivi, ciò che è identico per tutti
anche se afferrato in modi diversi, non sono altro che nomi!”
“Allora - interloquisco - avrai letto anche dell'obiezione che il
concettualista Abelardo fece ai nominalisti: qualche tratto di penna sulla carta
o una sequenza di suoni non costituiscono un segno, cioè un nome, se non hanno
un significato. E un significato non può essere altro che un concetto, ed
un concetto oggettivo, in quanto lo si deve poter comunicare. Dunque ...”
“Ma secondo i nominalisti il significato di un nome è semplicemente l'insieme
di tutti gli oggetti che portano quel nome: dunque, null'altro che un insieme di
particolari materiali. I nomi comuni, come anche gli aggettivi e i verbi, hanno
proprio questa caratteristica, di poter simboleggiare molti oggetti singoli
contemporaneamente: 'triangolo' simboleggia tutti i triangoli, 'uomo' tutti gli
uomini, ecc. A proposito: ho letto anche che per i nominalisti non è affatto
vero che noi abbiamo idee generali, come quella di uomo o di triangolo, perché
quando pensiamo a un triangolo dobbiamo per forza immaginarcelo equilatero o
isoscele o scaleno, e nessuno è capace di immaginare un triangolo generico che
non sia nessuno di questi tre. Guglielmo di Baskerville - insomma, di Occam -
aveva poi un principio, secondo cui non si deve mai credere all'esistenza di
qualcosa, specie se misterioso e invisibile come gli universali, quando se ne
può fare a meno. Si chiama “il rasoio di Occam”, e possiamo servircene per
radere anche la barba di Platone, cioè l'ipertrofica e parassitica fauna delle
idee dell'Iperuranio: con gli oggetti particolari spieghiamo il mondo materiale,
con i segni il mondo del linguaggio e della conoscenza, e non ci serve
null'altro.”
Non c'è che dire, Alex sa proprio il fatto suo, e penso che dovrò
ricordarmene al momento delle valutazioni quadrimestrali. A dire il vero, la sua
convinzione che il significato possa ridursi al riferimento è decisamente
ottimistica, ma ora non posso entrare in problemi che implicano interi capitoli
di filosofia del linguaggio. Inoltre, come ha mostrato Wittgenstein, il
significato di un termine non deve necessariamente essere un'entità
associata ad esso, ma, ad esempio, l'uso che ne facciamo. E Quine ha
sostenuto che il significato coincide con la posizione del termine nella rete
linguistica, e non ha senso parlare di significati se non in ambito strettamente
intralinguistico. Decido perciò di introdurre un argomento che gli studenti
saranno in grado di afferrare anche immediatamente.
“Molto bene, è chiaro che questo problema v'interessa. Affrontiamolo pure,
dunque, anche se ci costringerà ad anticipare qualcosa dal programma dei
prossimi anni. E' vero, il nominalismo è una dottrina di grande attrattiva, con
ottimi argomenti a suo favore; oggi, poi, pare la più in linea con le tendenze
empiristiche, critiche ed antimetafisiche del pensiero contemporaneo. Anch'esso
ha i suoi problemi, tuttavia. Nel Medioevo, ad esempio, un nominalista avrebbe
dovuto ammettere che al nome 'Trinità' non corrisponde alcuna entità unitaria,
ma solamente i tre individui particolari che sono il Padre, il Figlio e lo
Spirito. Avrebbe così rischiato l'accusa di triteismo, che è quanto dire il rogo
...”
“Vorrei sperare che i tempi siano cambiati!” ghigna Alex dal suo angolo,
visibilmente non preoccupato da questo problema.
“Certo, - rispondo - ma oggi la visione teologica del mondo è stata
sostituita da quella scientifica. E su che vertono le leggi scientifiche se non
su altrettanti universali, come la massa, la velocità, la carica, ecc.?
Con la differenza che gli errori teologici potevano compromettere la vita eterna
ma (Inquisizione permettendo) l'eretico medievale poteva almeno cavarsela come
chiunque altro in questa vita. Invece, a confondersi sulle leggi scientifiche si
rischiano guai anche molto seri e immediati! Ho un paio di esempi
divertenti, a questo proposito. Intanto, però, osserviamo quel che ha
sottolineato Bertrand Russell, ma anche i concettualisti e i nominalisti più
avveduti hanno sempre ammesso: almeno un universale deve esistere, ed è la
relazione di somiglianza. Se infatti sosteniamo che un certo insieme di
particolari non ha in comune altro che il nome, dovremo pur distinguere tra i
particolari a cui quel nome si riferisce e tutti gli altri; e per farlo c'è
bisogno che essi si rassomiglino tra di loro e non con gli altri. Un uomo, ad
esempio, dovrà somigliare a tutti gli altri uomini ma non a un cavallo o a un
albero. Altrimenti, riferiremmo il nome 'uomo' anche ai cavalli e agli alberi, e
viceversa.”
Noto uno smarrimento negli occhi di Claudia, che infatti mi chiede:
“Professore, ma un uomo non può somigliare a un cavallo? possono essere
entrambi di buon carattere, oppure timidi e scontrosi. Oppure possono essere
entrambi veloci, o lenti, e così via”
“Esatto” rispondo. “Proprio come hanno sostenuto Goodman e Putnam, ogni cosa
può assomigliare a qualunque altra in infiniti modi: un fungo porcino e lo
Space Shuttle si assomigliano nell'essere entrambi oggetti materiali,
nati sul pianeta Terra, esistenti nel XX secolo, appena nominati da me, ecc.
Proprio per questo, non basta che tutti gli uomini si assomiglino così
genericamente, ma in un modo ben preciso in cui non assomigliano ad altri
animali o cose. Devono cioè avere in comune un quid, una proprietà, in
una parola un universale. Un semplice nome, avrebbe detto Abelardo, non
riesce a individuare un insieme di particolari senza riferirsi all'universale
che li contraddistingue.
Ed eccoci al primo degli esempi di cui parlavo. La scienza, come sapete, si
basa sull'induzione: se osservo una serie di smeraldi e noto che ciascuno di
essi è verde, ne posso trarre una semplice legge scientifica: tutti gli smeraldi
sono verdi. Nelson Goodman, tuttavia, ha proposto di introdurre un nuovo
aggettivo, verlù, così definito: verlù è qualunque cosa che sia osservata
entro il Duemila d.C. e verde, oppure non osservata entro tale data e blu.
Tornando quindi agli smeraldi da me osservati, si constata immediatamente che
essi rispondono tutti alla definizione di verlù, in quanto osservati prima del
Duemila e verdi. Pertanto, proprio come prima avevo generalizzato concludendo
che tutti gli smeraldi sono verdi, ora posso generalizzare concludendo che tutti
gli smeraldi sono verlù. Qui però sorge un problema: la legge secondo cui tutti
gli smeraldi sono verdi e quella secondo cui tutti gli smeraldi son verlù
sembrano ricavate in modo ugualmente legittimo, ma sono reciprocamente
incompatibili: se infatti tutti gli smeraldi sono verdi, anche quelli non
osservati entro il Duemila lo sono, mentre se tutti gli smeraldi sono verlù
quelli non osservati entro il duemila sono blu. In altre parole, per quanti
smeraldi verdi io osservi entro una certa data, non potrò mai sapere se anche
quelli che osserverò in seguito o che non osserverò mai siano verdi, oppure blu,
o magari di qualche altro colore. Ora, voi capite che non solo per i colori, ma
per qualsiasi proprietà si possono introdurre aggettivi del tipo di verlù; e ciò
significa che viene meno la possibilità di fare previsioni di qualunque tipo, di
programmare la nostra vita in base all'esperienza, e di realizzare applicazioni
tecnologiche di qualsiasi genere. Chi può dire che da domani la terra non
cesserà di ruotare su sé stessa, o il pane non diventerà tossico per
l'organismo, o la carrozzeria della mia auto non si scioglierà al calore del
sole?”
Ora sono diverse le mani che vedo alzarsi, accompagnate da espressioni che
svariano tra l'incredulo e il deluso.
“Professore,” dice Claudio “ma questo Goodman era forse uno di quei sofisti
che, come ci ha appena spiegato, si piccavano di saper dimostrare tutto e il
contrario di tutto?” E Samantha:
“Ma non c'è nulla di verlù ... cioè, forse sì, ma verlù non è un vero
aggettivo.” E Wolf, quasi completando il ragionamento:
“Secondo me non vale, perché una cosa dev'essere una e basta. Non si può
essere qualcosa e qualcos'altro insieme.”
Ora che li ho lasciati sbollire ed hanno espresso tutta l'indignazione per la
bassa lega del mio sofisma (o così essi credono), posso riprendere la
parola:
“Bene; a parte che Goodman non è un sofista, ma un filosofo vivo e vegeto ai
nostri giorni, è chiaro quel che volete dire: il verde è una proprietà, mentre
il verlù è un complesso, anche abbastanza astruso, di due proprietà. O se
vogliamo rimanere nei limiti del nominalismo di Alex, diciamo che 'verde' è un
termine semplice e primitivo, mentre 'verlù' è un termine complesso e definito a
partire da altri due termini ('verde' e 'blu'); quindi, le inferenze induttive
compiute utilizzando termini semplici e primitivi sono legittime e ci danno
autentiche leggi scientifiche, mentre quelle che utilizzano termini complessi e
definiti, come 'verlù', sono spurie, e non conducono ad alcuna conclusione
accettabile.
Però, c'è un però: ed è che l'esser semplice o complesso, primitivo o
definito, sono proprietà relative a un linguaggio. Immaginiamo una tribù, dice
Goodman, nel cui linguaggio non esistano affatto i termini 'verde' e 'blu',
mentre esistono 'verlù' e 'blerde' (un termine, quest'ultimo, indicante cose
osservate entro il Duemila e blu oppure non osservate entro quella data e
verdi). Ebbene, se volessimo spiegare ai membri della tribù il significato del
nostro termine 'verde', dovremmo dire che esso indica tutte le cose osservate
prima del Duemila e verlù, o non osservate prima di allora e blerdi. Di 'blu',
poi, dovremmo dire che significa osservato entro il Duemila e blerde, o non
osservato e verlù. Ma allora, essi potrebbero osservare che 'verde' e 'blu' sono
termini complessi, definiti sulla base di 'blerde' e 'verlù'; dal loro punto di
vista, pertanto, sarebbero le generalizzazioni induttive sul verde e sul blu a
risultare illeggittime, mentre quelle sul verlù e sul blerde sarebbero del tutto
corrette.”
Direi che i miei interlocutori siano rimasti abbastanza colpiti; ma quando il
gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare: in realtà, immaginavo che Alex
non avrebbe lasciato cadere questa sfida, ed infatti:
“Ma professore, che importa cosa pensano gli indigeni dei nostri termini o
dei loro? Chiunque può fabbricare nomi a volontà, e con essi definire altri
nomi; ma il fatto è che il verde, il colore verde, è una proprietà, un
colore semplice, mentre il verlù e il blerde non sono dei colori, ma insiemi di
colori diversi; a parte questo, ciascuno può poi chiamarli come meglio
crede!”
“Beh, sorvolo sul fatto che mi stai chiedendo di disinteressarmi dei nomi,
per occuparmi invece di proprietà, cioè di universali: per un nominalista come
te, non c'è male! Ma a parte questo, non sei tu a giocare coi nomi? In base a
che cosa sostieni che la proprietà verde è semplice, se non al fatto che il
termine 'verde' lo è nel nostro linguaggio? E non potrebbe un indigeno dire lo
stesso del verlù?”
“No, non è affatto per questo. Immagini di voler costruire un apparato in
grado di rilevare la presenza di oggetti verdi: di cosa avrà bisogno?
semplicemente di un misuratore di lunghezze d'onda e di un segnalatore (un
campanello o una spia luminosa, ad esempio) che entri in funzione quando
l'apparato viene colpito da radiazioni della lunghezza d'onda del verde. Se
invece volesse costruire un rilevatore di verlù, le occorrerebbero, oltre al
segnalatore e al misuratore di lunghezze d'onda, anche un calendario e un
computer programmato per azionare il segnalatore in corrispondenza di una
lunghezza d'onda fino a una certa data, e di un'altra lunghezza dopo quella
data. Si tratterebbe dunque di un meccanismo più complesso, e questo proprio
perché la proprietà da rilevare è più complessa.”
“Capisco benissimo. Anzi, direi che non c'è affatto bisogno di costruire un
simile apparato per la rilevazione del verde, perché già ne possediamo uno
ottimo: è il sistema nervoso umano, che quando viene colpito da radiazioni della
giusta lunghezza d'onda ci avvisa producendo in noi (nessuno sa ancora come) la
caratteristica sensazione cromatica del verde. Ma il problema è: chi ci dice che
esso non sia in realtà un rilevatore del verlù, ossia che a partire dal Duemila
non inizierà a produrre in noi la stessa sensazione quando colpito da radiazioni
di una diversa lunghezza d'onda (ad esempio, quella del blu)?”
“Al momento forse nulla; ma una volta giunto il Duemila (non è poi così
lontano, dopo tutto) basterà misurare le lunghezze d'onda per rendersene conto.
E comunque, dato che un oggetto, uno smeraldo ad esempio, emette sempre la
stessa lunghezza d'onda, se gli smeraldi continueranno ad apparirci verdi non
avremo motivi per supporre che il sistema nervoso abbia cambiato il suo modo di
reagire ai colori. Se invece tutt'a un tratto gli smeraldi ci apparissero blu,
significherebbe che il sistema nervoso reagisce in modo nuovo, ossia che era
realmente un rilevatore di verlù e non di verde.”
“Davvero? e non potrebbe darsi invece che gli smeraldi fossero realmente
verlù, e quindi ci apparissero blu non per una diversa reazione del sistema
nervoso ma perché ormai “divenuti” blu dopo il Duemila? (In realtà essi non
avrebbero mutato colore, ma il nostro sistema nervoso, essendo un rilevatore di
verde, ossia di uno pseudo-colore, ce li mostrerebbe mutati). Viceversa, anche
se continuassero ad apparirci verdi, potrebbe darsi che fossero verlù (e quindi
ormai blu) e che il sistema nervoso, essendo un rilevatore di verlù, reagisse
agli oggetti blu dopo il Duemila producendo in noi la stessa sensazione che
prima produceva di fronte agli oggetti verdi. O magari, quelle pietre potrebbero
non essere affatto smeraldi, ma smeriri ossia smeraldi prima del Duemila
e zaffiri dopo ... Quanto poi al misurare le lunghezze d'onda, per farlo ci
servirebbe un apposito apparato: e non potrebbe anch'esso, a nostra insaputa,
funzionare in modi diversi prima e dopo il Duemila?”
Si vede chiaramente che Alex sta ormai stancandosi del gioco. Eppure trova la
voglia di replicare ancora una volta, se non altro per puntiglio:
“D'accordo, ma se davvero il sistema nervoso fosse un rilevatore di verlù
potremmo scoprirlo sezionandolo ed esaminandolo attentamente: proprio come un
congegno fisico, infatti, anch'esso dovrebbe contenere un calendario o qualcosa
di equivalente. Certo, oggi non sappiamo nemmeno esattamente come esso rilevi il
verde, figuriamoci il verlù; ma in linea di principio ...”
“La familiarità con cui tratti le questioni di principio depone assai bene
sulle tue attitudini filosofiche; comunque capisco: in linea di principio, tu
dici, dovremmo esser in grado di notare un'imprevista complessità del sistema.
Ma ciò vale solo se davvero il verlù fosse una proprietà complessa, perché in
caso contrario un rilevatore di verlù sarebbe più semplice di un rilevatore di
verde. Ma a parte questo, senti cosa ha obiettato Hilary Putnam: si può definire
una nuova proprietà, quella di rilevare* , consistente in questo: si
rileva* del verlù tutte le volte che si rileva del verde, e viceversa. Un attimo
di riflessione ci mostra allora che un rilevatore di verde è più semplice di un
rilevatore di verlù, ma un rilevatore* di verlù è più semplice di un rilevatore*
dil verde. Mi replicherai che questo accade solo perché la stessa proprietà di
rilevare* è complessa: essa consiste, ad esempio, nel far suonare un campanello
in presenza di una certa lunghezza d'onda prima del Duemila e di un'altra dopo.
Tuttavia, potremmo anche definire la proprietà di far suonare* come
quella di far suonare prima del Duemila e non far suonare dopo il Duemila, e
così via di questo passo, introducendo per ogni proprietà un corrispettivo con
asterisco, in modo da parare una dopo l'altra tutte le tue prevedibili
obiezioni.”
“Ma sarebbe banalmente circolare!”
“Forse; ma attento alla morale di questa storia: non è solo la semplicità o
complessità dei termini ad esser relativa ai termini con cui li definiamo; anche
la semplicità o complessità delle proprietà si misura solo per mezzo delle loro
relazioni con altre proprietà. Se guardiamo a un intero sistema di proprietà
“normali” e ad uno di proprietà asteriscate, non è possibile, semplicemente in
base alle relazioni interne a ciascun sistema, stabilire se le une siano più
semplici delle altre.
Del resto, ragazzi, quello di Goodman non è l'unico esempio del genere. Un
ambiguo filosofo di nome Kripgenstein ha osservato che quando impariamo
l'addizione lo facciamo in base ad esempi: il maestro ci spiega che 1+1=2,
2+1=3, ecc. Dopo un po' siamo in grado di procedere per conto nostro; ma chi ci
assicura che da un certo punto in avanti il nostro modo di procedere non
divergerà da quello dei compagni? Per esempio, supponiamo che a nessuno sia mai
capitato di eseguire un'addizione con addendi uguali o superiori a
12.345.678.987.654.321. Ebbene, se interrogati su quale sia il valore
dell'addizione
12.345.678.987.654.321+1, alcuni di noi probabilmente risponderebbero
“12.345.678.987.654.322”; ma perché qualcun altro non dovrebbe rispondere,
poniamo, “5”? Dopotutto, la prima risposta non è contenuta negli esempi da cui
tutti abbiamo imparato l'addizione più di quanto non lo sia la seconda.”
Quando ho introdotto il nuovo argomento, la classe aveva ormai cessato di
seguirmi. Perfino in Alex pareva stesse riprendendo il sopravvento quel sano
senso pratico che rende molti costituzionalmente refrattari a qualunque
ragionamento astrattivo, e che ormai li aveva pervicacemente convinti che i miei
non erano altro che vacui esercizi dialettici. Ma ora la stessa apparente
facilità del problema fa tornar la voglia di rispondermi, e così sono diversi a
intervenire, contemporaneamente:
“Ma questo non sarebbe più una somma!”
“Perché uno dovrebbe cambiare tutt'a un tratto modo di procedere?”
“Addizionare significa compiere sempre la stessa operazione: per
esempio, addizionare 1 significa aggiungere 1; addizionare 2 significa
aggiungere 2; e così via.”
“Bene, ragazzi, bene: se mi state dicendo che sommare significa addizionare,
e addizionare significa aggiungere, sono d'accordo con voi. Ammetterò perfino
che aggiungere significa sommare! Ma così abbiamo fatto qualche passo avanti? Mi
dite anche che per addizionare si dovrebbe fare sempre la stessa cosa; ma fare
2+2=4 è una cosa, e fare 5+5=10 è già una cosa diversa! In realtà volete dire
che per addizionare si dovrebbe applicare sempre la stessa funzione, continuare
la stessa serie? Bene, ma chi mi dice che la funzione che ho appreso sui banchi
di scuola sia quella che corrisponde alla serie
(1) 1+1=2, 2+1=3, 3+1=4, ... 12.345.678.987.654.321+1=
12.345.678.987.654.322, piuttosto che alla serie
(2) 1+1=2, 2+1=3,3+1=4, ... 12.345.678.987.654.321+1= 5?
Dopo tutto, entrambe le serie hanno in comune gli stessi esempi iniziali, e
dunque quegli esempi non ci permettono di classificare l'una o l'altra come
scorretta.”
“Ma la (2) è una serie casuale, e non una vera funzione matematica!” riprende
Samantha.
“Già, ma con che argomenti potresti sostenerlo? Se dici che non è
un'addizione commetti una petitio principii, presupponendo quanto
dovresti dimostrare; non puoi sostenere che una somma come l'ultima della (2)
non ha mai avuto un valore simile, perché per ipotesi una tale somma non era mai
stata calcolata; e se intendi dire che non si è mai calcolato in quel
modo, ti sfido a mostrarmi quale sia il modo corretto, senza ricorrere agli
esempi passati e senza far uso di termini come 'aggiungere', addizionare', ecc.
Per dire che la serie (2) non rappresenta una vera funzione, in sostanza, non
abbiamo più motivi di quanti ne avessimo poc'anzi per affermare che il verlù non
è un vero colore.”
“D'accordo, sono entrambe serie o funzioni; - (è lo spirito filosofico di
Alex che torna a farsi sotto, finalmente) - tuttavia non v'è dubbio che siano
qualcosa di ben diverso: la (1) rappresenta quello che normalmente chiamiamo
“addizione”, contrassegnata dal simbolo '+' ('più'); la (2) rappresenta invece
un'altra funzione, a cui potremmo assegnare un altro nome (diciamo
'chiaddizione') e un altro simbolo, diciamo '+*' ('chiù'). Pertanto, diremo che
12.345.678.987.654.322 è il corretto risultato dell'addizione
12.345.678.987.654.321+1, mentre 5 è il corretto risultato della
chiaddizione
12.345.678.987.654.321+*1.”
“Benissimo, è ciò che dice anche Kripgenstein; ma resta il problema se quella
che ciascuno di noi ha appreso da bambino e da allora ha sempre applicato sia
l'addizione o la chiaddizione. E soprattutto, di quale sia la funzione giusta,
nel senso di quella che la natura applica. Nel progettare gli aerei, gli
ingegneri calcolano la potenza complessiva addizionando i valori della potenza
dei singoli motori, e finora le cose sono sempre andate per il meglio. Ma
supponiamo che un bel giorno gli addendi siano tali che il valore della loro
addizione differisca da quello della loro chiaddizione: quale valore si dovrà
scegliere? In altri termini, quale risulterà in effetti la potenza totale
dell'aereo, quella ottenuta addizionando o quella ottenuta chiaddizionanando? A
rispondere in modo sbagliato si rischiano guai seri; ma affermare che finora la
natura ha sempre usato l'addizione, e quindi continuerà a farlo, è come
affermare che tutti gli smeraldi osservati finora sono verdi, e quindi
continueranno ad esserlo.
Si dice che per la proverbiale distrazione dei geni Einstein sbagliasse
spesso nel fare i conti della spesa; ma di certo non ha sbagliato il calcolo
dell'equivalenza tra massa ed energia, o delle trasformazioni relativistiche!
Eppure il paradosso di Kripgenstein, come quello di Goodman, implica la
possibilità di errori sistematici e diffusi in ogni campo. Senza risolvere
questi paradossi non possiamo spiegare ne' l'impressionante successo della
scienza contemporanea, ne' il più famigliare ma non meno importante successo
delle nostre quotidiane strategie d'interazione col mondo.
Mi rendo conto che continuate a credere che questi siano sofismi, e non vi
sfiora il benché minimo dubbio che gli smeraldi possano mai dimostrarsi verlù, o
che la natura possa mai mettersi a chiaddizionare. Scommetto anzi che proprio
ora state pensando più o meno così: “Non importa se non sappiamo come
dimostrarlo, ma è chiaro che il verde è un colore e l'addizione è una
funzione, mentre il verlù e la chiaddizione non lo sono.” E' questo che
pensate, o no?” (Il silenzio che segue mi indica che ho colto nel segno, e che
la risposta è talmente ovvia da non meritare una formulazione esplicita).
“Bene, ragazzi, è proprio qui che vi voglio. Se siete convinti di questo, è
perché siete convinti che vi sia qualcosa di comune a tutte le cose verdi,
mentre non v'è nulla di analogo per tutte le cose verlù, e che esista un modo in
cui tutti gli esempi di addizione si somiglino, mentre non ne esiste uno per
tutti gli esempi di chiaddizione. In altri termini, perché dentro di voi siete
convinti che esistano gli universali, a dispetto delle obiezioni di Alex e di
tutti i nominalisti prima di lui. Se effettivamente esistessero solo dei
particolari, senza nulla in comune, non farebbe alcuna differenza il
classificare insieme tutte le cose verdi, oppure quelle verdi prima del Duemila
e quelle blu dopo, o magari quelle gialle, purché stiano sotto il mio tavolo:
ogni modo di proseguire il segmento iniziale di una serie varrebbe quanto
qualsiasi altro. Se tutto ciò che dei particolari possono avere in comune
fossero i nomi, il verde non avrebbe alcun vantaggio sul verlù, e l'addizione
sulla chiaddizione: ogni classe di particolari varrebbe come ogni altra, ed a
ciascuna si potrebbe associare un nome; e d'altra parte, ogni nome può far parte
di un sistema di termini coerente nel quale figura come semplice e indefinito.
Se invece si ammettono gli universali, possiamo sostenere che non tutti i nomi o
le classificazioni si equivalgono: ad alcuni nomi e classi corrisponde un
singolo universale, come il colore verde o la funzione dell'addizione; invece a
nomi come 'verlù' non corrisponde alcun universale. A tali nomi si può
certamente associare una classe di particolari, ma essa è in realtà l'unione di
due o più classi, individuate per mezzo di altrettanti universali diversi.
Sul paradosso di Goodman si discute ormai da una cinquantina d'anni, e su
quello di Kripgenstein da poco meno; ebbene, se una cosa hanno chiarito tutti
questi dibattiti, è che senza gli universali entrambi i paradossi restano
inattaccabili, nella loro scandalosa incompatibilità con l'insegnamento del
buonsenso e con le verità della scienza. Gli universali sono dunque degli
indispensabili compagni della nostra vita, che possiamo permetterci di ignorare
solo perché li abbiamo sempre con noi. Eliminarli non significherebbe solo far
cadere con un goliardico colpo di rasoio la vetusta e venerabile barba di
Platone, ma trasformare i divertenti lapsus di Einstein in una inimmaginabile
condizione di paralisi teoretica e pratica per ogni essere razionale.”
Per oggi ho finito, e infatti suona la campana. Non c'è eco alle mie ultime
parole: Alex, assorto, sta processando l'ultima parte del discorso, e domani
forse ne avremo qualche output. Il resto della classe non è ben certo se
io li abbia definitivamente irretiti nelle spire della mia eristica, o condotti
alla scoperta di una verità nuova ed importante. Quel che è certo, e che per
loro costituisce già un sufficiente motivo di soddisfazione, è che anche per
oggi non ho proceduto col programma o assegnato lezioni per casa. Ma a questo
posso provvedere al volo:
“A proposito, ragazzi, sapete chi è Kripgenstein? Ve lo do come ricerca per
casa. Per aiutarvi, dirò che non è morto né vivente, ma come il gatto di
Schrödinger, mezzo e mezzo.”
NOTE
1 Alex e gli altri sono reali, fino a un certo punto. O forse dovrei dire
surreali, in quanto a loro ho attribuito anche obiezioni avanzate da studenti di
altre classi o in altri anni.
2 Per i colleghi di filosofia: se nelle vostre classi volete impostare un
percorso didattico del genere, ma non avete studenti come questi, le obiezioni
dovrete provvedere a farvele da soli.
INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE
- M. Alai, A Critique of Putnam's Anti-realism, U.M.I., Ann Arbor, MI
1989, §§ 32-37.
- M. Alai, “Goodman's Paradox: Drawing Conclusions from a Long Debate”, in
Atti del Congresso Nuovi
problemi della logica e della filosofia della scienza. Atti del Congresso
(1), CLUEB, Bologna 1991, pp.109-116.
- Alai Mario, Modi
di conoscere il mondo. Soggettività, convenzioni e sostenibilità del
realismo, Franco Angeli
- D. M. Armstrong, Universals and Scientific Realism, Cambridge
University Press, Cambridge 1978.
- M. Dummett “The Origins of Analytical Philosophy”, Lingua e stile
XXIII, 1988, pp.16-20.
- N. Goodman, Fatti,
ipotesi e previsioni, Laterza, Bari 1985, cap. III
- S. Kripke, Wittgenstein on Rules and private Language, Basil
Blackwell, Oxford 1982.
- Popper Karl R.; Eccles John C., L'io
e il suo cervello. Vol. 1: Materia, coscienza e cultura, Vol.
2: Strutture e funzioni cerebrali, Vol.
3: Dialoghi aperti tra Popper e Eccles., Armando
- H. Putnam, Ragione,
verità e storia, Il Saggiatore, Milano 1985, capp. II e III.
- W.V. Quine, Il
problema del significato, Ubaldini, Roma 1966, capp.1-3.
- B. Russell, “Il mondo degli universali. Ciò che sappiamo sugli universali”,
in L. Urbani Ulivi, Gli
universali e la formazione dei concetti, cit., pp. 53-68.
- L. Urbani Ulivi, Gli
universali e la formazione dei concetti, Edizioni di Comunità, Milano
1981.
- L. Wittgenstein, Ricerche
filosofiche, Einaudi, Torino 1967, §§ 138-242.
- Cimmino Luigi, Significato
e divenire. Wittgenstein e il problema delle regole, Morlacchi
- Nuovi
problemi della logica e della filosofia della scienza. Atti del Congresso
(2), CLUEB
Mario Alai
Pubblicato su "IL LICEO E LA CITTA'. Cinquantenario 1944-45/1994-95" annuario
del Liceo Scientifico Statale "A. Righi", a cura di P. Palmieri, Stilgraf,
Cesena, 1995, pp. 271-289.
www.uniurb.it/Filosofia/index.htm
Referente di Amnesty
International a Cesena:
www.amnesty.it - www.aicesena.tk |
FILOSOFIA DELLA MATEMATICA

La più perfetta suddivisione dell'uno è quella per tre. Infatti 1:3 dà 0,3
(periodico). Ciò significa che nell'idea di unità è contenuta quella di
triade.
Da notare che solo il decimale periodico dà l'idea dell'infinito, anche se,
ovviamente, in stretta correlazione con l'unità da cui dipende.
L'infinito esiste solo entro certi limiti, quelli posti dall'intero, in modo
particolare dall'uno, che è l'intero più perfetto, fonte di ogni altro
intero.
Al di là di questi limiti c'è il nulla o l'irrazionale (o la finzione dei
numeri negativi).
La suddivisione imperfetta dell'uno è quella per sei. Infatti 1:6 dà 0,16 (6
periodico).
Il limite ultimo di questa imperfezione, che rappresenta in un certo senso,
il ritorno all'origine, sta nel rapporto di 1:9 = 0,1 (periodico).
La perfezione dell'uno include l'idea d'imperfezione, senza che ciò lo
contraddica, a condizione naturalmente che si rispettino certi limiti. Singolare
è il fatto che quanto più ci si allontana, in virtù dell'imperfezione, dalla
fonte, tanto più s'impone la necessità di recuperarla.
In ogni caso il concetto d'infinito può essere elaborato solo servendosi
dell'unità e dei multipli di tre. L'uno è il numero aldilà del quale non esiste
nulla. I numeri non possono cominciare dallo zero. Lo zero serve per mettere i
numeri in relazione tra loro.
Il tre è il numero più perfetto, non in sé (come l'uno), ma in quanto in
relazione principalmente all'uno. Il tre è intrinseco all'uno, in quanto esiste
un primato dell'uno sulla triade. La triade, da sola, non riesce a
giustificarsi. La triade che dimentica l'uno, si frantuma e perde se stessa.
L'uno invece può giustificarsi da solo, anche se, nel farlo, si rivela come
triade.
Da notare che l'infinità di un elemento della triade è irriducibile all'altro
elemento, almeno in via infinita.
La triade è universale, è presente in ogni operazione, in ogni realtà, ma
essa non rimanda all'idea d'infinito se non in quanto si pone in relazione
all'idea di uno.
Perché la circonferenza non può mai essere perfettamente suddivisa per il suo
diametro? Per la legge dell'autoconservazione. Se una figura perfetta come il
cerchio fosse perfettamente suddivisibile, esisterebbe una figura diversa dal
cerchio ancora più perfetta.
Esistono quindi dei limiti aldilà dei quali la perfezione non può andare,
altrimenti si autodistruggerebbe. Ma autodistruggersi non è segno di
perfezione.
La perfezione è tale solo se è limitata. E nel caso del cerchio, essa si
difende dalla pretesa di suddividerla all'infinito, dimostrando la propria
incommensurabilità, cioè la propria infinitezza assoluta, irriducibile al
calcolo matematico, alla logica in senso stretto.
La perfezione è unità: essa non sopporta la divisione aldilà di un certo
limite. La pretesa suddivisione all'infinito non è segno di perfezione, ma di
alienazione.
|
E' POSSIBILE UNA RIUNIFICAZIONE DEL SAPERE
SCIENTIFICO?
Sin dall'alba della scienza, gli studiosi han sempre cercato di ridurre i
fenomeni complessi ad altri più semplici, delineando un quadro generale
dell'universo sulla base di un numero ristretto di principi fondamentali.
Nell'antichità Pitagora pensava che il mondo fosse l'armonia dei numeri.
Democrito vedeva l'universo come un movimento di atomi nel vuoto. Ad Aristotele
il mondo appariva come un organismo vivente. Dal XVII al XIX sec. dominarono le
idee meccaniciste in virtù delle quali s'interpretavano tutti i fenomeni della
natura inanimata. All'inizio del XIX sec. si fecero tentativi per costruire un
quadro fisico unico del mondo, fondato sull'elettrodinamica, ma vi furono anche
ricerche per stabilire un quadro fisico-probabilistico universale del mondo.
Oggigiorno gli scienziati mirano a integrare le idee relativiste e quantiche
con la possibilità di costruire una teoria unificata di tutte le fondamentali
interazioni. I matematici, p.es., si servono degli insiemi come base universale
delle loro teorie. I biologi cercano una coerenza di fondo nei principi della
attuale biologia molecolare o della genetica o anche della teoria sintetica
dell'evoluzione. Da tempo si è scoperto che fra microcosmo e macrocosmo vi sono
affinità sorprendenti. La fisica delle particelle elementari è già all'unisono
con la cosmologia.
Si potrebbe, in un certo senso, rappresentare lo sviluppo della scienza come
una successione di programmi riduzionisti sempre più perfetti sul cammino che
conduce dalla verità relativa a quella assoluta. Si ha infatti l'impressione che
l'assolutezza della verità coincida con la sua semplicità o essenzialità e che
con tale essenzialità si sia in grado di comprendere tutta la complessità
dell'esistenza, la quale, con le sue verità relative, ha mille sfaccettature. Si
procede in avanti, aumentando la conoscenza, ma come se si tornasse indietro,
verso l'epoca in cui la conoscenza era una sola cosa con la vita. Le costruzioni
scientifiche antiriduzioniste (generalmente fenomenologiche) sono destinate ad
essere riassorbite, in quanto il processo verso l'unificazione universale del
sapere appare irreversibile.
* * *
Il riduzionismo è legato non solo a ciò che la scienza riflette, ma anche al
modo in cui essa lo fa. La conoscenza scientifica è sempre più un insieme di
varie procedure cognitive e di diversi modi d'organizzazione del sapere
acquisito, aventi un carattere integrativo. In virtù di questa esigenza
integrativa, si può addirittura arrivare a dire che il fatto scientifico non è
tanto il riflesso di un avvenimento individuale, unico, quanto piuttosto la
rappresentazione di tutta una classe di fenomeni, unificati sulla base di un
certo livello di astrazione. Noi troviamo nelle regolarità empiriche di diversi
gruppi di fatti formanti un tutto unico una maggiore generalizzazione della
realtà. E queste regolarità, a loro volta, possono essere assimilate a una
comune interpretazione, avente un numero limitato di principi fondamentali.
In sostanza, tutte le forme di organizzazione del sapere scientifico
realizzano una descrizione generalizzata della realtà, a partire dalla quale si
individua sempre più profondamente l'essenza dei fenomeni, facendo così per
tappe una riduzione che va dalle forme poco generalizzate di organizzazione del
sapere scientifico a forme sempre più generalizzate. Naturalmente questo
processo riduzionistico o riunificativo non implica né la soppressione della
diversità delle teorie e dei campi d'indagine, né la loro concentrazione in un
unico schema teoretico. Il problema, se vogliamo, sta nell'alimentare la
tensione delle singole discipline verso l'unità, ovvero nel ricercare un metodo
per stimolare questa tensione.
Il processo verso la riunificazione del sapere è reale ma non è automatico.
Ad esso non fa ostacolo l'estrema frammentazione dei metodi di conoscenza e dei
programmi di ricerca, quanto piuttosto la chiusura, il settarismo, la difesa
corporativa di arcaici privilegi. Se nel campo della fisica, ad es., vi sono
descrizioni deterministe e probabiliste, ciò rientra nella normalità, ma quando
in nome dell'una o dell'altra corrente si rifiuta il dialogo, il confronto
aperto, critico e autocritico, ecco che allora non solo la fisica ma tutta la
scienza s'impoverisce, mentre il processo di riunificazione del sapere
inevitabilmente rallenta la sua marcia.
Oggi molti ricercatori si trincerano dietro una solida argomentazione, quella
secondo cui tutto ciò che esiste nel mondo è il frutto di una evoluzione dal
semplice al complesso. Il che implica, per molti di loro, un affronto
sistematico del particolare, una specializzazione sempre più sofisticata delle
conoscenze. Questo modo di orientarsi non è in sé sbagliato, ma rischia di
diventarlo ogniqualvolta si perde il senso dell'insieme, la globalità del reale,
che per forza di cose va colto nella sua essenzialità.
* * *
Nel corso dello sviluppo della scienza il grado di unità del sapere
scientifico, che pur si ristruttura di continuo, tende ad aumentare, anche se in
apparenza sembra il contrario. Lo dimostra il fatto che le interrelazioni dei
diversi campi scientifici si rafforzano. Lo sviluppo del 'sapere fondamentale'
(quello di cui non si può fare a meno) apre possibilità sempre maggiori di
sintesi delle conoscenze acquisite, a tutti i livelli. Vi sono tuttavia dei
problemi cui la metodologia riduzionista deve far fronte con grandi capacità se
vuole realizzare i suoi obiettivi.
Anzitutto va risolta la questione del rapporto fra la parte e il tutto. Senza
dubbio, il comportamento del tutto è determinato, essenzialmente, dalle
proprietà e dal carattere dei suoi singoli elementi. Ma la riduzione delle
proprietà del tutto alle proprietà delle sue parti è possibile solo nelle
situazioni elementari dei cd. 'sistemi sommativi', che rappresentano una piccola
frazione dell'intera diversità degli oggetti realmente esistenti. Di regola, il
tutto è caratterizzato da parametri e leggi specifiche che non valgono per i
suoi elementi particolari. Così ad es., le caratteristiche del gas in movimento
dipendono da parametri termodinamici: temperatura, entropia, ecc., i quali
risultano ininfluenti per l'analisi delle sue molecole particolari. Non è certo
possibile ottenere quelle caratteristiche a partire da una descrizione meccanica
dettagliata del movimento di tutte le molecole.
La perfezione dell'insieme, rispetto a quella delle parti che lo compongono,
la si nota anche laddove le relazioni che l'insieme instaura con l'ambiente sono
determinate dal comportamento dell'insieme stesso e non da quello delle sue
singole parti. Questa situazione è tipica di tutti i livelli di organizzazione
della materia, specie di quelli più complessi. Ciò che è sostanziale per
l'insieme di un organismo è il funzionamento integrale e coordinato di ogni
singola parte: è questo che assicura la grande stabilità dei sistemi viventi in
rapporto alle variabili condizioni esterne e che accresce fortemente le capacità
di adattamento dell'organismo. La perfezione sta nel funzionamento equilibrato
del tutto, all'interno di margini più o meno flessibili, ma comunque
invalicabili, di tollerabilità. P.es., la struttura attuale dell'universo è
determinata da una grandezza che esprime la differenza di massa fra il neutrone
e il protone. Questa differenza è assai piccola, circa 10-3 della massa del
protone. Ma se essa fosse stata tre volte più grande, non avrebbe avuto luogo la
sintesi nucleare e nell'universo non esisterebbero elementi complessi.
L'intero dunque non può essere concepito come funzionante unicamente secondo
leggi che reggono gli elementi che lo compongono. Una casa di mattoni è
evidentemente una realizzazione di possibilità inerenti ai mattoni e alla calce;
ma per costruire una casa non basta conoscere le proprietà dei materiali:
bisogna possedere un progetto della casa, stabilito secondo il suo modo di
funzionare in quanto abitazione. Questo progetto, è vero, si realizzerà sulla
base delle proprietà dei materiali da costruzione, ma la sua ideazione dipende
dalle leggi di un altro livello di realtà. Del pari, il comportamento dell'uomo
è sì legato alle sue qualità naturali e sociali in quanto individuo, ma
l'essenza dell'uomo -come vuole Marx- si esprime sulla base del sistema di
relazioni sociali in cui egli è inserito. Ogni organismo vivente è determinato
non soltanto dalla sua organizzazione interna, ma anche dal suo rapporto con la
popolazione circostante e con l'insieme del mondo vivente.
Il tutto dunque non è riducibile alla somma delle sue parti e la parte non
può essere interamente compresa che nelle sue relazioni col tutto. Su questo
principio vi è un esempio significativo nel libro di W. Heinsenberg, La parte e
il tutto, laddove l'autore afferma che mentre osservava, indifferente, il
castello Elsinore, che lo scienziato N. Bohr gli indicava, ne capì l'importanza
solo dopo che quegli gli precisò che si trattava del castello in cui Shakespeare
aveva scritto l'Amleto.
La fisica moderna fornisce una testimonianza esemplare di questa simbiosi
della parte con il tutto. Come noto, l'unità fondamentale dei principali tipi
d'interazione che descrivono il comportamento delle particelle elementari, non
si è manifestata che negli stadi iniziali dell'evoluzione del cosmo. In altre
parole, l'unità reale delle interazioni elettriche deboli e forti può
manifestarsi in casi di energia che non esistono nell'attuale universo e che
potevano realizzarsi sono nei primi secondi dell'evoluzione della metagalassia
dopo il Big bang. D'altra parte, noi siamo sorpresi dall'apprendere che le
proprietà macroscopiche del mondo osservabile (esistenza di galassie, di stelle,
di sistemi planetari, di vita sulla terra) sono determinate da un piccolo numero
di costanti che caratterizzano sia le diverse proprietà delle particelle
elementari che i tipi-base delle fondamentali interazioni. P.es., se la massa
dell'elettrone fosse stata di tre o quattro volte maggiore di quella attuale, la
vita d'un atomo neutro d'idrogeno sarebbe solo di qualche giorno. Di
conseguenza, le galassie e le stelle sarebbero principalmente composte di
neutroni e l'attuale diversità fra atomi e molecole neppure esisterebbe.
* * *
Le acquisizioni della scienza moderna mostrano con evidenza che tutto quanto
esiste è frutto di una evoluzione. La teoria del Big bang, le ricerche
sull'apparizione dei sistemi prebiologici e delle prime forme di vita,
l'individuazione delle leggi di formazione e sviluppo della biosfera e delle
specie animali, gli studi di antropo- e socio-genesi permettono di descrivere le
principali tappe dell'evoluzione del mondo dall'apparizione delle particelle
elementari all'origine dell'uomo e della civiltà. 10-35 secondi dopo l'inizio
del Big bang apparve l'asimmetria barionica della Metagalassia, che si rileva
oggi dalla quantità estremamente piccola di antimateria da essa contenuta. Dopo
10-5 secondi sono venuti emergendo i barioni e i mesoni a partire dai quarks.
Nel secondo minuto di vita della Metagalassia hanno cominciato a formarsi i
nuclei dell'elio e di altri elementi leggeri. Le galassie sono comparse un
miliardo di anni più tardi e le stelle della prima generazione 5 miliardi di
anni dopo. Gli atomi degli elementi pesanti nascono in seno alle stelle. Il
sole, quale stella della seconda generazione, ha circa 5 miliardi di anni. La
terra ne ha circa 4,6. Sulla terra, i microrganismi hanno 3 miliardi di anni, le
forme macroscopiche di vita esistono da un miliardo di anni. I primi vegetali
sono apparsi 450 milioni d'anni fa, i pesci hanno 400 milioni di anni, i
mammiferi 50 e, infine, l'uomo esiste da 2 o 3 milioni di anni.
Noi deduciamo l'evoluzione dal semplice al complesso anche da moltissimi
altri processi che si svolgono nel cosmo. Soltanto nella nostra galassia
esistono centinaia di miliardi di stelle simili al sole e in tutto l'universo si
contano decine di miliardi di galassie simili alla nostra. Tutto è in perenne
evoluzione, benché la stragrande maggioranza delle linee evolutive non approdino
alla nascita della vita e dell'intelligenza. L'idea che la vita e la ragione
siano molteplici nell'universo ha giocato nella storia un ruolo progressista.
Essa infatti postula l'origine naturale della vita e della ragione, e favorisce
lo sviluppo d'un'interpretazione materialistica del mondo, antitetica a quella
religiosa. Tuttavia, alla luce delle ricerche attuali, è forse più utile
prestare attenzione alla concezione secondo cui la vita e la ragione sono uniche
nell'universo, o comunque rarissime, in quanto nessuna forma di vita
extra-terrestre è in grado per il momento di farci sostenere il contrario.
Un altro aspetto di cui bisogna assolutamente tener conto è -come già si è
detto- la possibilità che il processo evolutivo dal semplice al complesso
diventi reversibile. Se ad es. la densità della massa del nostro universo
diventasse più grande di quella critica, esso comincerebbe a comprimersi, dopo
un certo tempo, provocando una riduzione globale di tutte le forme complesse a
forme più semplici. Tale fenomeno i cosmologi prevedono che prima o poi accadrà.
L'instabilità del protone tende a convalidare questa supposizione. Il che non
implica la sconfessione di determinate leggi fisiche o chimiche, quanto, più
semplicemente, la costatazione della loro inapplicabilità alla nuova situazione
che si verrà a creare.
* * *
La scienza è in un certo senso simile alla natura vivente. Per principio, la
vita non può esistere senza tradursi in una molteplicità di forme. Così è per la
scienza. Il suo polimorfismo è condizionato non solo dalla diversità reale del
mondo, ma anche dalle differenze che esistono negli statuti epistemologici del
suo apparato concettuale, la cui efficacia muta col mutare delle situazioni
cognitive. L'unità della scienza non sta nella ricomposizione, peraltro
impossibile, delle sue tecniche di ricerca o dei suoi criteri cognitivi e
interpretativi, quanto piuttosto nella interconnessione sempre più stretta fra
diversi campi scientifici, il cui compito principale è quello di riflettere
adeguatamente l'essenza della realtà.
Tutto ciò che esiste è caratterizzato dall'unità e dalla diversità: né l'una
né l'altra possono sussistere o essere comprese separatamente. Il riduzionismo
può aiutarci in questa esigenza riunificativa, ma esso dovrà comunque riflettere
la specificità dei fenomeni, se non vorrà rischiare di offrire un'immagine
semplicistica delle interrelazioni fra unità e diversità. Pertanto, se vogliamo
concretizzare il desiderio di una ricomposizione del sapere scientifico,
dobbiamo farlo con la pazienza di chi sa rispettare le conquiste scientifiche di
ogni singola disciplina. |
|
SCIENZA E FILOSOFIA VERSO IL
FUTURO
Una delle particolarità essenziali dello sviluppo della scienza consiste nel
fatto ch'essa si orienta verso lo studio di oggetti che già sono di uso comune o
che potranno diventarlo. Ma perché questa seconda caratteristica abbia qualche
garanzia di successo, occorre che il progresso scientifico disponga di un
sistema categoriale adeguato.
Per molto tempo, ad es., i fisici hanno cercato di presentare i solidi, i
liquidi e i gas come un sistema puramente meccanico di molecole. E' stato lo
sviluppo della termodinamica a rivelare l'insufficienza di questa concezione. Ma
in seguito, con la nuova teoria, si cominciò a sostenere che i processi fortuiti
nei sistemi termodinamici non erano qualcosa di esterno al sistema, ma ne
costituivano l'essenza interna, determinante lo stato e il comportamento del
sistema stesso. Con lo sviluppo della fisica quantistica si è poi scoperto che
le categorie di necessità e di contingenza vanno viste in una unità dialettica,
e che occorre rinunciare all'identificazione deterministica che Laplace poneva
fra causalità e necessità, utilizzando invece attivamente la categoria del
'potenzialmente possibile' per la descrizione dei processi dell''infinitamente
piccolo'. In una parola, una struttura categoriale adeguata -che risponda
anzitutto al principio della irriducibilità del tutto alla somma delle parti-
appare, allo stesso tempo, come premessa e condizione della conoscenza e della
comprensione di nuovi oggetti e fenomeni.
Senza dubbio, il compito di elaborare strutture categoriali che permettono di
uscire dal quadro dei modi tradizionali di percezione e d'interpretazione degli
oggetti, viene realizzato per gran parte dalla filosofia. La filosofia anzi è
stata capace di offrire le direttive categoriali necessarie alla ricerca
scientifica prima che la scienza cominciasse a padroneggiare gli oggetti che
corrispondevano a quelle categorie. Le quali, ovviamente, in virtù della ricerca
scientifica, si svilupparono ulteriormente, trovando quelle conferme empiriche
che la filosofia non poteva dare.
Resta vero però che senza una continua riflessione filosofica sulla scienza,
nessuna direttiva categoriale può arricchirsi di veri nuovi contenuti. Ciò non
significa che la filosofia sia di per sè sufficiente a risolvere i problemi
delle scienze naturali. La scienza è un aspetto particolare della cognizione
filosofica della realtà e la ricerca filosofica rappresenta uno dei presupposti
necessari dello sviluppo delle scienze naturali, benché questo sviluppo si
realizzi solo a condizione che le scienze siano autonome.
Un semplice confronto fra la storia della filosofia e quella delle scienze
naturali indica assai chiaramente le performances anticipatrici della filosofia
in rapporto alle scienze concrete. E' sufficiente ricordare che l'idea
dell'atomismo, essenziale per le scienze della natura, apparve nei sistemi
filosofici del mondo antico e in seguito si sviluppò all'interno di diverse
scuole filosofiche, finché le scienze naturali e il progresso tecnico
raggiunsero un livello idoneo a trasformare una intuizione o speculazione di
tipo filosofico in un fatto scientifico.
Si può anche evidenziare, ad es., che numerosi aspetti dell'apparato
categoriale sviluppato dalla filosofia di Leibniz vanno visti in relazione ai
cosiddetti 'grandi sistemi' e non certo in relazione alle scienze naturali del
XVII sec., dominate da una concezione puramente meccanicista del mondo. Nella
sua monadologia Leibniz sviluppò idee che per gran parte risultavano alternative
al meccanicismo (ad es. quelle riguardanti il rapporto fra la parte e il tutto o
fra la causalità, la virtualità e la realtà, che ricordano da vicino certi
modelli della cosmologia moderna e della fisica delle particelle
elementari).
La filosofia insomma scopre per intuito o anche per un ragionamento logico
ciò che la scienza arriva a dimostrare concretamente solo dopo un periodo di
tempo più o meno lungo. Ovviamente la filosofia è capace di questo solo nella
misura in cui si rapporta a tutta la realtà sociale e culturale (inclusa la
scienza stessa). Ed è altresì ovvio che non necessariamente la scienza giunge a
fare determinate scoperte sulla scia delle cose intuite o pensate dalla
filosofia. Sarebbe assurdo sostenere che i modelli cosmologici di Fridman o di
Planck, che pur si accostano al quadro d'interazione delle monadi, si rifanno
direttamente alla filosofia di Leibniz. Al massimo si potrà parlare di influenza
mediata (dalla storia della filosofia, come di tutta la cultura) delle idee di
Leibniz sull'epoca contemporanea.
Infine si può ricordare che è stata la filosofia a scoprire per prima la
capacità di autosviluppo degli oggetti, oggi ritenuta di fondamentale importanza
dalla scienza. Nell'ambito della filosofia sono stati elaborati i principi dello
storicismo, i quali esigono che si esamini un oggetto tenendo conto del suo
sviluppo precedente e della sua facoltà evolutiva (si pensi al contributo che
l'idealismo hegeliano ha dato alla comprensione del fatto che la contraddizione
è una forza motrice di ogni sistema vitale e di pensiero).
* * *
Detto questo, è necessario ora ridimensionare le pretese 'profetiche' della
filosofia e rassicurare i sostenitori dell'autonomia della scienza, dimostrando
che l'una e l'altra disciplina trovano la loro ragion d'essere all'interno del
contesto storico e culturale in cui si sviluppano. Cerchiamo di spiegarci con un
esempio. Quando si usa il concetto di 'spazio', il suo significato non è sempre
quello offerto dalle opere scientifiche e filosofiche. Lo spazio come categoria
della cultura è integrato nel tessuto della lingua quotidiana: quando usiamo le
parole 'qui', 'là', 'alto', 'basso' ecc., noi ci serviamo inconsciamente della
nozione di spazio, la quale organizza il senso di questo parole. In quanto
categoria culturale lo spazio funziona nelle opere artistiche, nelle
rappresentazioni che l'uomo generalmente si fa dell'ambiente in cui vive, nel
senso comune, ecc. La spiegazione filosofica o scientifica di questa categoria
non forma che uno degli aspetti del suo senso socio-culturale, per cui quando si
esaminano i principali significati della parola 'spazio' occorre tener conto
della struttura categoriale del pensiero di questo o quel contesto
storico-sociale.
Quando si realizza un approccio del genere, la categoria dello spazio appare
sempre sotto il suo aspetto storico concreto, il quale predetermina non solo la
comprensione e l'interpretazione, ma anche l'esperienza del mondo da parte
dell'uomo. Prendiamo ad es. la rappresentazione dello spazio nella scienza
medievale. Questa scienza aveva per concezione cosmologica principale il sistema
geocentrico di Tolomeo, leggermente modificato secondo lo spirito delle idee
religiose dominanti (la sfera dell'empireo, soggiorno delle anime e degli
angeli, è stata aggiunta a quella dei pianeti, del sole e degli astri immobili).
La fisica di quell'epoca considerava il movimento dei corpi in accordo con la
concezione aristotelica: ogni corpo tende ad occupare il suo posto.
L'interpretazione in termini di 'concezione del mondo' sanzionò questa visione
delle cose come unico schema possibile, aggiungendovi solo degli elementi
assiologici: ad es. i corpi pesanti cadono sulla terra perché la materia
'peccaminosa' li attira verso il basso, mentre i corpi leggeri tendono verso
l'empireo; i movimenti terrestri sono destinati al disordine mentre, al
contrario, i corpi celesti descrivono cerchi perfetti, ecc.
Furono proprio queste concezioni dello spazio, fuse nella fabbrica della
scienza medievale, che costituirono uno dei principali ostacoli all'apparizione
delle scienze naturali, cioè all'elaborazione di una sintesi fra la descrizione
matematica della natura e il suo studio sperimentale. E perché si potesse
formare una nuova concezione dello spazio, è stato necessario superare
radicalmente tutte le categorie della cultura medievale: il che è cominciato ad
accadere durante il Rinascimento, ovvero con i primi germogli della produzione
capitalistica e dell'ideologia borghese. Le grandi scoperte geografiche,
l'estensione delle migrazioni (durante l'epoca della primitiva accumulazione,
allorché i contadini rovinati erano costretti ad abbandonare le terre), la
distruzione dei legami corporativi tradizionali e altre cose ancora,
contribuirono a riformulare completamente il concetto fisico di spazio, e non
solo nell'ambito della scienza ma anche in tutte le sfere della cultura.
Ed è significativo, in questo senso, che la nuova concezione di uno spazio
omogeneo e isotropico (in cui tutti i punti e tutte le direzioni sono
fisicamente identici) abbia trovato un riflesso nelle arti plastiche
rinascimentali: la pittura, ad es., comincerà a organizzarsi in funzione della
prospettiva lineare dello spazio euclideo, che viene percepito come un dato
reale e sensibile della natura. E non è forse vero che esiste -come molti oggi
hanno costatato- un certo parallelismo fra le idee della relatività in fisica e
l'impressionismo in pittura?
* * *
La ricostruzione di un modello categoriale del mondo è legata alle svolte che
si compiono nella storia umana, poiché essa implica la trasformazione non solo
dell'immagine del mondo umano, ma anche dei tipi di personalità ch'essa produce,
ovvero del loro atteggiamento verso la realtà e dei loro orientamenti normativi.
Gli schemi generalizzati della concezione del mondo, rappresentati dalle
categorie della cultura, molto spesso concordano con gli interessi di
determinate classi e gruppi sociali.
Questa è la ragione per cui in una società divisa in classi una stessa mappa
di categorie culturali può essere interpretata assai diversamente.
Organizzandosi in modo conforme alla struttura categoriale del pensiero
dominante di un'epoca, la coscienza di classe vi introduce abitualmente dei
significati o delle concretizzazioni specifiche, che esprimono appunto gli
orientamenti della classe corrispondente. Questo riguarda soprattutto le
categorie della cultura, che caratterizzano l'uomo, con i suoi valori e la sua
attività.
Qualunque modello categoriale, storicamente determinato, del mondo, sia esso
scientifico o filosofico, sussiste finché è in grado di assicurare la
riproduzione o comunque la coesione di quelle attività di cui la società ha
bisogno per sopravvivere. Tuttavia, nella misura in cui si sviluppa la
produzione economica e appaiono nuove forme di attività socio-culturale e
professionale, si fa strada anche il bisogno di nuovi orientamenti (relativi
alla concezione del mondo), che assicurino la transizione a forme più
progressiste della vita sociale. Conditio sine qua non di questo
passaggio è la trasformazione delle strutture categoriali del pensiero. Essa si
verifica sulla base del confronto degli interessi di classe, allorché una nuova
classe progressista si fa portavoce di idee ch'essa propone a fondamento della
vita di tutta la società, presente e futura.
La filosofia, come qualunque altra scienza della cultura, ha il compito di
esplicitare i mutamenti che avvengono in forma embrionale, spesso allo stato
latente, nella coscienza degli uomini. In particolare, la conoscenza filosofica
deve individuare, nell'infinita diversità dei fenomeni culturali, i significati
categoriali comuni che li attraversano. E nel far questo non deve limitarsi a
usare le nozioni astratte e logiche, ma anche le metafore, le analogie, le
immagini figurate. Nei sistemi filosofici relativamente avanzati dell'antichità
numerose categorie fondamentali portavano l'impronta d'un riflesso simbolico e
metaforico del mondo (il 'fuoco' di Eraclito, il 'nous' di Anassagora, ecc.).
Ciò è ancora più vero nelle filosofie antiche dell'India e della Cina. La
costruzione concettuale, qui, non è quasi mai separata da una base immaginifica.
L'idea anzi veniva espressa più sotto una forma artistica che non astratta e
l'immagine appariva come il modo principale di percepire la realtà
dell'essere.
Questa esigenza simbolica e metaforica è presente anche nella sfera
scientifica, che pur è sottoposta a standard logici assai rigorosi. Ed è
presente anche nella letteratura, nelle arti, nella critica estetica, nel
pensiero politico e giuridico, nel senso comune: Manzoni e Leopardi, Tolstoi e
Dostoievski hanno saputo esprimere in un linguaggio letterario un coerente
sistema filosofico, paragonabile a quello di Schopenhauer o di Hegel.
Resta comunque significativo che l'apparizione della filosofia, come modo
particolare di conoscenza del mondo, emerga nel corso di un periodo segnato da
una delle svolte più radicali dell'evoluzione sociale, quella del passaggio
dalla società clanica e tribale a quella divisa in classi. Questo forse implica
-è solo una domanda- che la futura ricomposizione dell'umanità in un sistema
sociale senza classi sarà caratterizzata, fra le altre cose, anche dal
definitivo superamento della conoscenza filosofica? E' improbabile. E' possibile
invece pensare che l'uso della conoscenza filosofica non sarà più così
facilmente manipolabile da determinati interessi di parte. E comunque se tale
abuso avverrà, occorreranno grandi capacità di falsificazione, cui però
inevitabilmente si contrapporranno non meno forti capacità di
smascheramento.
* * *
I compiti della ricerca filosofica non si sono mai limitati all'analisi della
scienza, benché nella tradizione culturale europea, dall'epoca della formazione
delle scienze naturali, la generalizzazione delle acquisizioni di tali scienze
sia stata una via essenziale delle categorie filosofiche. La filosofia deve
anche risolvere problemi inerenti alla concezione del mondo: il significato
della vita, il valore intrinseco delle cose, ecc. Essa cioè deve elaborare e
sviluppare categorie e principi che le scienze naturali, in seguito,
selezioneranno, per farne propri fondamenti filosofici. In particolare, le
scienze naturali assumono quei principi che servono loro a comprendere i
rapporti dialettici e assai mutevoli di soggetto e oggetto, di uomo e natura, di
ambiente e civiltà... La forte presenza del cosiddetto 'fattore umano' (si pensi
alla biosfera, ai sistemi uomo-computer, alla genetica umana, ecc.) costringe
tutte le scienze ad affrontare in maniera sempre più sistematica e approfondita
gli aspetti ontologici e normativi della concezione del
mondo. |
|
LA SCIENZA OCCIDENTALE

Oggi la scienza occidentale è tanto più specialistica quanto più inutile.
Cioè la sua utilità è strettamente legata agli interessi di potere, politico o
economico, dell'occidente e quindi a una parte relativamente ristretta del
mondo.
La scienza occidentale è diventata "di parte" (o forse lo è sempre stata),
nel senso che non si pone al servizio degli interessi della comunità
internazionale, anzi li danneggia.
Le ricerche sono diventate ormai così settoriali che gli investimenti per
sostenerle sono assolutamente sproporzionati rispetto alla ricaduta positiva
sulla gran parte del genere umano dei risultati che si ottengono. Non è quindi
una scienza conveniente sul piano economico.
Peraltro non si tiene neppure in considerazione che gli sviluppi progressivi
della scienza occidentale contribuiscono non a risolvere ma ad accentuare i
problemi del Terzo mondo, che sono poi i problemi causati dallo stesso rapporto
ineguale tra Nord e Sud e che, se non risolti, porteranno al crollo
dell'occidente e della sua stessa scienza.
L'occidente sbandiera la propria scienza come un qualcosa di "universale",
quando tutti sanno che l'universalità delle cose non è data tanto dalla loro
diffusione quanto piuttosto dalla loro facilità d'uso, e
soprattutto dalla loro riproducibilità - e questo, con l'alta
specializzazione tecnologica della scienza occidentale, oggi non è più
possibile.
Nell'ambito dell'imperialismo la scienza occidentale è in grado di riprodursi
facilmente nei paesi del Terzo mondo grazie alle filiali delle multinazionali,
che concentrano nelle mani di poche persone l'enorme bagaglio di conoscenze
acquisite in occidente.
Tuttavia questa scienza esportata non serve alle nazioni che ospitano le
multinazionali, se non alle poche persone che ne ricavano un guadagno indiretto.
Serve piuttosto alle multinazionali e ad arricchire il personale che lavoro
attorno a queste imprese, che è sempre un numero ristretto di persone.
Il capitalismo appare ogni giorno di più come un sistema economico mondiale
che serve gli interessi di una fascia limitata di persone.
Il prossimo sistema economico dovrà dunque essere basato su una "democrazia
sociale", cioè non meramente "politico-parlamentare". Ci vorrà una democrazia di
tipo "diretto", non "delegato", una democrazia "autogestita", non
"centralizzata", una democrazia basata sulle leggi di autovalorizzazione non del
capitale ma dello stesso essere umano.
PER UN SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLA SCIENZA OCCIDENTALE
Tempo fa si diceva che la religione non è una scienza, per cui non può unire
gli uomini, ma soltanto dividerli. Anzi, è già molto che una fede religiosa
riesca a tenere uniti gli stessi credenti che la professano, poiché la storia
sta lì a dimostrare con infiniti esempi proprio il contrario: basti vedere le
enormi diversità che caratterizzano le tre fondamentali correnti cristiane:
ortodossa, cattolica e protestante.
Essendo soltanto un riflesso di interessi materiali di parte, la religione,
come ogni altra ideologia non umanistica o non democratica, tutela sempre le
classi privilegiate, anche quando sostiene, in via di principio, per ingannare
le masse, di voler fare il bene comune.
D'altra parte non esistono ideologie, neppure quelle che si dicono
"proletarie", che di per sé garantiscano contro gli abusi pratici che dei loro
principi si può fare; e gli abusi avvengono, in genere, proprio da parte di chi
si sente coinvolto in prima persona nella realizzazione di quei principi.
Oggi però sarebbe stupido sostenere che la scienza ha più capacità di unire
che non la religione. La scienza cui si fa generalmente riferimento, quando se
ne parla, è una sola: quella occidentale, cioè quella sorta con la
teorizzazione galileiana dello sperimentalismo induttivo. La concezione di
"scienza" che abbiamo ancora oggi è quella che considera l'uomo superiore
alla natura e questa un oggetto di sfruttamento puro e semplice.
Come noto, le religioni hanno contrastato questa posizione non perché
considerassero la natura superiore all'uomo (per trovare una concezione del
genere bisogna risalire alle primitive religioni animistiche o totemiche, forse
le uniche vere "religioni", in quanto quelle monoteistiche sono delle vere e
proprie "teologie", specie il cristianesimo), quanto perché nella pretesa
superiorità dell'uomo sulla natura, la scienza tendeva a escludere la dipendenza
dell'uomo nei confronti di qualsivoglia divinità.
Le religioni monoteistiche si sono opposte allo sviluppo della scienza non
per difendere la natura o l'uomo naturale, ma per un interesse di parte, in
quanto l'ateismo della scienza faceva perdere loro prestigio, credibilità e, in
definitiva, potere politico e culturale.
Ecco perché oggi una qualunque critica alle teorie scientifiche che pongono
l'uomo al di sopra della natura non ha bisogno, per essere efficace, di rifarsi
a qualche ideologia religiosa. Oggi la scienza occidentale va contestata dal
punto di vista dello stesso umanesimo laico che l'ha generata, anche se
con tale umanesimo, all'inizio, si pensava che l'uomo potesse fare a meno di una
qualsivoglia dipendenza non solo da dio ma anche dalla natura.
Nel secolo XVI l'umanesimo laico era di tipo borghese, cioè settario,
immaturo, condizionato dall'arroganza di ciò che, sul piano religioso, l'aveva
preceduto nei secoli: il cattolicesimo-romano, che a quell'epoca cominciò ad
assumere la forma esteriore del protestantesimo, molto più adatta alla pratica
individualistica della classe borghese.
Oggi dobbiamo darci una sorta di ideale di vita che vada al di là non solo di
ogni religione, ma anche della stessa scienza occidentale, poiché se ciò che si
presume "scientifico" si pone contro gli interessi riproduttivi della
natura e quindi, di conseguenza, dello stesso genere umano, di "scientifico"
questa teoria e questa prassi (che è la tecnologia) non hanno proprio nulla.
Oggi dobbiamo considerare come autenticamente "scientifico" solo ciò che tutela
un rapporto equilibrato tra natura e uomo.
Sembra un dire banale, scontato, eppure, se guardiamo lo sviluppo del
marxismo-leninismo, ci si accorgerà di quanto questo dire risulti praticamente
sconosciuto a questa ideologia, che pur indubbiamente, per chi è "proletario",
resta la punta più avanzata della riflessione teorica europea.
I classici del marxismo non hanno mai messo in discussione la superiorità
dell'uomo sulla natura, che si pensava definitivamente acquisita proprio in
virtù della rivoluzione tecno-scientifica.
Oggi una qualunque realizzazione del socialismo democratico non può tenere in
considerazione soltanto le problematiche della giustizia sociale ed economica,
deve anche porre all'ordine del giorno il rapporto uomo-natura, connesso al
quale vi è il discorso, ben più complessivo, riguardante il senso generale della
civiltà industriale. |
|
DAVVERO NON ESISTE UNA SCIENZA
PROLETARIA?
Premessa
Ancora ai tempi di G. Lukács si sosteneva, in ambienti marxisti, che la
scienza poteva essere divisa in "borghese" e "proletaria", essendo la prima
un'ideologia travestita da scienza, che difende interessi di classe, mentre la
seconda è la vera scienza che difende gli interessi del popolo lavoratore.
La differenza di principio era nata negli anni Trenta, quando in Russia si
sosteneva fosse "borghese" la scienza darwinista che si opponeva a Trofim
Lysenko, alla sua idea dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Lysenko, il
biologo favorito di Stalin, nel 1948, e per più di quindici anni, riuscì ad
imporre in Urss una situazione dittatoriale nella comunità scientifica
attraverso l’abolizione della genetica mendeliana e l’imposizione di una teoria
neolamarckista, secondo cui l'eredità dei caratteri sarebbe influenzata da
fattori ambientali e che, in onore dell’agronomo russo Ivan Micurin - pioniere
di tale concezione -, fu battezzata "micurinismo".
La contrapposizione di una pretesa “scienza proletaria” alla “scienza
borghese” era un motivo tipicamente “bogdanoviano” che, all’inizio degli anni
Trenta, divenne il tema portante dei normalizzatori staliniani, protagonisti
prima dell’attacco all’ecologia, poi a quello della genetica mendelliana.
Osteggiata da vari scienziati sovietici, questi finirono col pagare di persona:
da N. Vavilov a N. Tulajkov, G. D. Karpečenko e altri ancora.
Lysenko andò in pensione nel 1965, ma restò un accademico temuto fino al
1975, quando Brežnev lo fece espellere dall'Accademia con la motivazione che "la
politica deve poter intervenire nell'orientamento delle ricerche". I danni che
aveva fatto subire all'agricoltura sovietica erano stati enormi.
Negli anni Cinquanta, Jean-Toussaint Desanti (1914-2002) scriveva un saggio
intitolato Science bourgoise, science prolétarienne per esaltare la
seconda. Poi ci ripensò.
Negli anni Sessanta e Settanta le femministe americane denunciano la scienza
borghese dei maschi bianchi e privilegiati.
Dagli anni Novanta la scienza è "borghese" per i militanti terzomondisti, in
quanto nega qualunque valore a tutto ciò che non è occidentale.
Oggi il socialismo è arrivato alla conclusione che la scienza non può essere
in sé aggettivata: semmai è il suo uso che deve esserlo.
Come reimpostare il problema
Perché oggi si sostiene che non esiste e mai esisterà una "scienza
proletaria"? Il motivo principale sta nel fatto che dicendo "proletaria" si teme
d'essere accusati di non fare "scienza" ma "ideologia", cioè di dire cose non
perché oggettivamente vere ma perché politicamente strumentali, finalizzate
appunto a una posizione di parte.
Ma il motivo è anche un altro: il marxismo ha avuto la pretesa di dimostrare,
servendosi della scienza borghese, che il capitalismo ha in sé delle
contraddizioni così antagonistiche che ne rendono inevitabile il superamento in
direzione del socialismo. E' la stessa scienza economica borghese che porta a
questa conclusione, ovviamente a condizione che si faccia del nesso
capitale/lavoro un'antinomia di fondo, un insanabile contrasto.
Detto questo, gli economisti borghesi continuano a sostenere che in realtà
non vi sono alternative praticabili al capitalismo, e quelli socialisti
insistono nel dire che, andando avanti di questo passo, il capitalismo è
destinato a rendere sempre più invivibile la vita sociale e civile. Entrambi gli
schieramenti, quando parlano di "scienza", non mettono mai in discussione i
principi generali su cui essa si fonda, che sono poi quelli stabiliti con la
nascita dell'umanesimo, con la nascita dello sperimentalismo galileiano, con la
nascita di tutte quelle riflessioni filosofiche che hanno voluto porre l'uomo al
disopra della natura.
La scienza borghese s'illude di poter considerare il sistema capitalistico
una formazione sociale di tipo non "storico" ma "naturale"; e la scienza
proletaria ha la pretesa di dire esattamente il contrario. Davvero dunque la
differenza tra le due scienze si pone solo a questo livello? Davvero non
possiamo pretendere una vera scienza "proletaria", che non sia semplicemente una
diversa interpretazione dei fatti economici, fatta salva una base borghese
condivisa?
Una "scienza proletaria" andrebbe anzitutto intesa in senso
"antiscientifico", cioè in un senso che rimetta in discussione i presupposti
stessi della scienza su cui si è edificata la società borghese e su cui si
vorrebbe edificare anche quella socialista, pur nella variante del primato
concesso al lavoro, intrinseco a una previa socializzazione dei mezzi
produttivi.
Sono in realtà proprio questi stessi "mezzi produttivi" che vanno ripensati.
Aspirare a socializzarne la gestione non serve a nulla, se prima non ci si
chiede qualcosa di sostanziale sulla loro legittimità. Una vera "scienza
proletaria" non può più darla per scontata.
Alla luce di quanto accaduto alla natura, in questi ultimi due secoli,
occorre rimettere in discussione la legittimità degli stessi mezzi produttivi, i
quali, nati in ambito borghese, dovrebbero essere ereditati (e nel "socialismo
reale" lo sono effettivamente stati) dalla futura società socialista, stando
alle previsioni dei classici del marxismo.
In 70 anni di "socialismo reale" non abbiamo soltanto sperimentato
l'illusorietà di far coincidere "socializzazione" dei mezzi produttivi con la
loro "statalizzazione" (con tutto quel che di antidemocratico, sul piano
politico e culturale, ha comportato un'equiparazione del genere). Abbiamo anche
sperimentato l'illusorietà di poterci risparmiare conseguenze nefaste
sull'ambiente solo perché la proprietà dei mezzi produttivi era state resa
"pubblica".
Una "scienza proletaria" dovrebbe dunque essere una scienza che si rifà in
toto alle leggi della natura. Il vero "proletario" è colui che, non
possedendo nulla, si lascia "possedere" dalla natura. Lascia cioè che sia la
natura a dettargli le condizioni della propria esistenza in vita.
Il "proletario" diventa un "soggetto di natura", colui che non usa nulla che
possa ostacolare i processi riproduttivi di chi gli offre i beni essenziali per
sopravvivere.
Il moderno "proletario" non fa soltanto un discorso di socializzazione dei
mezzi produttivi, ma anche uno sull'uso ecocompatibile di tali mezzi. E
considera quest'uso prioritario su tutto, l'unico vero parametro per stabilire
il grado di benessere, il livello di vivibilità, di umanizzazione di una
qualunque comunità sociale. |
SUL CONCETTO DI TEMPO IN EINSTEIN
Fino ad Einstein, come noto, tempo e spazio erano separati e considerati
oggettivamente, sulla base della geometria euclidea soprattutto. Lo spazio aveva
tre dimensioni e il tempo era misurato con calendari di tipo solare o
lunare.
Con Einstein tempo e spazio diventano una cosa sola, nel senso che, a causa
della velocità della luce, essi s'influenzano reciprocamente. Il tempo ha smesso
d'essere una questione oggettiva, indipendente dalle sensazioni e opinioni
dell'uomo.
Einstein in pratica fa capire che quanto più aumenta la nostra velocità nello
spazio (rapportata a quella della luce), tanto più il tempo rallenta.
Senza dubbio, tale formula, considerata astrattamente, è vera, ma solo se
l'uomo si pone in una condizione spazio-temporale metastorica. Nel senso cioè
che quella formula, che pur pretende d'essere vera sul piano “fisico”, può
riferirsi a una “fisica” di cui l'uomo comune ha ben poco bisogno.
Peraltro Einstein cercò di applicare quella formula anche al livello
metafisico, elaborando una propria concezione della relatività.
Si può accorciare il tempo? Si, relativamente, cioè sino a un certo punto. Lo
si può fare oggettivamente? No di certo. Se io mi sposto da un fuso orario a un
altro, posso accorciare o allungare il tempo, ma è sempre in riferimento al mio
tempo iniziale: nessun altro si accorgerà di questo mutamento.
Il tempo non dipende unicamente dalla nostra percezione soggettiva: esso ha
una propria oggettività il cui significato ultimo, per il momento, ci sfugge,
poiché tutti noi siamo suoi “figli” e suoi “padri”. Come non riusciamo a vedere
l'inizio del tempo, così non ne vediamo la fine.
Non esiste un punto di riferimento preciso che non sia la nostra nascita
personale, che peraltro non è dipesa da noi. Noi non possiamo prendere come
punto di riferimento neanche la nostra morte, al fine di chiudere, con un
segmento, i due punti della nostra vita.
L'unico tempo veramente oggettivo che possiamo esaminare è quello degli altri
che ci hanno preceduti e che sono morti. Noi ci dobbiamo rapportare a questi
morti (coltivando una forte memoria storica) e vivere il nostro tempo,
conformemente alle sue specifiche esigenze: un tempo (presente) che sicuramente
risulterà molto più chiaro a chi verrà dopo di noi. Nessuno può pretendere di
vivere oltre il proprio tempo: sono i posteri che devono decidere se in che
misura lo meritiamo.
Einstein, se vogliamo, non ha scoperto la quarta dimensione dell'universo, ma
ha evidenziato che nell'epoca contemporanea gli uomini hanno una grande angoscia
del tempo (che passa). Sempre più infatti ci si chiede che senso abbia lo
scorrere del tempo, visto che questo fluire spesso è foriero di immani
catastrofi, come ad es. le due guerre mondiali.
Gli esseri umani hanno perso il senso del tempo, proprio perché hanno perso
il senso della storia e il significato della loro stessa vita. Gli uomini
vorrebbero ridurre a un nulla il tempo, proprio perché sanno che il fluire di
questa dimensione implica un'assunzione di responsabilità, cioè il bisogno di
aumentare l'impegno personale e collettivo nel cercare di risolvere i problemi
dell'umanità.
Il tempo insomma è una dimensione in cui l'uomo deve giocarsi la sua libertà.
In un certo senso è il tempo stesso, col suo carattere di unidirezionalità, che
costringe l'uomo a tener conto ch'esiste un irreversibile processo in
avanti.
Il tempo non è una condizione che ci obbliga, fatalisticamente, a fare
determinate cose. E' soltanto una dimensione vincolante, all'interno della quale
possiamo muoverci con relativa libertà (la libertà “assoluta”, storicamente
parlando, non esiste).
Chi tiene conto del tempo e lo vive in uno spazio adeguato (necessariamente
“sociale” e in sintonia con le esigenze della società), non resta indietro, ma è
conforme alla velocità del tempo.
Mettere in rapporto la propria velocità a quella della luce non ha senso per
l'uomo di questo mondo. Lo spazio in cui l'uomo deve vivere resta quello
euclideo. Il resto è speculazione arbitraria.
Non a caso le teorie di Einstein portano a credere che il tempo, in ultima
istanza, non esista, in quanto esiste solo la percezione soggettiva che ne
abbiamo. Il tempo è uguale all'eternità e questa è uguale al nulla. Siamo in
pieno nichilismo.
Di conseguenza, anche il movimento della massa (o materia) è illusorio,
irreale, in quanto -secondo Einstein- non esistono punti di riferimento
oggettivi in grado di misurare la velocità della luce.
E così il cerchio si chiude: Einstein è tornato alla fissità astratta di
Parmenide e alle assurdità delle ipotesi di Zenone.
QUALE TEORIA COGNITIVA?
La teoria della conoscenza è il campo della filosofia che ha cominciato a
giocare un ruolo eccezionale nello sviluppo delle scienze della natura in
correlazione con i mutamenti rivoluzionari che conosce la scienza del nostro
secolo. Qualsiasi rivoluzione scientifica implica che siano ripensati e talvolta
radicalmente rivisti i fondamenti scientifici di questa o quella disciplina o
anche di tutto un campo della ricerca.
Nelle passate rivoluzioni scientifiche erano i mutamenti delle concezioni
ontologiche che venivano a integrarsi direttamente in un certo quadro
scientifico del mondo e che servivano da nucleo ai programmi della scienza.
Così, ad es., la rivoluzione scientifica dei secoli XVI e XVII sarebbe stata
impossibile senza una revisione delle idee sulla struttura del cosmo (si pensi
al rifiuto dell'idea dell'eterogeneità del mondo in favore della sua
omogeneità), sul ruolo dell'uomo e della sua attività nell'universo (superamento
dell'opposizione fra natura 'naturale' e attività umana 'artificiale') e su
altre cose. Oggi invece la scienza è arrivata a un punto tale di sviluppo che
ogni suo ulteriore progresso dipende dalla consapevolezza che essa stessa ha o
deve avere dei metodi e dei risultati della propria attività cognitiva.
Lo sviluppo della scienza contemporanea è caratterizzato da una crescente
complessità degli strumenti di ricerca, empirici e teorici. Ciò comporta delle
difficoltà interpretative circa i sistemi cognitivi, relativamente alle loro
possibilità e ai loro limiti applicativi. Gli elementi di riflessione nel
pensiero scientifico teorico sono aumentati a dismisura in quest'ultimo secolo.
Paradossalmente, la scienza contemporanea è diventata così sofisticata che per
potersi riprodurre efficacemente ed essere veramente di aiuto al genere umano,
ha bisogni di riprendere i rapporti con la filosofia o comunque con una
disciplina gnoseologica che sappia cogliere in profondità i fondamenti del
sapere scientifico teorico e i problemi ontologici ch'esso pone.
Il giusto processo emancipativo della scienza dalla tradizionale filosofia
idealistica rischia di ritorcersi contro la scienza stessa, se questa non riesce
a misurarsi con una teoria cognitiva adeguata alle sue esigenze. Le accese
discussioni che già oggi avvengono sui fondamenti della matematica, sulla
meccanica quantistica, sulla cosmologia, sulla teoria dell'evoluzione biologica,
ecc., dimostrano che il problema è reale. A. Einstein, W. Heisenberg, N. Bohr,
O. Hilbert, L. Brauer hanno affrontato sistematicamente complesse questioni
gnoseologiche, epistemologiche e filosofico-metodologiche.
Si badi, il problema non è quello di tradurre in nozioni filosofiche
determinate concezioni scientifiche, ma quello di capire come un certo insieme
di idee filosofiche può giocare un ruolo decisivo nel momento stesso della
formulazione d'un programma concreto di ricerca scientifica. Occorre cioè
prendere consapevolezza che la riflessione gnoseologica è un mezzo
indispensabile per superare i modelli stereotipati del pensiero. Si pensi solo a
quanti nuovi problemi epistemologici conduce lo sviluppo delle scienze naturali
(ad es. il principio antropico in cosmogonia).
Un altro aspetto di cui bisogna sempre più tener conto, in quanto uno
sviluppo incontrollato della scienza e della tecnica oggi potrebbe portare a
conseguenze molto più pericolose di quelle a cui si poteva andare incontro nel
passato, è la cosiddetta 'umanizzazione' del sapere scientifico. Si tratta cioè
di sviluppare intensivamente delle discipline che studino l'uomo e la società:
ricerche sociologiche, psicologiche, teorico-culturali (linguistica, semiotica,
scienze umane...) ecc. L'esigenza di 'umanizzare' il sapere -che non si poneva
in maniera così acuta all'inizio del secolo- è forse in grado di anticipare la
futura fusione (già da Marx prevista) delle scienze naturali e sociali in
un'unica scienza fondata sul problema dell'uomo. Tale fenomeno, a ben guardare,
è il prodotto non tanto dello sviluppo naturale di talune discipline
scientifiche, quanto piuttosto del progresso scientifico in se stesso, nonché la
conseguenza di mutamenti radicali avvenuti nella relazioni fra scienza, società
e cultura.
L'umanità oggi è posta di fronte all'arduo problema di come gestire la
scienza attraverso l'intera società civile. Per risolvere questo problema
occorrerebbe prima rispondere a tutta una serie di quesiti molto complessi: ad
es. quali sono i criteri di scientificità? qual è il ruolo della scienza nel
sistema della cultura e dell'attività umana? qual è il rapporto della conoscenza
scientifica con altri tipi di apprendimento? e così via. Domande, queste, che
spesso neppure gli specialisti del sapere scientifico si pongono. D'altra parte
fino a ieri erano studiosi del tutto estranei al processo e ai metodi
scientifici veri e propri, che s'interessavano di 'filosofia della scienza'.
Oggi questo non avrebbe più senso, anche se molti ancora lo fanno, pensando,
ingenuamente, di poter far risorgere una 'filosofia epistemologica della
natura'.
E' vero però anche il contrario, e cioè che lo sviluppo degli studi
dell'attività cognitiva nelle varie discipline specializzate non può sostituire
l'analisi filosofica della conoscenza o dell'epistemologia, nel senso proprio
del termine. Su questo forse non tutti i ricercatori saranno d'accordo. Ad es.
lo psicologo Piaget cercò di risolvere, nell'ambito della sua 'epistemologia
genetica', alcuni problemi tradizionali della teoria della conoscenza attraverso
i soli mezzi della scienza psicologica, partendo dalla sua teoria dello sviluppo
cognitivo. Il matematico e logico americano W. Quine propose un progetto di
'epistemologia naturalizzata' che si riduce a un'analisi complessiva dei
risultati dell'informatica, della logica simbolica e della psicologia cognitiva.
Alcuni psicologi, linguisti e specialisti americani dell'intelligenza
'artificiale' discutono, in questi ultimi tempi, intorno all'idea di realizzare
una sorta di 'scienza cognitiva unificata', in grado di risolvere anche tutti i
problemi epistemologici. Un progetto, quest'ultimo, tanto ambizioso quanto
inutile, poiché i progressi nello studio dei meccanismi della conoscenza in
virtù di mezzi e metodi specializzati, lungi dal sopprimere la problematica
filosofica di studio della conoscenza, non fa che dimostrarne l'importanza e la
necessità.
Determinate premesse gnoseologiche giocano un ruolo decisivo nella
formulazione o nell'argomentazione di qualunque programma specialistico di
studio dell'attività cognitiva, ne sia lo scienziato consapevole o no. Una
particolare teoria scientifica può svilupparsi, sotto certe condizioni e fino ad
un certo punto, anche se la sua interpretazione filosofica è inadeguata. Ma
presto o tardi si giungerà a quello stadio della ricerca in cui
l'interpretazione filosofica inadeguata comincia a frenare lo sviluppo della
teoria scientifica, senza influire direttamente sul contenuto di quest'ultima.
Einstein, p.es., è stato convinto, per un certo tempo, che la sua teoria della
relatività fosse intimamente legata alla gnoseologia idealistico-soggettiva di
Mach; in seguito mutò completamente parere.
Non solo, ma i dati e i modelli teorico-scientifici si prestano spesso a
diverse interpretazioni filosofiche. Ad es. il modello ipotetico-deduttivo di
una teoria scientifica può essere sviluppato al di fuori del quadro
interpretativo logico-positivista, benché proprio in questo quadro esso sia
stato in origine formulato e perfezionato. La questione in effetti è quella di
sapere sino a che punto un determinato modello è universale, cioè in che
misura, partendo da tale modello, è possibile comprendere la struttura logica
del sapere teorico in generale. Qui le divergenze dei ricercatori non si
contano.
Sempre più infatti ci si rende conto che una qualsiasi modifica
nell'orientamento filosofico, può comportare non soltanto una diversa
interpretazione dei fatti e dei modelli teorici, ma addirittura un mutamento del
loro ruolo nella ricerca scientifica: ciò che in precedenza costituiva il nucleo
del programma di ricerca può rivelarsi in seguito del tutto privo d'importanza.
Insomma, un programma di ricerca nel campo della logica e della metodologia
delle scienze dipende dalla scelta delle premesse filosofiche, dal carattere
delle ipotesi ontologiche. In questo senso la crisi in cui è caduta la
psicologia cognitiva lo attesta abbondantemente.
Anche lo specialista americano di storia della scienza, T. Kuhn, si è accorto
che l'interpretazione dei fatti dipende dal suo modello teorico. Persino la
semplice costatazione d'una rivoluzione scientifica verificatasi in una data
disciplina e in un particolare momento (cioè la semplice descrizione di un fatto
evidente) implica in realtà una certa 'idea' sul carattere e la struttura di una
rivoluzione scientifica in generale. La stessa maniera in cui Kuhn comprende la
struttura e le forze motrici dello sviluppo di una teoria scientifica non può
essere separata dalle sue proprie idee filosofiche, soggettiviste e relativiste,
riguardo p.es. alla presunta impossibilità di applicare le nozioni di progresso
e di verità oggettiva alla storia del sapere scientifico, o alla cosiddetta
'incommensurabilità' dei diversi 'paradigmi'.
E' ormai un fatto che per gli specialisti della teoria e della storia della
scienza, la questione delle rivoluzioni scientifiche non ha un senso in sé e per
sé. Sulla base del modo in cui s'intende l'organizzazione e il funzionamento
della scienza, si avrà una certa concezione e non un'altra circa la natura di
una rivoluzione scientifica, o addirittura sulla possibilità di qualificarla
come tale. La filosofia del positivismo logico, ad es., nega il carattere logico
delle rivoluzioni scientifiche. Ecco perché è assurdo sostenere che la
concezione filosofica è una semplice sovrastruttura di fatti e generalizzazioni
ottenuti senza filosofia. Con ciò non si vuol dire che la scienza deve di nuovo
sottomettersi al diktat dell'idealismo oggettivo o soggettivo, ma semplicemente
ch'essa deve riaprire il dialogo (specie in occidente) con quelle correnti
filosofiche (fra cui il materialismo umanistico) che non solo sanno rispettare
l'autonomia delle scienze, ma che hanno anche a cuore i destini
dell'umanità.
In altre parole, ciò significa che va riprecisato il problema della verità in
generale e della verità scientifica in particolare, ovvero il problema del
rapporto dialettico fra verità assoluta e verità relativa.
L'evoluzione della conoscenza umana ha raggiunto un livello in cui, da un lato,
la soluzione dei problemi gnoseologici diventa sempre più una condizione
necessaria al progresso della scienza; e, dall'altro, il legame della teoria
filosofica della conoscenza con numerose scienze specializzate (incluse quelle
che studiano l'uomo e che organizzano la sua attività) è ormai diventata l'unica
garanzia di sopravvivenza della stessa filosofia. |
|

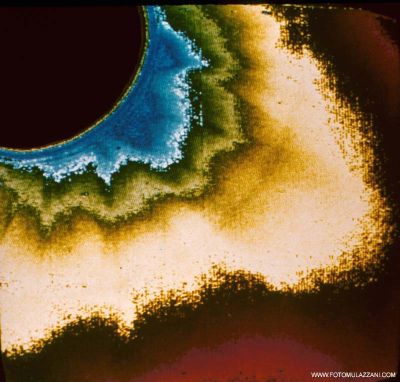
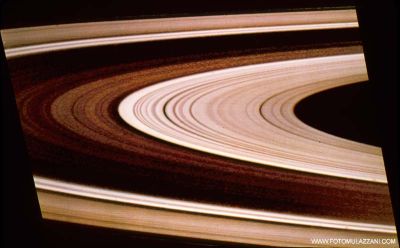











Nessun commento:
Posta un commento